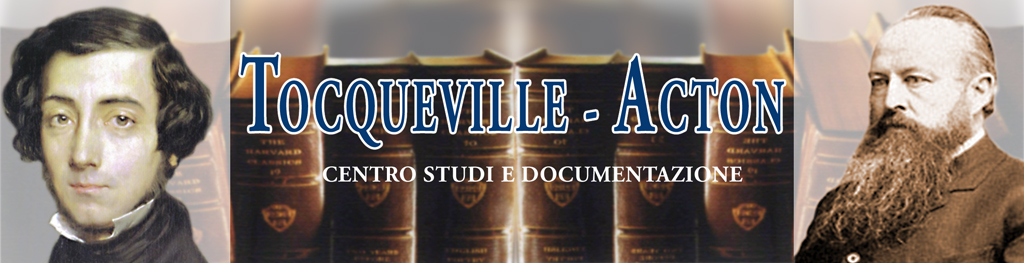
Alexis de Tocqueville
Il Pensiero
Libert� ed eguaglianza: A. de Tocqueville
di Rocco Pezzimenti
Una delle realt� pi� significative che impressionarono Tocqueville negli Stati Uniti � l�idea di progresso che avevano gli Americani molto pi� vicina a quella dei viaggiatori del XVI secolo che a quella dei philosophes e dei loro eredi che, con le loro astrazioni, avevano animato il dibattito politico francese (cf. Matteucci, I, 16). La novit� americana imponeva una nuova metodologia, ma anche discipline completamente rinnovate per analizzare una democrazia moderna pienamente attuata. Tocqueville, da aristocratico, ebbe il merito di affrontare il problema con serenit� e obiettivit� sapendo che, altrimenti, non avrebbe potuto fare opera di scienza. Esaminando la libert� come tensione morale che concretamente si sviluppa e sia attua nel concreto terreno politico, finisce per ribaltare e completare la visione di Constant sulla libert� degli antichi e dei moderni. La prima, cio� la possibilit� di partecipare direttamente e collettivamente alla formazione della volont� dello Stato, non si contrappone alla seconda, ma in essa sfocia e in essa si completa. Tutto ci� lo tiene al riparo delle pericolose utopie rousseauiane e da tutte quelle convinzioni democratiche che, se realmente realizzate, minacciano l�esistenza stessa della libert� (cf. Matteucci, I, 37).
Alexis de Tocqueville nacque nel castello di Verneuil, vicino a Parigi, nel 1805. Provenendo da una famiglia aristocratica, venne educato ad amare l�Antico regime. Ottenuta la licenza in diritto nel 1826, l�anno seguente entr� in magistratura. A seguito dei fatti del �30, chiesto e ottenuto un congedo, assieme all�amico Beaumont si rec� negli Stati Uniti per studiarvi il sistema penitenziario. Rimasto quasi due anni nel continente americano, tornato in Francia si dimise dal suo ufficio e si dedic� alla stesura della sua opera pi� famosa De la d�mocratie en Am�rique, la cui prima parte usc� nel 1835. Eletto nel �39 deputato, pubblic� l�anno seguente la seconda parte del suo studio. Rappresent� negli anni quaranta una posizione politica schiettamente liberale sino all�avvento di Luigi Napoleone a causa del quale fu anche arrestato nel 1851. Ritiratosi dalla vita politica si dedic� pienamente agli studi. Scrisse i Souvenirs, L�Ancien R�gime et la R�volution (1856), purtroppo non terminata a causa di una salute che si andava facendo sempre pi� precaria. Da ricordare pure sono i suoi Voyages. Mor� nel 1859.
Tra le novit� che lo interessarono maggiormente, durante il suo soggiorno americano, c�� l�eguaglianza delle condizioni. � quanto afferma lo stesso Tocqueville nelle prime righe della sua opera pi� famosa. Il cammino verso l�eguaglianza � ormai penetrato nell�essenza dell�uomo occidentale tanto che, come aspirazioni, cultura e persino religione � impossibile pensare di arrestarlo. Anche gli ambiti politici dell�alto clero, quelli tradizionalmente pi� conservatori, si vanno aprendo al ricco come al povero, al plebeo come al nobile, tanto che si pu� dire che, tramite la Chiesa, l�eguaglianza va penetrando in tutti gli ambiti della societ� e persino nel governo (cf. Tocqueville, DA, 4). Tutta la storia dimostra che questo processo � attivo ormai da secoli tanto che si pu� definire un fatto provvidenziale, universale e duraturo. Arrestarlo non solo significa ostacolare il cammino stesso della democrazia, ma quasi �lottare contro Dio stesso�. Compito principale dei governanti appare perci� quello di educare alla democrazia, regolarla, evidenziarne i rischi, ma anche i suoi indubbi vantaggi. Per questo si rende necessaria una scienza politica nuova capace di analizzare quei cambiamenti, che la rivoluzione democratica ha attuato nell�assetto materiale della societ�, nell�ambito delle leggi e delle istituzioni (cf. Tocqueville, DA, 6-7). � questo un compito fondamentale: una volta svanito il prestigio del potere tradizionale e il senso d�autorit�, occorre avere il coraggio di rinnovare la vita civile. Tutte le forze antiche e nuove debbono capire la grandiosit� di questo compito. Il Cristianesimo stesso, che ha reso tutti gli uomini uguali davanti a Dio, dovr� aiutarli a farli sentire tutti cittadini uguali davanti la legge. Compito non facile per nessuno e questo spiega la grande confusione che Tocqueville avverte nel dibattito politico attorno alla democrazia e alla libert�, sovente osteggiate da chi dovrebbe difenderle o, per calcolo, esaltate da chi dovrebbe, da un punto di vista logico, osteggiarle (cf. Tocqueville, DA, 13-4). Ora la cosa migliore �, a suo parere, quella di non lasciarsi trascinare dalla lotta partitica e di esaminare problemi cos� scottanti il pi� possibile lontani dalle passioni.
Per capire un fenomeno storico e politico come quello della democrazia americana bisognerebbe risalire, se fosse possibile, fino agli elementi originari e costitutivi di quella societ�, tornando all�epoca delle prime migrazioni nelle quali � gi� possibile vedere il germe delle libere istituzioni, quelle dei governi comunali e della sovranit� popolare che traversarono l�oceano al tempo della monarchia dei Tudor. Ma ancora pi� importanti sono le ragioni di carattere psicologico: gli emigrati partono dalla madre patria non sentendo nessuna prerogativa di superiorit� gli uni sugli altri, convinti che per realizzare qualcosa di buono dovevano faticare di persona e, infine, sicuri che la libert� che volevano non aveva niente di aristocratico (cf. Tocqueville, DA, 31-2). Singolare il fenomeno che porta alla formazione del popolo americano nel quale non si distinguono signori o popolo minuto, ricchi o poveri, bens� individui, posti su un piano di perfetta eguaglianza, spinti unicamente dall�esilio e dall�austerit� della vita per far trionfare il bisogno di libert�. In America si concretizzeranno, col tempo, i principi fondamentali delle costituzioni moderne: partecipazione agli affari pubblici da parte del popolo, voto non vincolato all�imposta, responsabilit� dei governanti, libert� individuali e giudizio per giuria (cf. Tocqueville, DA, 43). Ma soprattutto in America si sintetizzavano due elementi che l�Europa moderna aveva finito per mettere in contrasto: spirito di religione e spirito di libert�. La religione, liberata dalle strettezze della politica, sente di essere tanto pi� stabile quando pu� contare sulle sue solo forze. La libert� finisce cos� per vedere nella religione la compagna di tutte le sue lotte e dei suoi trionfi nonch� la fonte divina di tutti i suoi diritti (cf. Tocqueville, DA, 47-8). Questo rapporto tra religione e libert� � cruciale perch�, nelle democrazie, si finisce per amare l�eguaglianza senza misura: a tratti nei confronti della libert� si pu� anche essere rassegnati a subire sconfitte, mentre si preferisce morire pur di perdere l�eguaglianza. Lo spirito religioso rende cos� un grande servizio alla causa democratica negli Stati Uniti. Tutte le confessioni religiose sostengono le istituzioni democratiche. Gli stessi cattolici, sostiene ammirato Tocqueville, sono in continuo aumento perch� riescono a essere i fedeli pi� sottomessi e i cittadini pi� indipendenti. Va per� detto che, pur nella diversit� di religione, ogni confessione si ritrova nella grande unit� cristiana, la morale del Cristianesimo � ovunque la stessa (cf. Tocqueville, DA, 334-6).
Per capire da cosa derivi questo amore per l�eguaglianza bisogna considerare il principio della sovranit� popolare che negli Stati Uniti � un vero e proprio dogma. La sua importanza � pari alla sua efficacia in quanto non � un principio sterile o astratto, come appare in altre nazioni, ma riconosciuto dai costumi e proclamato dalle leggi. Per questo si pu� dire che la societ� americana �agisce da s� su se stessa�, possiede tutti i poteri e non � neppure in grado di concepire altro potere all�infuori di se stessa. Il popolo partecipa alla formazione delle leggi, sceglie i legislatori e provvede all�esecuzione delle leggi eleggendo i membri dell�esecutivo. La sovranit� popolare si estende nella sfera politica come Dio esercita la propria nell�universo (cf. Tocqueville, DA, 60-3). Questa sovranit� popolare parte da un�istituzione che costituisce la forza dei popoli liberi: il comune. � qui che l�individuo comincia ad abituarsi allo spirito di libert�, ne capisce il suo uso e i suoi limiti, ma impara anche a tutelarsi dai possibili abusi del dispotismo della maggioranza. Ogni cittadino pu� svolgere le diverse funzioni che esercita un comune. Esse sono retribuite e quindi consentono anche ai poveri di dedicarvi il loro tempo. Si ricordi che questo non significa che il sistema americano dia ai funzionari uno stipendio fisso. Chi esercita certe funzioni ha una sua tariffa per ogni atto del suo ufficio, perci� sono remunerati in proporzione di quanto hanno fatto. Cultura, ricchezza, origini, ecc. non distinguono quindi gli individui. Ognuno � considerato uguale agli altri e, per quanto riguarda i reciproci doveri fra cittadini, � divenuto soggetto alle leggi che regolano la societ�. Per quello che non riguarda altri che lui � libero e non deve rispondere che a Dio delle proprie azioni (cf. Tocqueville, DA, 69-70).
I comuni godono di reale autonomia, ma si sottomettono allo Stato quando entra in gioco un interesse pi� grande che condividono con altre realt�. Per garantire ancora possibilit� di partecipazione e maggiore protezione nei confronti del potere centrale si � istituita la contea con interessi puramente amministrativi. Essa costituisce il primo centro giudiziario e possiede una corte di giustizia. Gli amministratori della contea hanno poteri limitati ed eccezionali che applicano in pochissimi casi previsti e stabiliti. Tutto questo porta a dire che non c�� al mondo uno Stato in cui la legge abbia un valore cos� assoluto e nel quale, il diritto di eseguirla, sia diviso tra tante mani (cf. Tocqueville, DA, 76-8). Le funzioni pubbliche derivano comunque sempre dall�elezione. Gli individui scelgono tra di loro gli amministratori e li controllano nel territorio dove esercitano le proprie funzioni e nell�ambito delle regole esistenti. Dopo i comuni e le contee si arriva al potere legislativo dello Stato esercitato mediante un corpo legislativo diviso in due rami. Si arriv� a questa conclusione perch� il principio dell�indipendenza degli Stati trionf� nella formazione del Senato, quello della sovranit� nazionale nella composizione della Camera dei rappresentanti (cf. Tocqueville, DA, 131). Con questo gli Americani non hanno certo voluto creare un�assemblea ereditaria o aristocratica e una elettiva e quindi democratica. Anche qui � stata una necessit� di ordine pratico che ha portato a diversificare i senatori dai rappresentanti. Concedendo ai primi la possibilit� di essere nominati per pi� anni, la legge ha cercato di mantenere tra i legislatori alcuni individui gi� pratici di svolgere certe funzioni e quindi capaci di dare un positivo contributo ai nuovi eletti (cf. Tocqueville, DA, 93). Dalla base al vertice si � venuto cos� a realizzare negli Stati Uniti un decentramento che nessun altro Stato potrebbe realizzare senza gravi problemi. Gli Americani hanno per� ben capito la necessit� di un�amministrazione centrale e, contemporaneamente, hanno capito che un potere centrale, �quelque �clair�, quelque savant qu�on l�imagine, ne peut embrasser � lui seul tous les d�tails de la vie d�un grand peuple� (Tocqueville, DA, 100-1). � un problema di efficacia politica a dettare tutto ci�. Gli Americani ricavano dal decentramento una serie di vantaggi di cui non potrebbero fare a meno. Vantaggi spesso legati alla singola libert� individuale che, nessuna democrazia saprebbe garantire, senza istituzioni locali realmente funzionanti.
La maggioranza, che ovunque tende a divenire sempre pi� assoluta, in America non ha accresciuto le competenze del potere centrale. Lo ha reso onnipotente nella sua sfera, ma fuori di questa ha posto limiti precisi alla sua azione. L�esecutivo centrale, nel suo ambito, � fortissimo, ma non meno forte � in America il �legista�. Coloro che svolgono questo compito per conto del popolo sembrano, in America, essere da lui separati. Negli Stati Uniti non esiste un�aristocrazia di tipo europeo eppure, se si dovesse parlare di principio aristocratico, questo non andrebbe rintracciato in termini di ricchezza o di cultura. Sono i legisti la vera aristocrazia americana. Si tratta di un corpo diffuso che va dagli avvocati ai giudici e che costituiscono un vero contrappeso alla democrazia. Il magistrato americano, con la possibilit� di avviare un procedimento di incostituzionalit�, finisce per controllare continuamente le questioni politiche (cf. Tocqueville, DA, 308-9). I legisti si vedono poco, quindi non si temono, eppure contano molto. Il quadro si completa grazie all�istituzione del giur� che sembra affidare realmente la direzione della societ� nelle mani del popolo, ma il giur� serve soprattutto a formare nella mente di tutti i cittadini una parte delle abitudini del giudice, abitudini che aiutano il popolo a essere veramente libero. Infatti la pratica del giur� diffonde in tutti il rispetto della cosa giudicata, insegna la pratica dell�equit� e porta a non sfuggire alle proprie responsabilit�: si pu� quindi considerarlo come una scuola gratuita e sempre aperta che forma il senso civico della popolazione (cf. Tocqueville, DA, 314-5). Il mezzo pi� efficace per insegnare a tutti a governare e rendere responsabili. Doveva certo restare sorpreso l�osservatore europeo nel considerare il Presidente dell�Unione responsabile dei suoi atti, mentre la legge francese sosteneva ancora che la persona del Re fosse inviolabile.
La paura di Tocqueville era quella di vedere, in un sistema democratico, attuarsi la tirannia della maggioranza. Pericolo questo che gli Americani erano riusciti a evitare non solo per i motivi suddetti, ma anche perch� la maggioranza degli Stati Uniti si compone in realt� di cittadini, che per interesse e per aspirazione, desiderano prima di tutto il benessere della loro patria. Per questo danno vita ai partiti e, in genere, si associano (cf. Tocqueville, DA, 194). Tutto ci� determina la formazione dell�opinione pubblica americana, punto di forza della democrazia. Opinione pubblica che non conosce n� l�odio religioso e n� quello di classe, che esasperano l�Europa, e che meglio si concentra su problemi concreti cercando soluzioni possibili. L�opinione pubblica si manifesta grazie a una libert� di stampa impensabile in Europa. Tocqueville, anche in questo argomento, mostra un notevole equilibrio. Il giornalismo, la retorica e, potremmo dire, il gergo politico lo preoccupano per la loro superficialit�. Il linguaggio politico, sia scritto e sia orale, in democrazia tende a modificarsi continuamente. Si introducono nuove parole, anche quando non c�� bisogno, per il semplice desiderio di novit�, ma non sempre questo contribuisce alla chiarezza delle idee. I significati delle parole vengono raddoppiati divenendo infine dubbi. Tocqueville non esita a dire che preferirebbe la propria lingua con parole cinesi o tartare pi� che con parole francesi incerte (cf. Tocqueville, DA, 577-9). Malgrado ci� � convinto che il movimento tipico della democrazia deve necessariamente investire anche il modo di comunicare purch� non diventi un abuso e per questo finisce per accettare la libert� di stampa. Pur non provando verso di essa un completo gradimento, sostiene che l�apprezza �per i mali che essa impedisce, molto pi� che per il bene che essa fa�. D�altra parte, quando si d� a ognuno un diritto politico da esercitare, occorre riconoscergli la possibilit� di scegliere tra le diverse opinioni che agitano i suoi contemporanei. Sovranit� del popolo e libert� di stampa sono due principi correlati (cf. Tocqueville, DA, 202-4). A riprova di ci� si pu� notare come negli Stati Uniti non c�� borgata che non abbia il suo giornale. Questo svolge un ruolo fortemente aggregante e consente lo svilupparsi di un altro strumento capace di garantire la libert�: l�associazionismo. Il bisogno di associarsi � per Tocqueville un bisogno tipicamente americano. L�abitante del nuovo mondo impara appena nato che deve contare solo su se stesso e che non deve aspettarsi nessun aiuto dall�autorit� politica, tranne nei casi previsti. Per questo ci si associa per raggiungere gli scopi di sicurezza pubblica, commercio, industria, morale, religione, scopi che pi� facilmente si possono perseguire associandosi. Notevole � il sostegno dato dalla libert� di stampa all�associazionismo. Questo determina la possibilit� di riunirsi in assemblea e poi, se ci sono motivazioni politiche, i sostenitori di una stessa opinione possono nominare coloro dai quali vogliono essere rappresentati in un�assemblea centrale (cf. Tocqueville, DA, 212-4). La possibilit� di associarsi, anche per scopi politici, � illimitata negli Stati Uniti e costituisce un ulteriore baluardo contro la tirannia della maggioranza.
Molti in Europa vedono un pericolo in questa libert� di associazione, ma chi ragiona cos� � inesperto in fatto di libert�. Basti pensare che in America ci si pu� associare anche quando si � minoranza per arginare l�impero morale della maggioranza e mettere in discussione ogni argomentazione politica degli avversari. Inoltre, ci� che negli Stati Uniti concorre a moderare la violenza delle associazioni politiche, � il suffragio universale. Le associazioni sanno bene che non possono mai rappresentare la maggioranza, altrimenti non avrebbero bisogno di associarsi per cambiare le regole, perci� debbono essere capaci di rispettare avversari politici e governo che tali regole garantisce. � questo un caso in cui l�estrema democrazia previene i pericoli della democrazia (cf. Tocqueville, DA, 218-9). Uno dei lati negativi di questo modo di partecipare alle vicende politiche � che raramente emergono i personaggi pi� ragguardevoli. I ciarlatani sanno piacere alla gente e sanno essere pi� appariscenti, ma quello di saper scegliere uomini di merito � una delle capacit� che sembra mancare alle democrazie. Il popolo sembra avere scarsa benevolenza verso le classi elevate o verso le persone troppo preparate: �non teme i grandi ingegni, ma li gradisce poco�. Inoltre non � solo il popolo ad allontanare dal potere gli uomini eminenti, ma sono anche questi ad allontanarsi dalla vita politica nella quale dovrebbero scendere a troppi compromessi (cf. Tocqueville, DA, 222-4). Un�eccezione, anche su questo punto, si incontra in America, basta entrare nell�aula del Senato. Il fatto si spiega, forse, con la diversa modalit� di elezione.
La democrazia, quando consente il concreto manifestarsi delle libert� individuali, si caratterizza per la realizzazione di un crescente benessere. La libert� produce pi� beni di quanti non ne distrugga e lo stesso capita per le risorse del popolo che aumentano pi� rapidamente delle imposte. Questo capita perch� diverso � il modo di assorbire e di spendere dei governi. Mentre nelle aristocrazie il danaro giova soprattutto alla classe dirigente, la democrazia, ovviamente quella che difende e valorizza la libert�, d� poco ai governanti e molto ai governati. Una simile diversit� non si nota solo nella politica interna, ma anche in quella estera. D�altra parte, sostiene Tocqueville con una punta di aristocratico orgoglio, i popoli che hanno di pi� agito sul mondo, animati da grandi disegni, dai Romani agli Inglesi, erano diretti da un�aristocrazia (cf. Tocqueville, DA, 243 e 263). Ma il sistema democratico resta comunque da preferirsi perch�, se i suoi difetti sono chiari e visibili a tutti, le sue qualit� sembrano occulte e si scoprono solo col tempo, senza contare che il sistema democratico � sicuramente il pi� adatto a far prosperare la societ�. Inoltre in democrazia si possono avere governanti meno onesti e capaci, ma i cittadini sono pi� istruiti e attenti. Il potere, anche quello dei magistrati, pu� essere usato peggio, ma chi lo detiene lo esercita per un tempo definito e sa che pu� essere rimosso. Infine la democrazia non � detto che favorisca la prosperit� di tutti, ma almeno quella della maggioranza (cf. Tocqueville, DA, 264-7).
Occorre quindi difendere la democrazia, ma quest�ultima deve saper mantenere le sue vere prerogative. � questa una posizione che avvicina assai Tocqueville a Montesquieu. �Dopo l�idea della virt�, non ne conosco una pi� bella di quella dei diritti� tanto che queste due idee sembrano confondersi al punto che l�idea dei diritti altro non � che l�idea della virt� introdotta nel mondo politico. Come non vi sono grandi uomini senza virt�, cos� non vi sono grandi popoli senza rispetto dei diritti. Sono questi che stabiliscono il limite oltre il quale si va verso la licenza o la tirannide (cf. Tocqueville, DA, 272). Il richiamo a Montesquieu e alla virt� fa intendere un legame strettissimo che intercorre tra diritto e morale, intesa come costume, mentalit�, quella che anticamente si definiva il mos maiorum all�interno del quale si sviluppava la vita civile. Per questo in America si ha una grande idea dei diritti politici, perch� sono la ragione stessa della vita civile: occorre rispettare quelli degli altri se si vuole che si rispettino i propri. � proprio questa consapevolezza che rende attivo sia singolo sia la societ� civile di uno Stato democratico. Basta passare da uno Stato libero a uno che non lo � per passare dall�attivit� all�immobilit�, dalla prosperit� all�apatia (cf. Tocqueville, DA, 277). I governi veramente democratici lasciano fare nell�ambito delle regole e non si sentono mai onnipotenti. Il problema, sembra lasciar capire Tocqueville, � vedere se queste regole sono rispettate da tutti. Non c�� alcun dubbio che sia cos� per la popolazione che si � stabilita liberamente nel nuovo continente, ma per le altre due razze, gli indiani e i neri, si pu� dire lo stesso? Interessantissime sono le riflessioni riguardo ai rapporti che potranno intercorrere in avvenire tra i futuri abitatori del territorio degli Stati uniti (cf. Tocqueville, DA, 367 e segg.).
Il secondo libro De la d�mocratie en Am�rique, uscito nel 1840, consent� a Tocqueville di approfondire la sua riflessione, potremmo dire culturale, che pervadeva l�intera nazione americana. Il nuovo contatto con la Francia, la riflessione a distanza degli Stati Uniti e gli impegni politici sopraggiunti consentono quell�analisi comparata che fanno dell�opera non solo un classico del pensiero politico, ma un testo nel quale i motivi anche politologici finiscono per intrecciarsi con quelli sociologici, psicologici, morali al punto da renderlo una specie di �specchio enciclopedico� della situazione americana del tempo. La riflessione sullo stato culturale del tempo � assai cara al pensatore francese, anche se non sempre � stata adeguatamente analizzata. Il calo della tensione culturale � sinonimo di decadenza. Una sorte di barbarie assai pericolosa ci minaccia e non possiamo ritenere che sia lontana da noi quando esistono popoli che affievoliscono l�anelito verso il sapere e altri che lo spengono (cf. Tocqueville, DA, 557-8). Ora in America l�amore verso le arti, le scienze e la cultura in genere � sicuramente diverso da quello che mostrano i francesi, sar� pi� pragmatico e utilitaristico, ma, almeno per ora, � presente e vitale. La preoccupazione di Tocqueville � che l�aggressivit� e la rozzezza, spesso evidente nello spirito pionieristico e che giudica tutto avendo come unico metro il danaro, possa degenerare compromettendo lo sviluppo completo di un popolo che, per essere tale, deve essere armonico. Per ora, questo pragmatismo � indirizzato al bene pubblico e mostra la necessit� che gli Americani hanno gli uni degli altri, quasi sentano un continuo obbligo di aiutarsi a vicenda. Da qui nasce quel bisogno associativo che, nelle democrazie, d� luogo a quella sorta di corpi intermedi che la sola eguaglianza tenderebbe a far scomparire (cf. Tocqueville, DA, 624). � questo un mezzo, assieme al sistema federale, che consente all�individuo di non dipendere direttamente dal potere centrale.
Tocqueville aveva un modo nuovo di fare storia. Come dice Furet, present� agli europei l�America non come l�infanzia del nostro continente, ma come il nostro futuro. Intento che lo porta ad analizzare il passato avendo una spiccata sensibilit� per il presente. Il passato serve a prevedere. Da qui l�analisi serrata dei tre stati della societ� francese: accanto a una Chiesa divenuta corpo politico lontano dalla popolazione, l�analisi di una nobilt� in bilico tra monarchia e popolo e incapace di opporsi a entrambi. Infine un terzo stato che, non solo riecheggiando Siey�s, si pu� dire che crea un popolo nuovo, ma va generando una propria aristocrazia. Quale la conseguenza sul piano politico e istituzionale. Per Tocqueville ve ne � una grandissima: come la societ� aristocratica tende al governo locale, quella democratica, espressa dal terzo stato, tende all�accentramento governativo. Ci� spiega perch�, all�idea di privilegio, si and� sostituendo quella del diritto comune (cf. Furet, 173-7). Anche la Rivoluzione francese non gli appariva tanto un �evento� di rottura, bens� come un processo. Arrivando ad abolire non tanto l�aristocrazia quanto il principio aristocratico si era soppressa l�unica opportunit� di resistenza sociale allo stato centralizzato, fenomeno peraltro iniziato sin dai tempi di Richelieu. Si era cos� accelerata l�estensione dello stato centralizzato evidenziato dal predominio del potere amministrativo sulle comunit� e sulla societ� civile (cf. Furet, 28-30). Ecco perch� si pu� dire che Tocqueville non tratta un periodo, bens� un problema e cio� che la Rivoluzione � la logica continuazione dell�Ancien R�gime (cf. Furet, 33). Per questo il periodo studiato da Tocqueville � estremamente ampio e d� notevole spazio al regno di Luigi XIV, anche se si tratta in generale dello studio dell�intera societ� che precede la Rivoluzione.
Lo studio della societ� francese che arriva all�ottantanove � condotto a partire dai cahiers redatti dai tre stati che, per Tocqueville costituiscono il testamento della Francia del Settecento, l�espressione dei suoi desideri e la manifestazione delle sue volont� (cf. Tocqueville, ARR, 45). Questi cahiers de dol�ance erano i memoriali che gli elettori dei tre Ordini consegnavano ai loro rappresentanti agli Stati generali quando questi si riunivano. Ne veniva fuori un rapporto dei diversi distretti che metteva in luce le reali condizioni della nazione. Questo materiale, oltre a spiegare perch� la rivoluzione sia scoppiata �chez nous plut�t qu�ailleurs�, spiega anche perch� i francesi, malgrado in una prima fase dessero l�impressione di voler distruggere tutto, poi ripresero una parte di quello che avevano lasciato (cf. Tocqueville, ARR, 47). Emerge un quadro assai interessante di una realt� da tempo instabile dove tutti sono presi dal timore di scendere e dalla smania di salire e da quella di procacciarsi danaro. Il rapporto tra nobilt� e borghesia chiarisce assai bene questi timori e queste smanie. Il crollo dell�aristocrazia, gi� avviato da tempo, � uno dei fatti incontrovertibili della Francia moderna. Tocqueville vi assiste e lo descrive convinto della sua ineluttabilit�, ma anche dei suoi rischi. Tutto questo non in modo nostalgico tipico di chi vuole mantenere certi privilegi. Il pensatore francese � certo che tutte quelle societ� che tendono ad annientare l�aristocrazia stenteranno pi� delle altre a sfuggire a un governo assoluto anche perch�, distruggere l�aristocrazia, per una popolazione significa correre verso l�accentramento (cf. Tocqueville, ARR, 50 e 131-2). Ci� non vuol dire salvare ad ogni costo una classe che, contratta �une d�bilit� s�nile�, non ha saputo rinnovarsi e capire la novit� dei tempi, come era avvenuto in Inghilterra, vuol dire piuttosto pensare ad una rinnovata �lite capace di vivere la democrazia in modo da evitare che questa degeneri. L�aristocrazia, sconfitta dalla Rivoluzione da molto tempo non influiva pi� sulla vita politica e giuridica della Francia, ma conservava privilegi incomodi e diritti onerosi. La perdita di funzioni svolte in passato aumentava cos� il peso dei privilegi (cf. Tocqueville, ARR, 92-5).
� notevole il fatto che, per Tocqueville, i nuovi funzionari amministrativi, quasi tutti borghesi, fossero una sorta di �aristocratie de la soci�t� nouvelle� gi� viva e pronta a prendere il posto della vecchia. Attendeva soltanto la Rivoluzione, per trovare libero il posto della vecchia classe. Qui sta la forza dei nuovi burocrati convinti di aver acquisito un potere che difficilmente sarebbe stato ridimensionato. Non si dimentichi infatti che in Francia il governo tollera qualunque cosa. Si pu� discutere qualsiasi teoria o principio religioso, assalire persino i principi fondamentali sui quali riposa la societ�, mettere in discussione Dio stesso, purch� non si censuri il pi� piccolo rappresentante dello Stato, il minimo dei suoi agenti (cf. Tocqueville, ARR, 136). I borghesi hanno acquisito un nuovo peso politico che li porta a separarsi dal popolo, come un tempo l�aristocrazia tendeva a distinguersi dalla borghesia che ora gestisce l�accentramento politico della Francia. Questo per�, a ben vedere, sembra essere una delle caratteristiche antiche di tutti i governi francesi che non hanno mai imitato quegli esecutivi che dicono di volersi interessare di tutto e poi navigano nella pi� apatica sterilit�. Al contrario in Francia il governo vuol fare tutto, anche quanto � superiore alle sue forze o quanto � fuori del controllo dei privati. Per questo le nuove regole si succedono in modo repentino al punto che, persino coloro che debbono applicarle, stentano a capirle. Seppure le leggi non cambiano, a riprova del peso assunto dalla burocrazia, cambia il modo di applicarle (cf. Tocqueville, ARR, 168-9 e 138-9). Cos� facendo si va verso una vera e propria statolatria. Il governo �ayant pris ainsi la place de la Providence, il est naturel que chacun l�invoque dans ses n�cessit�s particuli�res� (Tocqueville, ARR, 144). Questa forma di accentramento era iniziata da molto tempo gi� nell�antico regime quando si erano pian piano eliminate tutte le forme di autonomia municipale. Tutto ci� spiega anche perch� la passione dei francesi per gli �impieghi� sia sorta ben prima della Rivoluzione e sia andata sempre aumentando con l�accrescere del prestigio e della forza, che da tali impieghi, derivava (cf. Tocqueville, ARR, 170).
Gi� nell�analisi degli Stati Uniti, Tocqueville aveva puntualizzato l�importanza, sia pur indiretta, della religione anche se tutto ci� lo portava a valorizzare la netta separazione della Chiesa dallo Stato. Altrettanto importanti sono le considerazione svolte sulla Chiesa francese attorno alla quale circolavano, come circolano ancora, una serie di luoghi comuni. Tocqueville non nega che la cultura del XVIII secolo sia irreligiosa, vuole per� evidenziare che il cristianesimo aveva suscitato una serie di critiche non tanto come dottrina religiosa, bens� come istituzione politica. I preti erano accusati non tanto perch� pretendevano di regolare le cose dell�altro mondo, ma perch� volevano essere amministratori e proprietari in questo. Ci� spiega perch� si � vista �graduellement la puissance de l��glise se relever dans les esprits et s�y raffermir� mano a mano che il clero si mette da parte da tutto ci� che riguarda compromessi e ricchezze terrene. Questo non � un fenomeno soltanto francese in quanto non v�� chiesa cristiana in Europa che non si rifiorita dopo la Rivoluzione. Per Tocqueville questo non deve sorprendere perch� non c�� niente nel cristianesimo e nel cattolicesimo che sia contrario alla democrazia per cui �est commettre une grande erreur� credere che le societ� democratiche siano naturalmente ostili alla religione (cf. Tocqueville, ARR, 63-4). Di notevole valore sono anche le considerazioni fatte sul clero che, con pi� forza di altri, sostiene il diritto della nazione a formulare leggi e a votare liberamente le imposte; sostiene che nessuno deve pagare una tassa se non � stata voluta da lui stesso o da un suo rappresentante; reclama la libera elezione degli Stati Generali e la loro convocazione annuale e vuole che in ogni provincia siano create assemblee dei tre Stati per garantire, come avveniva negli antichi municipi cittadini, un reale decentramento. Malgrado i difetti personali, al momento della crisi rivoluzionaria, il clero era fornito di virt� pubbliche e di autentico spirito di fede, come mostrarono poi le persecuzioni sopportate. Tocqueville non ha paura di ammettere di aver cominciato a studiare l�antica societ� �plein de pr�jug�s contre lui; je l�ai finie, plein de respect�. Basti pensare che la sola persona ben educata e con un poco di cultura che rest� a contatto, in tutti i sensi, con le masse contadine non fu il filosofo, ma il curato (cf. Tocqueville, ARR, 198 e 210). � curioso poi che Tocqueville, quando parla di alcune propriet� del clero, finisca per fare riflessioni assai vicine a quelle di Balmes.
Il fenomeno religioso va visto in rapporto agli aspetti concreti. Concretezza che, non sempre, � stata la spinta dei rivoluzionari i quali, a volte, hanno considerato �le citoyen d�une fa�on abstraite, en dehors de toutes les soci�t�s particuli�res� (Tocqueville, ARR, 71). Astrazione che prima o poi genera delusione e incredulit�. Questo sembra essere uno dei mali nati col mondo moderno quando, a seguito delle critiche alla religione ufficiale che spinse non pochi spiriti fuori del cristianesimo, pian piano �� l�h�r�sie avait succ�d� l�incr�dulit�� (Tocqueville, ARR, 243). Fu quell�astrattezza, dalla quale derivava quel bisogno spasmodico di creare una sorta di paradiso in terra, che port� molti ad attaccare quasi con furore la religione cristiana in modo qualche volta fanatico e con autentico spirito di propaganda. � vero che allora la Chiesa era, anche sul piano politico, il primo dei poteri e, perci�, il pi� detestato, malgrado non fosse il pi� oppressivo, ma � anche vero che ci si accan� contro di essa perch� ancora non si era compreso di rendere il fenomeno religioso, come negli Stati Uniti, distinto da quello religioso. Purtroppo in Francia, ma in genere in Europa, si era ben lontani da quella conquista, frutto della Rivoluzione, che port� la distinzione tra le istituzioni della Chiesa e dello Stato impedendo soprattutto che le prime servissero come fondamento e modello per le seconde (cf. Tocqueville, ARR, 243-5). L�ostilit� nei confronti del potere ecclesiastico si spiega col fatto che esso controllava e censurava tutti i movimenti di pensiero dall�alto della sua autorit� morale. Per questo la Chiesa andava combattuta e anche per questo l�autorit� civile si sent�, in alcuni momenti, investita quasi a sostituirla. Ma, una volta indebolita nei suoi aspetti temporali, riprese quel vigore e quell�importanza che le riconoscevano le popolazioni americane. Prima la nobilt� � poi la borghesia, per motivi diversi e a seconda gli esiti della Rivoluzione, si riconvertirono e si riaccostarono alla fede (cf. Tocqueville, ARR, 246-9).
L�astrazione era una delle caratteristiche di una parte della cultura francese del tempo che, ad esempio, quando parlava di eguaglianza non sempre era in grado di vederla nella giusta luce. Secondo Tocqueville la Francia, ancor prima della Rivoluzione, era il paese nel quale gli uomini erano divenuti pi� eguali fra loro (cf. il cap. VIII del II Libro). Certo, si trattava di apportare una serie di correttivi per rendere l�eguaglianza pi� effettiva, per� senza cedere alle lusinghe di nessun tipo di utopismo altrimenti si poteva correre il rischio di imitare alcuni di quei filosofi che, pur intuendo la necessit� della Rivoluzione, non avevano nessuna idea dei pericoli che essa avrebbe potuto determinare (cf. Tocqueville, ARR, 232). Perch� la vita politica francese fu spinta da intellettuali sovente astratti pi� che da uomini concreti capaci di guidare non soltanto gli affari pubblici, ma anche le opinioni e il dibattito politico? Il motivo sta nel fatto che l�accentramento politico, da tempo in atto nella Francia, aveva fatto perdere ai francesi la capacit� di occuparsi journellement dell�amministrazione e dei fatti concreti e, per questo, si lasciarono facilmente infiammare dalle idee degli scrittori (cf. Tocqueville, ARR, 233-4). Malgrado i molti aspetti positivi della Rivoluzione, quando la si studia ci si accorge che fu condotta �dans le m�me esprit qui a fait �crire tant de livres abstraits sur le gouvernement�, lo stesso disprezzo dei fatti reali bilanciato da una estrema fiducia nella teoria, lo stesso desiderio di rifare la costituzione �au lieu de chercher � l�amender dans ses parties�. Una vera e propria mentalit�, diremmo oggi, costruttivista che contagi� anche il linguaggio politico ricco di espressioni generiche e di architetture ambiziose e inattuabili (cf. Tocqueville, ARR, 240).
Per Tocqueville la societ� francese del XVIII secolo si crea gradualmente nuovi portavoce: i philosophes e i letterati. La letteratura assume una funzione politica e gli scrittori diventano una forza politica, forse la pi� importante. Gli scrittori tendono a sostituire al fatto il diritto, il calcolo degli interessi alla valutazione dei mezzi, finalit� e valori al potere e all�azione. Quale il risultato? Semplice: privati del concreto e delle vere libert�, i francesi si rivolgono alla libert� astratta. Da qui quell�illusione della politica di cui parler� Marx (cf. Furet, 57-9). Inoltre per Tocqueville, e basterebbe leggere le pagine relative alla situazione contadina, la societ� francese del XVIII secolo � fortemente disintegrata dall�accentramento monarchico e dallo sviluppo dell�individualismo: la Rivoluzione si presenta perci� come un notevole processo di integrazione socio-culturale (cf. Furet, 134-5). Disintegrazione che colpisce anche le singole classi: la stessa nobilt�, uscir� sconfitta, perch� non presenta alcuna omogeneit� sociale o economica. A proposito della situazione contadina, Tocqueville evidenzia un particolare paradosso. Il contadino della fine del Settecento � gi�, per tanti aspetti, quello del XIX secolo, cio� un proprietario terriero indipendente dal suo signore. Ci� accadeva per circa i tre quarti delle campagne ancor prima della Rivoluzione. Questo rendeva ancora pi� insopportabile la residua feudalit� che ancora interessava parte del territorio e spiega perch� l�amministrazione dell�Antico Regine fosse cos� diversa ed eterogenea (cf. Furet, 185-6 e cf. Tocqueville, ARR, cap. I del lib. II).
Questa difficile situazione rende necessaria una seria riflessione su quello che lo stesso linguaggio politico cerca di descrivere. �Ci� che crea nello spirito la peggior confusione � l�uso fatto delle parole democrazia, istituzioni democratiche, governo democratico. Finch� non arriveremo a definirle chiaramente e a interderci sulla definizione, vivremo in un�inestricabile confusione di idee, a tutto vantaggio dei demagoghi e dei despoti (...) Ma le parole democrazia, monarchia, governo democratico possono significare una sola cosa, secondo il vero senso delle parole: un governo in cui il popolo partecipa pi� o meno largamente al governo. Il suo significato � intimamente legato all�idea di libert� politica� (cf. Furet, 191-2, che cita Tocqueville). Parole queste che presentano una grande novit�, come giustamente ritiene Furet, in quanto la democrazia non � pi� solo esaminata sul piano sociale in base al criterio dell�eguaglianza, ma sul piano politico in base alla libert� e alla partecipazione della gestione del potere. La trasformazione democratica � infatti stata resa possibile dall�incapacit� delle classi superiori di conservare il potere o di generarne uno nuovo (cf. Furet, 192-3). Ci� che risulta chiaro nel Tocqueville anziano � che l�accentramento ha favorito lo sviluppo e la diffusione della mentalit�, ma anche del costume democratici. Questa lucida constatazione rende l�autore dell�Ancien R�gime molto meno ottimista di quello della Democrazia in America. Si pu� anzi parlare di pessimismo perch� (e non credo di forzare troppo la lettura di Tocqueville che in questo sembra sulla stessa lunghezza d�onda di Rosmini, che pure aveva percorso un diverso itinerario) il totale annullamento di freni incammina la democrazia verso un processo di astrazione che pu� anche finire per imboccare itinerari utopici o rivoluzionari in modo assurdo e pericoloso.
I pericoli della degenerazione democratica sono presenti in un famoso Discours prononc� � l�Assembl�e constituante dans la discussion du projet de contitution (12 septembre 1848) sur la question du droit au travail. Si tratta di un testo inteso e frainteso in vari modi, ma che forse andrebbe letto in un contesto nel quale il socialismo, al quale il pensatore francese si oppone, non ha ancora assunto quelle caratteristiche socialdemocratiche con tinte addirittura liberali che oggi conosciamo e, per questo, � molto vicino a una concezione statalistica che ignora troppo la sfera dell�individuo. Nelle parole del discorso si avverte la preoccupazione per uno Stato sempre pi� invadente che diventa alla fine il solo proprietario di tutto e unico arbitro dei salari, della produzione e dell�organizzazione del lavoro (cf. Tocqueville, D, 1140). Ma c�� di pi�. In primo luogo la preoccupazione che tutte le scuole socialiste, cos� come si erano evidenziate fino ad allora, insistono solo sulle passioni materiali dell�uomo. In secondo luogo attaccano i presupposti stessi della propriet� individuale. Infine manifestano una forma di disprezzo per l�individuo preso in se stesso cercando in tutti i modi di ridurre, mutilare e intralciare la libert� umana. Lo Stato vuole essere il precettore di tutti come di ognuno e finisce per esprimere quasi una nuova forma di schiavit� (cf. Tocqueville, D, 1142-3). Cos� facendo si venivano a mettere in discussione persino gli aspetti gloriosi della Rivoluzione come la libert� e la propriet� venendo a determinare una forma di sudditanza ben pi� pericolosa di quella che esisteva nell�Antico Regime. Riprendendo un principio, che ho gi� evidenziato nel precedente volume, Tocqueville mette in guarda dall�antica mania, intuita da Robespierre, di voler governare troppo e, anticipando Owen, avverte che quella voluta dal socialismo statalista sarebbe una societ� di animali. In alcune conclusioni di questo Discorso, parte della critica ha voluto vedere nel pensatore francese una mentalit� aristocratica e liberale. Ma, nell�intento di difendere quella democrazia che aveva tanto esaltato, Tocqueville in poche righe respinge questa accusa. La democrazia e il socialismo sembrano avere in comune solo l�amore per l�eguaglianza, ma la democrazia la vuole nella libert�, mentre il socialismo, quel socialismo, la vuole nelle strettezze e nella schiavit� (cf. Tocqueville, D, 1145-7).
TESTI RILEVANTI
Acton J. E. D., History of Freedom and other Essays, London, 1907.
Acton J. E. D., The Influence of America, in Essays in the Liberal Interpretation of History; selected Papers, con una introduzione di W. H. McNeill, Classical European Historians, Chicago, 1967.
Acton J. E. D., Essays on Freedom and Power, New York, 1955.
D�Addio M. e Negri G., (a cura di) Introduzione a Il Federalista, il Mulino, Bologna, 1980.
Fasnacht G. E., Acton�s Political Philosophy: an Analysis, Hollis and Carter, London, 1952.
Fasnacht G. E., Freedom and Socialism, in Lord Acton on Nationality and Socialism, London, 1949.
Furet F., Penser la R�volution fran�aise, �ditions Gallimard, Paris, 1978.
Gasquet A. F., Lord Acton and his Circle (Letters of Lord Acton), ed. by Abbot Gasquet, George Allen, Burns & Oates, London, 1906.
Himmelfarb G., Introduction a J. S. Mill, On Liberty, London, 1985.
Kochan L., Acton on History, A. Deutsch, London, 1954.
Mathew D., Acton. The Formative Years, London, 1946.
Matteucci N., Introduzione a Alexis de Tocqueville, Scritti politici, vol. I, UTET, Torino, 1969.
Tocqueville A. de, La d�mocratie en Am�rique I (1835), II (1840), in �uvres, vol. II, �ditions Gallimard, Paris, 1992.
Tocqueville A. de, L�ancien r�gime et la R�volution, �ditions Gallimard, Paris, 1996.
Tocqueville A. de, Discours prononc� � l�Assembl�e constituante dans la discussion du projet de contitution (12 septembre 1848) sur la question du droit au travail, in �uvres, vol. I, �ditions Gallimard, Paris, 1991.
L�indipendenza dei giudici nel pensiero di Alexis de Tocqueville
di Tito Lucrezio Rizzo
Il continuo accendersi dei dibattici politici e dottrinali nel nostro Paese in merito al ruolo della Magistratura , alla separazione della carriera del giudice da quella del Pubblico Ministero, alla necessit� di ristabilire gli equilibri costituzionalmente sanciti fra i tradizionali poteri dello Stato (il Legislativo, l� Esecutivo ed il Giudiziario), rende vieppi� interessante il pensiero di Tocqueville a quasi due secoli di distanza dai suoi scritti.
E� doveroso premettere che gli Stati Uniti d�America, sui quali egli scrisse la pi� vasta e lucida opera mai realizzata da un europeo sul Nuovo Mondo, sin dal loro costituirsi furono un Paese di common law , cio� un Paese nel quale a differenza di quelli continentali europei di derivazione romanistica, la principale fonte del diritto era (ed � tuttora) costituita dalle sentenze dei giudici. Le riflessioni dell�A., giustamente considerato uno dei padri del liberalismo moderno, non possono pertanto essere oggetto di acritiche e fuorvianti trasposizioni in un ambito come quello italiano, che ha conosciuto delle vicende storico-giuridiche assai diverse e che � l�erede principale della tradizione del jus scriptum, esaltante la centralit� del ruolo della legge.
Nondimeno, dopo aver preso atto delle differenze sostanziali esistenti fra i due sistemi, il primo basato sul preminente potere normativo del magistrato, che opera secondo la regola dello stare decisis [1], il secondo sull�esclusivo potere normativo del Parlamento, riteniamo quanto mai utile una rilettura dei tratti essenziali del pensiero dello studioso francese, poich� � dato evincerne delle linee-guida universali, che trascendono il sistema di riferimento e riguardano l�idea stessa di democrazia, al di fuori di ogni vincolo di spazio e di tempo.
Tornando alla realt� italiana, il problema del rapporto tra giurisdizione e legislazione � tutt�altro che recente. Negli anni �70 del secolo appena trascorso si era manifestato il fenomeno di alcuni giudici politicizzati, che miravano a porsi loro stessi come legislatori, in spreto alle competenze predeterminate della Costituzione.
Giovanni Cassandro, giudice costituzionale e gi� segretario del P.L.I. nel dopoguerra, critic� tale tendenza esaltando l�apoliticit� della funzione giurisdizionale, senza la quale sarebbe venuta meno la certezza del diritto, l�eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge e la loro libert�. Allorch� i magistrati applicavano la norma astratta al caso concreto- notava l�insigne giurista,-creavano indubbiamente un quid novi, che per� sorgeva ex vinculis dal corpo precostituito delle norme e, pertanto, non era condivisibile l�operato di quei giudici i quali pensavano che �la giustizia deve essere amministrata non applicando la legge e servendo la legge, ma piegando la legge (attraverso l�interpretazione) a strumento eversivo di un ordinamento che non realizza o non realizza ancora l�ideologia che i giudici prediligono., difendono, propagano, e intendono addirittura attuare con le loro sentenze�.[2]
Andando pi� a ritroso nel tempo, il Cassandro ricordava che la liceit� del disapplicare la legge da parte dei giudici, problema ricorrente nella storia del diritto nei momenti di crisi dell�autorit� centrale, era stata discussa gi� nel sec. XII d.C. nell� Universit� di Bologna, dove si erano contrapposte le tesi dei glossatori Bulgaro e Martino.
Il primo era fautore della supremazia dell�osservanza dello strictum jus, il secondo della aequitas di cui il singolo magistrato poteva farsi direttamente interprete; ma fin� con il prevalere la tesi di Bulgaro, in virt� della quale solo il legislatore poteva recepire l�equit� e tradurla in dei precetti positivi.
Vero �, per converso, che nell�et� medievale i giudici, anche quelli di nomina regia, erano di fatto dotati di un� autonomia oggi impensabile, data la mole delle fonti del diritto (costituzioni imperiali, leggi feudali, statuti comunali, diritto canonico, diritto comune, consuetudini, etc.) innanzi alla quale la loro �interpretazione� sovente era determinante nell�individuare ed adattare la norma al caso concreto loro rappresentato.
Dunque lo strictum jus di bulgariana memoria, era come un�odierna autostrada - se ci � consentito il paragone- dove il giudice-pilota poteva scegliere la corsia , ma non inventarsi il percorso; mentre l� attuale nostro magistrato � vincolato a camminare nell� unica corsia consentita dalla Costituzione,che � quella della legge ordinaria.
Avvicinandoci a grandi passi al periodo di Tocqueville, ricordiamo che nel sec. XVIII gli illuministi, fautori della divisione dei poteri e della chiarezza delle leggi, erano stati fermamente avversi ad un� attivit� del giudice che, in ossequio all�equit�, si fosse spinto a lenire quello che ritenevano dovesse essere il giusto rigore della legge: ci� si sarebbe risolto in un nuovo arbitrio, che avrebbe vanificato il loro impegno per l�invocata certezza del diritto.
In quel periodo nell�Europa continentale erano state effettuate delle raccolte normative, per ribadire la prevalenza della legge sull�attivit� interpretativa dei magistrati e per tentare di porre fine al particolarismo giuridico, con la riaffermazione dell�unicit� della fonte di produzione ,riferibile ovunque al monarca, a vantaggio della chiarezza, dell� auspicata coerenza e della generale vigenza del sistema legislativo ( p. es le .Costituzioni di Vittorio Amedeo II re di Sardegna del 1729; il Codex Theresianus di Maria Teresa d�Austria del 1766 etc.)
Occorre per� arrivare alla fine del sec XVIII, con le Rivoluzioni americana e francese, perch� vedessero la luce le prime codificazioni costituzionali in senso moderno, cio� non meramente antologico- compilative come quelle appena citate, bens� innovative ed organiche, in quanto dotate di un �intima armonia interna.
Queste ultime posero fine nelle varie nazioni all�era del c.d. jus commune, vale a dire del diritto romano giustinianeo riscoperto nel sec. XII da Irnerio alla Scuola di Bologna, da dove si sarebbe irradiato.come la �scienza del diritto� per eccellenza ovunque in Europa.
Tale scienza avrebbe finito per dominare la storia giuridica del nostro continente, fino alle menzionate codificazioni, mantenendo comunque anche dopo la loro entrata in vigore, una sua linfa vitale di sopravvivenza quale diritto della ragione, grazie alla razionalit� ad esso intrinseca. Cos� ,pi� o meno inconsapevolmente, proprio attraverso il mondo del diritto si venne a configurare l�unit� ideale della Europa.[3]
Lo spirito liberale che la Restaurazione post-napoleonica non era riuscito a soffocare, pass� dall�originaria matrice individualistica circoscritta alla mera protezione del singolo agire da interferenze esterne, a nuovi obiettivi di coinvolgimento sociale..
Ne deriv� la partecipazione del singolo, tramite la rappresentanza parlamentare, al processo di decisione della legge, che lo rese compartecipe del potere sovrano cui spontaneamente si sottometteva.[4]
In tal modo venne a maturazione quel sincretismo tra liberalismo e democrazia, che nella comune istanza per l�introduzione del suffragio universale, fu il tramite per la promozione di un� ascesa dell�individuo inserita nella pi� ampia cornice del progresso generale dell�intera sua comunit� di appartenenza[5].
Onde evitare tuttavia che la democrazia fagocitasse il liberalismo, cio� che la mera logica dei numeri potesse prendere il sopravvento sull�individuo, occorrevano degli antidoti a tutela delle minoranze: questo problema fu centrale nel pensiero e nell�opera di Alexis de Tocqueville[6]. Egli vide chiaramente che la mobilit� delle classi sociali era una forza positiva che poteva scongiurare tendenze involutive ,al pari della nascita di tante associazioni intermedie fra lo Stato ed il cittadino,cio� di quella pluralit� ordinamentale che in Italia avrebbe avuto in seguito un sostenitore appassionato in Santi Romano. Non a caso l�attenzione di Tocqueville si era soffermata con particolare enfasi su quella realt� di base di origine medioevale che era rappresentata dal Comune, la cui genesi era a lui ben nota, in ragione della sua formazione storico-giuridica.
Nel nuovo Mondo tale realt� si era configurata da subito come la struttura organizzativa fondamentale, il che fu puntualmente rilevato dal pensatore francese, che cos� annot�: �nel Comune, come dappertutto, il popolo � la fonte dei poteri sociali, ma in nessun luogo esercita la sua funzione cos� direttamente� Il corpo degli elettori, dopo aver nominato i magistrati, li dirige lui stesso in tutto ci� che non � pura esecuzione delle leggi dello Stato�[7].
Questa riflessione dell�A. sulla positivit� di un sistema elettivo delle magistrature locali, con gli inevitabili condizionamenti legati alle maggioranze che le avevano votate, non � in contrasto � come vedremo � con il suo fermo sostegno all�autonomia di quelle federali, riconducibile alla diversa logica della necessaria unitariet� dello Stato centrale, di cui le seconde erano espressive.
L�America dunque gli apparve l�organizzazione statuale ideale, nella quale gli individui da soli, o nelle agglomerazioni intermedie, potevano liberamente decidere del loro futuro prima di qualsiasi intervento da parte del potere centrale: ecco allora il decentramento amministrativo, l�esercito federale, il sistema radicato delle libert� civili e politiche,e cos� via.
Prendendo nettamente le distanze da molti suoi connazionali, esponenti di un liberalismo con forti venature anticlericali, Tocqueville sostenne che innanzi alla modernizzazione, di fronte a delle masse assetate solo di maggior benessere, occorreva recuperare lo spirito della religione, per scongiurare la tentazione di un �dispotismo paterno� volto ad addormentare le coscienze dei cittadini, attraverso il soddisfacimento delle loro sole istanze materiali.
L�A. pertanto fu fautore di un incontro non soltanto tra il liberalismo e la democrazia, ma anche tra il primo e la religione, per armonizzare le giuste aspirazioni di crescita economica di una collettivit�, con le superiori esigenze dell�innalzamento spirituale della stessa[8].
L�opera pi� importante di Tocqueville, La democrazia in America, fu pubblicata in due parti, nel 1835 e nel 1840 e venne ristampata per ben 12 volte, segnando per il pensiero liberale la svolta significativa test� ricordata[9], riguardo alla quale meritano una particolare attenzione le osservazioni sul potere giudiziario.
Giunto Oltreoceano, Tocqueville rilev� che quel che riusciva pi� difficile da comprendersi per uno straniero, era proprio l�assetto di tale potere, al cui riguardo testualmente osserv�: �Non vi � avvenimento politico in cui non si intenda invocare l�autorit� del giudice�[10].
Negli Stati Uniti, come in Europa, il giudice operava solo previo esperimento di un�azione processuale e si occupava soltanto del singolo caso sottopostogli.
Tuttavia aveva dei poteri ben pi� ampi rispetto a quelli dei colleghi europei, poich� � proseguiva l�A. � �gli americani hanno riconosciuto ai giudici il diritto di fondare le loro sentenze sulla Costituzione, piuttosto che sulle leggi. In altri termini, hanno loro permesso di non applicare quelle leggi che ritengono incostituzionali�.
In America la Costituzione non era ritenuta immutabile come in Francia, ma non poteva tuttavia neanche essere modificata dai poteri ordinari come in Inghilterra, dal momento che occorrevano delle procedure lunghe e complesse nell�ambito di forme prestabilite.
Allora come oggi, la Costituzione era garantita dalle Corti di Giustizia, in grado anche di paralizzare le leggi ordinarie che fossero state ritenute in contrasto con la Costituzione medesima..
Dette Corti, e quella Suprema pi� di ogni altra, erano dotate di poteri tali che qualcuno aveva definito enfaticamente quello degli Stati Uniti, come un �Governo dei Giudici�[11].
Il cittadino americano dunque, che si fosse ritenuto vulnerato da una determinata legge, sapeva di poter ricorrere alla via processuale per evitarne gli effetti, con la conseguenza che innanzi al moltiplicarsi del contenzioso giudiziario, la legge impugnata finiva con il perdere l�efficacia sua propria. Pertanto � proseguiva l�A. � o il popolo cambiava la Costituzione, grazie alla quale la legge era disattesa con giurisprudenza costante, oppure il Parlamento modificava la legge stessa.
�Racchiuso nei suoi limiti � osservava conseguentemente Tocqueville � il potere accordato ai Tribunali americani di pronunciarsi sull�incostituzionalit� di una legge, forma ancora una delle pi� forti barriere che siano mai state elevate contro la tirannide delle Assemblee politiche�[12].
Pi� simile alle tradizioni europee era la procedura per la messa in stato di accusa dei funzionari pubblici, Presidente degli U.S.A. incluso, comprendente la contestazione degli addebiti effettuata preliminarmente dalla Camera dei Rappresentanti, ed il successivo giudizio che veniva formulato dal Senato. Quest�ultimo-allora come oggi-poteva pronunziare la rimozione (p. es. del Presidente stesso, nel caso di accusa di alto tradimento), intervenuta la quale il funzionario allontanato, tornava ad essere un cittadino comune, soggetto in quanto tale alla giurisdizione della Magistratura ordinaria[13].
Riguardo a ci� Tocqueville cos� osservava: �lo scopo principale del giudizio politico negli Stati Uniti � dunque quello di togliere il potere a chi ne ha fatto cattivo uso, ed impedire che questa stessa persona ne possa per l�avvenire essere rivestita�.
In tal modo si era venuto a creare un sistema misto, che dava alla destituzione amministrativa tutte le garanzie del giudizio politico e, per converso ,toglieva �al giudizio politico il suo pi� forte rigore�.
Viceversa nel Vecchio Continente i corpi politici eccezionalmente chiamati a funzioni giudicanti (p. es. la Camera dei Pari francese per la messa in stato di accusa dei Ministri), emettevano essi stessi direttamente la sentenza contro il convenuto in giudizio.
I reati per i quali in genere i funzionari pubblici potevano essere sottoposti ad un giudizio politico, erano quelli di una generica �condotta colpevole�, o quello parimenti genericamente definito, di �cattiva amministrazione�[14]; mentre per il Capo dello Stato erano contemplati quelli di �alto tradimento, corruzione o altri grandi crimini o delitti�.
Tocqueville nonostante ci� concludeva che �gli americani, impedendo ai Tribunali politici di pronunziare pene giudiziarie, abbiano prevenuto le conseguenze pi� terribili della tirannide legislativa, ma non la tirannide stessa[15]. Ed io non so- soggiungeva -se nel suo complesso il giudizio politico come lo si concepisce negli Stati Uniti, non sia l�arma pi� formidabile che mai sia stata messa nelle mani della maggioranza�.
Proprio in ragione della struttura federale del proprio Stato, il governo americano doveva poter contare pi� di ogni altro sull�appoggio della giustizia, poich� il federalismo lo rendeva naturalmente pi� debole innanzi ad eventuali conflitti con la periferia.
L�unitariet� della giurisdizione si esprimeva a livello di vertice nella �Suprema Corte degli Stati Uniti�, competente a decidere sulle questioni di interesse generale, sui conflitti di attribuzione fra le Corti dei singoli Stati dell�Unione, sulle controversie fra questi ultimi, o tra privati cittadini appartenenti a differenti territori statuali, o ancor sulle cause intentate da particolari categorie di soggetti (p. es. gli Ambasciatori).
La Suprema Corte era inoltre preposta a decidere le controversie in tema di commercio marittimo interno, di diritto internazionale ed in tutto quanto era disciplinato dalla Costituzione federale (p. es. i dazi, la monetazione, etc�).
Del pari deliberava su cause dovute a norme indebitamente varate dai singoli Stati membri in contrasto con la Costituzione; mentre per le cause minori operavano le giurisdizioni inferiori[16].
Tocqueville acutamente osservava che l�Unione, cos� come era stata costituita dal 1789, aveva s� una sovranit� ristretta, ma che in compenso era stato sancito che nel suo ambito esisteva un solo, unico popolo[17]. In conseguenza di ci� la giurisdizione dei singoli Tribunali locali era destinata ad ampliarsi o a restringersi, specularmente alle variazioni in pi� o in meno di quella, di ben altro spessore, esercitata dalla Suprema Corte, posta al vertice di un potere giudiziario che- rilevava l�A.[18]- non aveva mai avuto una similare forza presso nessun popolo.
I membri della Suprema Corte venivano nominati dal Presidente degli Stati Uniti, sentito il Senato: la loro indipendenza dagli altri poteri era altres� garantita dalla loro inamovibilit� vita natural durante, e dal fatto che il loro stipendio, una volta determinato, non era assoggettabile al controllo parlamentare.
�Nelle mani dei sette giudici federali- commentava perci� Tocqueville- stanno la pace, la prosperit�, l�esistenza stessa dell�Unione. Senza di loro la Costituzione sarebbe lettera morta; a loro si appella il Potere esecutivo per difendersi dalle usurpazioni del Corpo legislativo, e questo per difendersi dagli atti dell�Esecutivo; l�Unione per farsi obbedire dagli Stati; gli Stati per respingere le pretese esagerate dell�Unione; l�interesse pubblico contro l�interesse privato; lo spirito di conservazione contro l�instabilit� democratica. Il potere di questi giudici � illimitato, ma � un potere morale. Essi sono onnipotenti finch� il popolo accetta di obbedire alla legge; non possono nulla quando la disprezza[19].
Tocqueville avanz� nella sua analisi fino a sostenere che persino gli eventuali errori del Presidente o del Congresso, non sarebbero stati pericolosi per l�Unione quanto quelli commessi dai supremi giudici federali, in quanto � scrisse �� se la Corte Suprema venisse mai ad essere composta da uomini imprudenti o corrotti, la Confederazione dovrebbe temere l�anarchia o la guerra civile . I giudici federali non debbono dunque soltanto essere buoni cittadini, uomini istruiti e probi, qualit� necessarie ad ogni magistrato; bisogna anche che siano uomini di Stato; � necessario che sappiano discernere lo spirito del loro tempo, affrontare gli ostacoli che si possono vincere, ed uscire dalla corrente quando il flutto minaccia di trascinare con loro la sovranit� dell�Unione e l�obbedienza dovuta alle sue leggi�
Ovunque negli Stati costituzionali europei il massimo della sovranit� era nelle mani del Legislativo, cui erano subordinati l�Esecutivo ed il Giudiziario, con il rischio che ne derivava � ad avviso di Tocqueville � di un dispotismo della maggioranza[20].
Diversamente, negli U.S.A., il potere sovrano era articolato-lo si � visto- su di una base federale saldamente legata tramite un sistema giurisdizionale di tipo piramidale.
Alla base operavano (ed operano ancora oggi) dei magistrati eletti per un periodo di tempo limitato e con delle retribuzioni stabilite dal Potere legislativo, cui erano conseguentemente assoggettati.
Sia in materia civile che in quella penale, accanto ai giudici �togati� intervenivano nei tribunali dei giurati popolari, in un�articolazione mista i cui vantaggi erano quanto mai evidenti nella prima, dove i giudici con l�apporto della loro competenza tecnica e della loro scienza potevano orientare quelli di estrazione popolare, ignari del diritto[21].
In campo penale, viceversa, dove l�analisi dei fatti era pi� importante della puntuale conoscenza delle norme da applicare, Tocqueville osservava che entrambe le categorie di giudici erano in grado di esprimere le loro valutazioni, con la stessa profondit� di giudizio[22].
A corollario della sua analisi cos� concludeva: �con l�aiuto della giuria civile, la Magistratura americana ha introdotto ci� che io chiamo lo spirito della legge, fin nelle ultime classi sociali. Cos� la giuria, che � il mezzo pi� potente per far governare il popolo, si dimostra il mezzo pi� efficace per insegnargli a governare�.
All�inizio di questo Millennio � balzata all�attenzione di tutto il mondo l�importanza della Suprema Corte, a causa del controverso computo dei voti del democratico Al Gore e del repubblicano George W. Bush, che si � risolto con la decisione di tale Corte, che � com�� noto � ha attribuito la vittoria finale per la nomina a Presidente degli Stati Uniti, al secondo.
L�alta giurisdizione federale �, pur nella fallibilit� di tutte le istituzioni umane, tuttora quanto mai essenziale per assicurare l�ordinato svolgimento della vita politica nazionale e per garantire l�equilibrio fra le massime istituzioni[23]-.
Tale essenzialit� non va peraltro confusa- lo ha bene osservato M. Teodori[24]-con il c.d. governo dei giudici o con le loro possibili interferenze sul potere legislativo, poich� in realt�, ferma la reciproca indipendenza dei tre tradizionali poteri dello Stato, negli U.S.A. i cittadini hanno un� opportunit� in pi� per far valere i loro diritti, qualora non riescano ad ottenerne l�auspicata tutela in sede legislativa o governativa.
Ben diverso dal modello americano � quello vigente nel nostro Paese, dove la nota riforma del Titolo V della nostra Costituzione, ha conferito ampio spazio alle autonomie locali in ossequio ad un federalismo poco appropriatamente evocato, trattandosi, a differenza che Oltreoceano ,della frammentazione e non dell�aggregazione (come l�etimo foedus lascerebbe altrimenti intuire) delle realt� territoriali esistenti.
Entrando nello specifico della giustizia, le differenze sono ben pi� marcate perch�, innanzi tutto, la nostra Magistratura ha una configurazione unitaria nei vari livelli di giurisdizione, che la rende in toto e non solo agli apici, indipendente da ogni altro potere. Tale indipendenza, oltre all�espressa previsione costituzionale (art. 104 cost.), � garantita dalle procedure concorsuali stabilite per accedervi e dall�inamovibilit� dei suoi appartenenti (artt. 106 e 107 cost.).
Questi ultimi, come recita testualmente l�art. 101 cost., sono soggetti soltanto alla legge, che pertanto costituisce per un verso la fonte del loro potere, e per altro verso ne costituisce il limite invalicabile.
In tempi abbastanza a noi vicini � stata messa in discussione- com�� noto- l� unitariet� della Magistratura, che alcuni vorrebbero distintamente articolata nella carriera giudicante ed in quella del Pubblico Ministero, anche per rendere pi� equilibrato il rapporto fra accusa e difesa, attualmente sbilanciato ai danni della seconda.
Non si tratterebbe in realt� di un novit� per il nostro Paese, dal momento che a partire dall�Unit� e fino al periodo fascista, quella del P.M. era una carriera a parte, posta alle dirette dipendenze dell�Esecutivo, e quindi priva di quella connotazione autonoma che avrebbe dovuto assicurarle l�esercizio sereno ed imparziale dell�azione penale.
Il problema � tornato dunque di attualit� in seguito alla c.d. Tangentopoli, nel cui ambito i magistrati del pool di Mani pulite della Procura di Milano, avviarono una serie di procedimenti penali per corruzione ed illecito finanziamento ai partiti, in cui furono inquisiti o arrestati membri sia del Parlamento che del Governo.
L�equilibrio dei fondamentali tra poteri teorizzato dal barone Montesquieu ne risult� profondamente alterato, ma trattandosi di una fase di crisi, seppur non destinata ad esaurirsi nell�arco di un breve lasso di tempo, la contingente confusione dei ruoli non poteva di per s� portare ad involuzioni di tipo autoritario.
La funzione di �supplenza� che di fatto venne ad essere esercitata dal potere giudiziario � o meglio da parte di esso � innanzi all�arretramento sbigottito di un Parlamento vacillante sotto i colpi dei mandati di arresto, poteva ancora ritenersi �fisiologica� nell�ambito di una fase di decadenza (morale prima che giuridica) destinata ad alternarsi con altre di ascesa.
Si trattava infatti di uno di quei momenti facenti parte, secondo la lezione crociana , dell�idea stessa di progresso, che si svolge come una spirale con dei tratti in salita e altri in discesa, e non nella direzione di una linea retta che s�innalza costantemente, illusoriamente ipotizzata nell�Ottocento[25].
Chiusa l�era di Tangentopoli, anche dopo la riforma elettorale che ha segnato con il passaggio dal sistema proporzionale a quello maggioritario- riforma votata non tanto per una sopraggiunta inadeguatezza del primo ad esprimere l�orientamento politico dei pi�, quanto per la sua (ingiusta) identificazione quale principale causa della deriva morale dei partiti tradizionali- alcune frange della Magistratura hanno stentato a rientrare nei ranghi loro assegnati dalla Costituzione.
Ne sono derivate � come accennato � proposte di riforma non del tutto disinteressate, per separare la Magistratura giudicante da quella inquirente, la qual ultima dovrebbe tornare sotto l�Esecutivo, come in et� regia.
Ci� comporterebbe, a nostro avviso, una speculare straripamento: questa volta dell�Esecutivo nei confronti del Giudiziario, che ha gi� superato a sua volta gli argini che lo separano dal Legislativo. Quest� ultimo in virt� della rappresentanza conferitagli dal popolo, � l�unico depositario del potere sovrano.
Con il perdurare o addirittura l�istituzionalizzazione della confusione dei ruoli, e con il rischio della concentrazione nelle mani di una medesima forza politica del potere legislativo, di quello esecutivo e di gran parte di quello giudiziario, verrebbe a realizzarsi quella �dittatura della maggioranza� che Tocqueville aveva vivamente aborrito.
Contro tale rischio esistono bens� dei meccanismi di garanzia, come i poteri di controllo assegnati al Capo dello Stato ed alla Corte costituzionale; nonch� la procedura �rafforzata� che prevede una maggioranza qualificata per cambiare una Costituzione come la nostra (perci� detta �rigida�);ed infine i paletti insormontabili dei diritti fondamentali ivi riconosciuti, che dunque sono ad essa preesistenti e che nessuna sua eventuale riforma potrebbe eliminare.
La formale separazione dei tre poteri fondamentali, da sola non basta dunque a garantire il reciproco controllo e bilanciamento, nel caso di una loro riferibilit� sostanziale ad una stessa forza politicamente prevalente[26].
La Costituzione, da canto suo, non � un dominio riservato alle maggioranze che si alternano al Governo, ma appartiene al popolo- come ha ben osservato A. Maccanico[27]- cio� al presente ed al futuro della collettivit� nel suo insieme.
Una maggioranza, per quanto estesa, non deve mai scalfire i diritti delle minoranze e non deve contrastarne la possibilit� che, in tempi pi� o meno vicini, attraverso la propaganda propria o gli errori altrui, possa a sua volta divenire maggioranza, per quella che gli anglosassoni amano definire l��oscillazione del pendolo� (o altalena dei partiti)[28].
In conclusione, sar� utile aver sempre presenti le riflessioni e le lungimiranti analisi di Tocqueville, il cui pensiero, a distanza di quasi due secoli, rimane di sorprendente attualit� e ne perpetua l�immortalit� spirituale, anche sopra il cielo di questa nuova Europa ,che ha pi� che mai bisogno di riconoscersi in solidi e duraturi valori morali e politici.
[1] E� il principio fondamentale degli ordinamenti anglosassoni, in virt� del quale i giudici inferiori debbono rispettare le sentenze precedenti di quelli superiori, al fine di assicurare una linea di omogeneit� giurisprudenziale.
[2] Cos� G. Cassandro, �I giudici elettivi�, in Diritto e societ�, 1978, n.1, p.161
[3] F. Calasso, �L�unit� giuridica dell�Europa�, Rubettino., Soveria Mannelli, p.7
[4] V. G. Tedeschi, �Alexis, il bello della diretta�, ne Il Sole 24 Ore del 5 giugno 2005
[5] Sul punto, cfr. E. P. La Manna, La filosofia dell�Ottocento, Le Monnier, Firenze, 1962, P.251 segg.
[6] A de Tocqueville, �Liberalismo e democrazia�, ne Il liberalismo europeo, a cura di V. De Caprariis e T. Amato, Garzanti,Milano, 1963, P. 115 segg.
[7] Il brano � riportato da G. Bedeschi, �Alexis, il bello della diretta�, cit.
[8] Sul punto ch. N. Matteucci, �La tradizione liberale�, in www.societ�libera. org/liberali/oggi/matteucci; nonch� www.filosofico.net/Tocqueville.
[9] Cfr. J. Godechot, �Le grandi correnti della storiografia nella Rivoluzione francese in Nuove questioni di storia moderna, Marzorati, Milano, 1972, pp. 1369-70.
[10] A. de Tocqueville, La democrazia in America, a cura di G. Candeloro, Rizzoli, Milano, 1982, p. 101.
[11] Cfr. G.B. Rizzo, �La democrazia americana�, in Scritti vari, Giuffr�, Milano 1973, p. 42.
[12] A. de Tocqueville, op. cit., p. 105
[13] Op. cit., p. 110
[18] Op. cit., p. 148
[19] Op. cit., p.149
[20] Op. cit., p. 152
[21] Op. cit., p. 278
[22] Ibidem.
[23] Cfr. al riguardo M. Teodori, Benedetti Americani, Mondadori, Milano 2003, p. 135.
[24]Iblidem.
[25] Sul punto cfr. G. Cassandro, �Sul problema della continuit��, in Annuario scientifico dell�anno 1972 della scuola di Scienze politiche di Atene Panteios, 1972, p. 145
[26] V. M. Luciani, �Ma anche Tocqueville ha usato quello stesso concetto�, ne La Stampa del 12 marzo 2005.
[27] A. Maccanico, �Non si pu� profanare la Costituzione�, in Europa del 14 ottobre 2004.
[28] Cfr. G.B. Rizzo, �I diritti delle Minoranze�, in Scritti vari,cit.,p.35

vai indietro