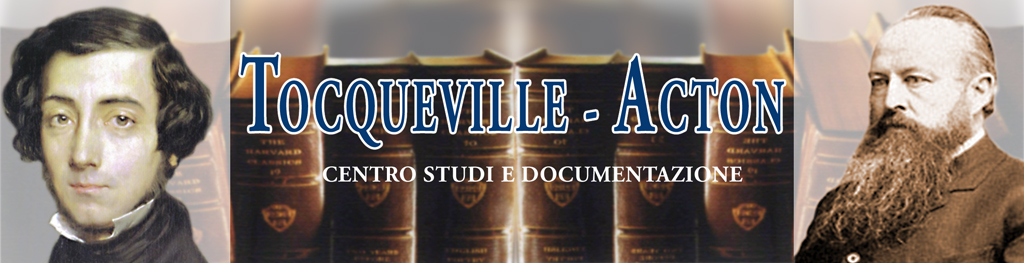
Un voto liquido in una societ� liquefatta
di Gianfranco Morra
La cosa pi� paradossale delle recenti elezioni � che, in mezzo a forti contrapposizioni e proclamate inconciliabiulit�, i candidati non dicevano in fondo cose troppo diverse. Abbiamo avuto elezioni con scarsa dialettica politica: tutti promettevano la diminuzione delle tasse e l�aumento di retribuzioni e pensioni, senza indicare come far quadrare il circolo. Le cose pi� importanti, in fondo, nessuno le ha dette, perch� sono le pi� sgradevoli: all�attacco delle economie asiatiche e alla recessione dell�occidente l�Italia non � stata sinora capace di rispondere, in quanto avrebbe bisogno di riscoprire lo stile etico, produttivo e solidaristico, degli anni Cinquanta. Pi� che di riforme strutturali, ha bisogno di recuperare una morale pubblica, senza il quale nessuna riforma funziona. Mentre invece, questa morale, � stata sinora assai affogata nell�individualismo delle masse, nelle archeologie sindacali, nell�inconcludenza dei politici.
�Sacrifici�: ecco la parola che in campagna elettorale nessun tycoon poteva usare. Perch� mai � accaduto? Per capirlo occorre guardare da lontano e assumere quella consapevolezza che tanti sociologi hanno indicato: che la societ� del passato era solida, mentre quella attuale � �liquida� (Z. Baumann, Vita liquida, 2006), non � ordinata, ma �flessibile� (R. Sennet, L�uomo flessibile, 2001). Anni addietro usai la dicotomia �forte-debole� (G. Morra, Il quarto uomo, 1996); il mio amico (in senso buono) Gianni Vattimo aveva detto �trasparente� (La societ� trasparente, 1989). Meglio di tutti Ch. Lasch l�aveva definita �narcisista� (La cultura del narcisismo, 1981).
In una societ� del genere, dominata dal consumo di massa e dagli audiovisivi, non solo il ragionamento e il confronto di idee non sono attesi dai cittadini, ma risultano non poco sgradevoli e astratti. L�uomo liquido � un �io minimo�, pauroso di perdere il �particulare� e privo di speranze per il futuro. Guarda dunque alla quotidianit� e al concreto: i soldi, la casa, il posto di lavoro (o almeno di stipendio), la libert� di fare quello che vuole, magari con il contributo del Welfare. E� un misto di individualismo liberal e di statalismo assistenziale. Il criterio della scelta � troppo spesso l�interesse di categoria o la collocazione geografica. Il futuro leader, in queste condizioni, � costretto ad assumere l�abito del campione sportivo, del piazzista e del mezzobusto televisivo, il suo linguaggio deve stupire e catturare, dato che non importa convincere: un po� come insegnavano i sofisti. Pi� che i ragionamenti, valgono le gag, ma solo per pochi minuti, mezz�ora dopo vengono smentite o dimenticate.
In tale situazione, che � di tutti i paesi occidentali, passati dal liberalismo elitario alla democrazia di massa, sarebbe dovuta prevalere, secondo la previsione di Max Weber, una democrazia plebiscitaria del leader. In effetti la politica, dopo il crollo delle ideologie, si � personalizzata attorno a due o tre candidati, al punto che l�elettorato pu� scegliere solo loro e non i quasi mille suoi rappresentanti in parlamento (tutti predestinati dalla �casta�). Ma questa personalizzazione viene il pi� delle volte vissuta dentro superficialit� ed impressionismo, prevalenza delle immagini e delle emozioni. Anche perch� dovendo pescare da tutte le parti, i due leader finiranno per somigliarsi tanto nel dire, quanto ancor pi� nel non dire.
Non � stato sempre cos�. Nei primi decenni della nostra democrazia l�alternativa era tra idee forti: democrazia-comunismo, iniziativa-solidariet�, occidente-oriente, cristianesimo-ateismo. Il clima della guerra fredda alimentava queste alternative e produceva una certa stabilit� nel voto, tanto che la Dc non perse mai il potere per quarant�anni. E la Dc di valori, anche se ne faceva per lo pi� un uso strumentale, ne aveva non pochi. Magari li tradiva, a un certo punto ha cominciato a pescare a destra per spendere a sinistra, ma il voto era ancora determinato dal riferimento a quelle grandi parole (le �ideologie), che tutti partiti dovevano usare: libert�, eguaglianza, solidariet�, giustizia, benessere. Poi, insieme col muro di Berlino, tanto le ideologie, quanto i partiti ideologici sono caduti.
Oggi le competizioni elettorali non hanno pi� partiti forti (liberali, comunisti, democristiani, fascisti, socialisti), ma solo delle coalizioni liquide che cercano di tenersi lontane dalle ideologie, evitate anche nelle denominazioni, volutamente generiche e deboli (Libert�, Democratico, Arcobaleno, Centro). Ecco perch� Veltroni non ha avuto difficolt� a fare un partito con i postcattolici ed a ospitare i radicali; e nella casa di Berlusconi convivono il partito della difesa della nazione e quello della secessione. Non poteva che essere cos�: in una politica liquida, ci� che pi� conta sono i flussi dei voti e per raccogliere i �liquidi� non ci vogliono partiti, ma contenitori, tenuti in mano da un esibito leader �carismatico�. Gli elettori non hanno pi� una identit� definita, n� una ideologia di appartenenza, hanno bisogno di avere qualcosa di nuovo: ecco perch�, negli ultimi quindici anni, non solo i vecchi partiti hanno messo in cantina i nomi tradizionali e ne hanno assunti altri disideologizzati, ma hanno anche cambiato due o tre volte il nuovo nome. Anche i partiti sono liquidi.
La prova del nove � venuta dal disastro di Giuliano Ferrara, esponente autentico e schietto di quella �morale della convizione� (�vegna che vegna�), che Max Weber aveva mostrato disastrosa se non unita alla �morale della responsabilit�� (�se faccio x, quali ne saranno le conseguenze?�). La sua proposta di mettere in moratoria la legge sull�aborto era certo priva di fondamenti giuridici, ma partiva da un principio sacrosanto della morale: la difesa della vita. Ma un elettorato liquido guarda al concreto e non � scosso in alcun modo da questi appelli ai valori supremi. La diminuzione della tasse conta pi� della vita, la strage degli innocenti interessa meno del prezzo della benzina. Ferrara � stato il Savonarola di turno, un �profeta disarmato�. Non l�hanno bruciato solo perch� ci sarebbe voluta troppo legna.
E� facile e anche giusto dire che la politica opera in una data situazione, che ne costituisce lo sfondo. Una situazione socioculturale che dipende da motivi metapolitici e di cui i politici debbono tener conto. Cosa vera, quando si pensi che l�attuale crisi della morale � stata prodotta da una rivoluzione, quella del Sessantotto, che non fu politica, ma antropologica. Eppure anche la politica pu� fare qualcosa. Pu� gettare le basi di un lungo recupero, pu� fornire gli strumenti per rialzare l�Italia non solo economicamente, ma anche e prima ancora moralmente.
Per fortuna Veltroni � stato sconfitto. E� stato capace di staccarsi dal comunismo, al punto che lo ha fatto sparire, come il figlio freudiano che, per divenire adulto, ha dovuto uccidere il padre. Ma non si � staccato dal relativismo buonista che, finiti i bollenti spiriti della contestazione, � divenuto prevalente nei riflusso del �pensiero debole�. In lui il radicalismo piccolo-borghese trionfa sul collettivismo all�interno di una ideologia e di una politica �liquide�. Come � ovvio, dato che la sfacelo etico, la distruzione dell�unica morale che gli italiani abbiano avuto, quella insegnata da Santa Madre Chiesa (una morale che la classe borghese aveva laicizzato, ma non rifiutato), � stata compiuta dalla sinistra, nelle sue varie denominazioni.
Oggi ha vinto il centrodestra ed � lecito sperare che qualcosa comincer� a muoversi. Ci� di cui abbiamo bisogno non � di un radicalismo di massa e neppure di una populismo tecnocratico. Senza liberali, democristiani, fascisti, comunisti, socialisti, la politica potr� essere pi� spedita ed efficiente. Ma sarebbe un errore annegare in un liquido incolore quei messaggi di libert� e solidariet� che, nonostante strumentalizzazione e tradimenti, per pi� di un secolo hanno fatto la storia d�Italia.

vai indietro