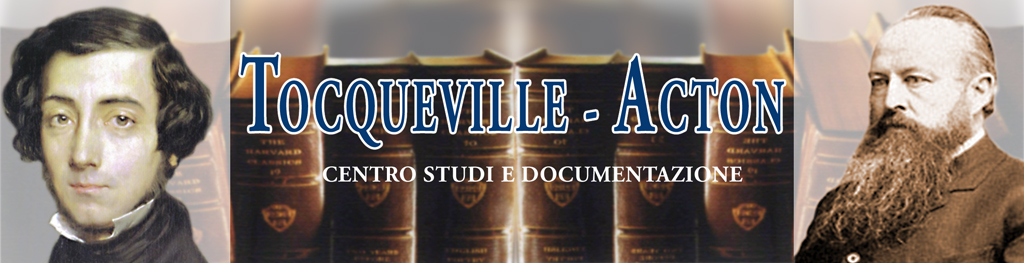
![]() D. Antiseri, Filosofia contemporanea,
riconquista della contingenza e attualit� del pensiero francescano
D. Antiseri, Filosofia contemporanea,
riconquista della contingenza e attualit� del pensiero francescano
![]() E. Donadon,
Schweitzer e cassirer: memoria e
speranza
E. Donadon,
Schweitzer e cassirer: memoria e
speranza
![]() G. Brescia, Benedetto Croce e Luigi Sturzo
G. Brescia, Benedetto Croce e Luigi Sturzo
![]() R. Cubeddu,
Legge naturale o diritti naturali? Alcune questioni concernenti
la filosofia politica liberale
R. Cubeddu,
Legge naturale o diritti naturali? Alcune questioni concernenti
la filosofia politica liberale
vai indietro
Filosofia contemporanea, riconquista della contingenza e attualit� del pensiero francescano
di D. Antiseri
1. �Assoluti terrestri�: altrettante negazioni dell��Assoluto trascendente�
Il secolo XX, il secolo appena trascorso, si � aperto con tre imponenti movimenti filosofici � positivismo, idealismo e marxismo � che, assolutizzando o divinizzando l�uomo, pretesero, con motivazioni differenti, di cancellare ogni spazio della fede.
Per i materialisti la trascendenza � illusione; per i positivisti Dio � un�ipotesi inutile; per gli idealisti le verit� di fede non sono la rivelazione di Dio all�uomo, sono rappresentazioni mitiche di cui va scoperto il nocciolo razionale. Con Marx le cose vanno ben oltre. Per Marx, infatti, la fede in Dio non � semplicemente un�ipotesi inutile o un�illusione o un mito che mentre sembra parlare di Dio, in realt� parla di cose del tutto �immanenti�. Per Marx la fede in Dio � dannosa per l�uomo, una malattia le cui cause sono da combattere ed estirpare. �La lotta contro la religione � si legge in Per la critica della filosofia del diritto di Hegel � � la lotta contro quel mondo, di cui la religione � la quintessenza spirituale [�]. La religione � il sospiro della creatura oppressa, il cuore di un mondo spietato [�]. Essa � l�oppio del popolo�.
Dannosa la fede non � soltanto per Marx e, sostanzialmente, per l�intero movimento marxista del nostro secolo. La fede � dannosa pure per Freud, il quale vede nella religione �una nevrosi ossessiva universale�. In breve, per i marxisti e per l�ateismo psicoanalitico Dio � diventato importuno. Cos� come, in linea generale, lo � per l�esi-stenzialismo ateo, per esempio di Sartre, Merleau-Ponty o Camus. L�uomo, ha scritto Sartre, �� una passione inutile�. Dio non esiste e �noi non abbiamo n� dietro a noi, n� dinanzi a noi, in un dominio luminoso di valori, delle giustificazioni o delle scuse. Siamo soli, senza scuse�. E, dopo gli esistenzialisti, i loro avversari: gli strutturalisti. Costoro in nome di una �ragione nascosta� hanno preteso di condannare la �ragione cosciente�, ed insieme a questa, ogni traccia di trascendenza. Claude L�vi-Strauss: �All�inizio del mondo l�uomo non c�era; non ci sar� neanche alla fine�. E alla domanda �che cosa si pu� sperare?�, Jacques Lacan ha risposto: �Non si pu� sperare assolutamente niente. Non vi � alcuna specie di speranza�. E non avrebbero nessun senso letterale, secondo i neopositivisti del Circolo di Vienna, le proposizioni che parlano di �Dio�, dell��anima immortale�, di �trascendenza�, o di �Provvidenza�. Questi concetti e gli asserti che li inglobano sarebbero dei puri �non-sensi�, perch� concetti e asserzioni non verificabili empiricamente, vale a dire non traducibili o riducibili al linguaggio �cosale� della fisica. �N� Iddio n� alcun diavolo � dir� Carnap � potranno mai darci una metafisica�. E per Alfred J. Ayer, gli asserti di fede, insieme alle teorie metafisiche �sono soltanto materiale per lo psicoanalista�.
Queste ora richiamate sono prospettive filosofiche che hanno preteso di proibire lo spazio della fede. La fede nel Dio di Ges� Cristo risulta vietata da �assoluti terrestri� che si sono presentati come altrettante negazioni dell��Assoluto trascendente�. Difatti � e al fine di essere ancora pi� chiari � se il positivismo fosse vero, la fede sarebbe allora null�altro che illusione, residuo di mentalit� sorpassate; se il materialismo dialettico fosse nel giusto, la fede sarebbe allora solo alienazione; se il neopositivismo fosse valido, allora la fede sarebbe unicamente un cumulo di non-sensi; e cos� via. Assoluti terrestri proposti e accettati e sempre propagati come indubitabili � scientismo materialistico, idealismo (in gran parte), positivismo, neopositivismo, movimento psicoanalitico (in gran parte), marxismo, esistenzialismo (in buona parte), strutturalismo � queste prospettive filosofiche hanno costituito nel secolo che abbiamo alle spalle la truppa d�assalto contro le verit� cristiane.
2. La riconquista della �contingenza�
La fede � grazia a parte Dei e opzione a parte hominis. Questa opzione a parte hominis sarebbe tuttavia impossibile in un universo in cui si dimostrasse che l�uomo � solo corpo; in un universo in cui quello scientifico fosse l�unico linguaggio dotato di senso; in un mondo in cui il senso della vita del singolo e dell�umanit� nella sua interezza risultasse determinato da ineluttabili leggi di sviluppo della storia; in cui tutta la realt� si risolvesse nel solo universo fisico. Quindi, perch� la fede sia possibile � necessario che prima vengano distrutti gli �assoluti terrestri�, certezze presunte indubitabili, totalizzanti e negatrici della trascendenza. Un sapere assoluto � un uomo assoluto; e l�uomo assoluto fa sprezzantemente a meno del Redentore.
Ebbene, se il secolo scorso si � aperto, come si � detto all�inizio, con imponenti movimenti filosofici, accomunati dall�idea che �homo homini deus est�, sempre questo secolo si � chiuso con la lucida consapevolezza di una riconquistata contingenza, con una luce chiara sui limiti della ragione umana. Si � trattato di concezioni filosofiche che hanno tenuto incatenate le menti di tanti uomini e donne, e che avevano sequestrato intelligenze proibendo ad esse qualsiasi apertura all�esperienza religiosa. Ai nostri giorni non � pi� possibile nascondere l�inventario dei fallimenti di filosofie come il positivismo, l�idealismo, il marxismo o il neopositivismo � fallimenti dovuti ad una ybris generata dall�abuso sistematico della ragione. Al tramonto del secolo abbiamo viste sepolte le �grandi illusioni� e le orgogliose presunzioni di filosofi che volevano essere i becchini di Dio. Ma non si � affatto avuta la morte di Dio. Sono piuttosto scomparse le illusioni filosofiche. Non � scomparsa la �grande filosofia�. E� scomparsa la presunzione fatale stando alla quale l�uomo sarebbe stato e sarebbe capace di autosalvezza, di salvare se stesso dalla voragine dell�assurdo.
La filosofia contemporanea, nelle sue punte pi� avanzate e scaltrite, ha esattamente devastato le pretese di un uomo che ha tentato di erigere vitelli d�oro � che ha negato Dio e ha popolato la terra di mostri, del Gulag e di Lager. In quest�opera di demolizione degli �assoluti terrestri� particolarmente efficaci si sono mostrati, a mio avviso, gli strumenti concettuali forgiati nell�arsenale epistemologico-ermeneutico. Cos�, per esempio, � stato Karl Popper ad assestare il colpo decisivo allo scientismo: le teorie scientifiche sono e restano smentibili; i discorsi non scientifici, quali le teorie filosofiche, non sono affatto insensati (come pretendevano i neopositivisti); il cervello non spiega la mente; il determinismo � falso; falso � il conseguente fatalismo; e il futuro resta aperto alle nostre scelte e al nostro impegno di cittadini liberi e responsabili in una societ� aperta. Hans Georg Gadamer ci ha fatto capire che noi leggiamo il mondo con un linguaggio fatto di concetti non assoluti, di a-priori temporalizzati, per cui non paiono pi� possibili quei grandi racconti che pretendevano esibire fundamenta inconcussa. Contro lo pseudo-razionalismo di quanti, come i marxisti, si sono creduti in possesso di leggi ineluttabili della storia, si � battuto non solo Popper, ma anche Friedrich A. von Hayek � premio Nobel per l�economia nel 1974 � il quale, insistendo sulle inevitabili conseguenze inintenzionali delle azioni umane intenzionali, � giunto a concludere, in una prospettiva anticostruttivistica, che �l�uomo non � e non sar� mai il padrone del proprio destino�. E Kelsen, Popper ed Hayek � e, certamente, non solo loro � hanno messo a nudo la totale inconsistenza delle argomentazioni a sostegno dello Stato totalitario, offrendo al contempo ragioni logiche, epistemologiche ed economiche della �societ� aperta� (Popper) o �Stato di diritto� (Kelsen) o �Grande societ� (Hayek).
3. Domanda metafisica e risposta religiosa
All�interno di siffatto orizzonte � dove con evidenza vengono scolpiti i tratti della contingenza umana � riemerge pi� irreprimibile che mai la domanda metafisica: perch� l�essere piuttosto che il nulla? Domanda metafisica che trova il suo nervo scoperto nella sofferenza, e in special modo nella sofferenza innocente. Perch� la sofferenza? Ma poi, e soprattutto, perch� la sofferenza di tanti innocenti? Tale interrogativo � annota con profondit� Norberto Bobbio � �� una richiesta di senso, che rimane senza risposta o, meglio, che rinvia ad una risposta che mi pare difficile chiamare ancora filosofica�.
Non � la scienza a dirci quello che dobbiamo fare. Non � la scienza a insegnarci in che cosa possiamo sperare. E� per principio che la scienza non risponde alle domande per noi le pi� importanti. Il porro unum necessarium esula dalla ragione scientifica. e non � possesso della ragione filosofica: la filosofia non salva. La filosofia pu� portare a perdizione ma non salva. Ma �proprio perch� le grandi risposte non sono alla portata della nostra mente, l�uomo � � ancora Norberto Bobbio a parlare � rimane un essere religioso, nonostante tutti i processi di demitizzazione, di secolarizzazione, tutte le affermazioni della morte di Dio, che caratterizzano l�et� moderna e ancor pi� quella contemporanea�.
�Credere in Dio � ha scritto Ludwig Wittgenstein � vuol dire vedere che i fatti del mondo non sono poi tutto�. Il secolo XX si era aperto con le filosofie certe che i fatti del mondo e gli uomini siano tutto; e si � chiuso consapevole della presunzione fatale di quanti intesero proibire e cancellare l�esperienza religiosa, privando l�umanit� della ricchezza pi� grande. � cos� che � stato ricostruito lo spazio della fede, dove � possibile l�opzione religiosa che sola ci consente di sperare che il carnefice non abbia l�ultima parola sulla vittima innocente.
La distruzione degli assoluti terrestri non � e non va in nessun modo scambiata con la vittoria del nulla, del nulla di senso, vale a dire del nichilismo. La consapevolezza della contingenza umana non � naufragio nell�assurdo. � la consapevolezza che la salvezza dall�assurdo non � una costruzione umana; e che quel senso che non pu� essere costruito pu� venir invocato. Ma � e qui torniamo al punto di maggior rilievo � l�invocazione � possibile solo nel mondo della contingenza. Per questo non si sar� mai grati abbastanza a quei pensatori i quali hanno insegnato che l�uomo non � il padrone del senso, che � un mendicante di senso. E che ci han fatto capire che �ormai solo un Dio ci pu� salvare�. La mancanza di senso si risolve nell�angoscia, in quella �malattia mortale� che per Kierkegaard era la disperazione. E �la coscienza angosciata � affermava Kierkegaard � capisce il Cristianesimo, come un animale affamato; se gli metti davanti un pezzo di pane o di pietra capisce che l�uno � da mangiare e l�altra no; a questo modo la conoscenza angosciata capisce il Cristianesimo�.
Quaestio magna mihi cactus sum, terra difficultatis � confessava Agostino. E Heidegger e Marcel hanno puntato l�attenzione sul fatto che quella metafisica � una questione che coinvolge il domandante stesso. Non � un �problema�, ha piuttosto la natura di un� �invocazione�. E� una �interrogatio� nella forma; solo �rogatio� nella sostanza. Per questo essa non ammette soluzioni presunte razionali univoche, assolute ed incontrovertibili. Ammette soltanto scelte di fede. La domanda metafisica, se vuole una risposta assoluta, avr� soltanto una risposta di fede, una risposta religiosa. E ci� vuol dire, inequivocabilmente, che anche la domanda era religiosa, era cio� invocazione. Invocazione di salvezza, invocazione appunto della salvezza dall�assurdo, invocazione di quel senso assoluto della vita che da soli non riusciamo a costruire. E chi sceglie l�assurdo, cio� l�ateo, non � pi� scientifico del credente. In un orizzonte del genere � del tutto ragionevole cercare una risposta religiosa ad una invocazione religiosa. E� questo quanto ha fatto Francesco d�Assisi. Egli spalanc� il suo cuore e la sua mente all�invito di Cristo. Ne I racconti dei Chassidim Martin Buber parla del Rabbi Mendel di Kozk, il quale �stup� alcuni uomini dotti che erano suoi ospiti con questa domanda: �Dove abita Dio?�. Quelli risero di lui: �Che dite? Se tutto il mondo � pieno della sua gloria?�. Ma egli rispose da s� alla propria domanda: �Dio abita dove lo si fa entrare��. �Aprite le porte a Cristo�: fu questo il grido di Papa Giovanni Paolo II: un tratto essenziale della spiritualit� francescana � del pensiero e dell�azione del francescanesimo.
Dono a parte Dei, scelta a parte hominis � la fede o, meglio, la scelta di fede viene talvolta considerata una specie di rifugio opportunistico � un rifugio dove Dio altro non sarebbe che un Dio-tappabuchi. La paura delle parole, per�, � la pi� meschina delle paure, per cui se il buco da tappare � il senso della vita di ogni uomo e dell�intero universo, il buco da tappare � un autentico baratro � il baratro del non senso � che soltanto Dio pu� colmare. E a quanti qui replicano con l�accusa di irrazionalismo si pu� richiamare la scommessa di Pascal, della quale � rinvenibile una versione �volgarizzata� in una pagina di Lodovico Antonio Muratori: �Mentre Arrigo IV, Re di Francia, si trovava alla caccia, pass� per quelle parti il Padre Gioiosa Cappuccino, gi� Duca e General d�Armata al Secolo; e udito, ch�ivi era il Re, and� a inchinarlo. Arrigo in vedere il buon Religioso tutto sudato, e pien di polvere e di stanchezza: Padre Gioiosa, gli disse ridendo, e se non fosse poi vero quanto si dice dell�altra vita? Francamente il Cappuccino rispose: Sar� ben peggio per la V.M. quando sia vero�. Dunque , chi � pi� �ragionevole� Arrigo IV o Padre Gioiosa? E a quei cattolici, solo loro �razionalisti� e sempre pronti ad accusare gli altri di fideismo, vorrei chiedere in base a quale metafisica accettano un Dio che muore in croce o credono nella presenza di Cristo nell�eucarestia. Come dice Luigi Giussani, alla fin fine l�opzione � decisiva.
4. Guglielmo d�Occam e la difesa dell�autonomia, libert� e intraprendenza della persona umana
�La maggior parte delle grandi emancipazioni dello spirito come dei progressi nel riconoscimento della dignit� degli uomini che hanno segnato la storia della civilt� occidentale si appoggiano sul postulato individualista implicito nel nominalismo di Occam (1280-1349). Dalla semplice verit� enunciata da questi � solo l�essere singolo � ontologicamente reale e nessuna entit� collettiva (priva di esistenza in quanto tale) ha il diritto di subordinarlo � ne segue che ciascun individuo si erge come essere autonomo dotato di un reale potere su se stesso�. Questo ha scritto Alain Laurent. Una annotazione da cui traspare l�enorme rilevanza del pensiero francescano a difesa della autonomia e responsabilit� di ogni uomo e di ogni donna nei confronti delle nefaste, onnivore e liberticide reificazioni dei concetti collettivi, di quelli che Max Weber chiamava Kollektiv-begriffe, quali: lo �Stato�, la �classe�, il �partito�, e cos� via. La verit� �, insomma, che l�individualismo (si pensi alla Scuola dei moralisti scozzesi, alla Scuola austriaca di economia, a Max Weber, Karl Popper, Raymond Boudon) non si oppone ad altruismo, bens� a collettivismo. E, come ha sottolineato Jos� Ortega y Gasset, �� stato proprio l�individualismo ad arricchire il mondo, ed stata questa ricchezza che ha cos� fondamentalmente moltiplicato la pianta umana�. Da parte sua, un dotto padre francescano, Orlando Todisco, in un volume di qualche anno fa (Duns Scoto e Guglielmo d�Occam. Dall�ontologia alla filosofia del linguaggio, 1989) faceva presente che la lotta di Occam contro il collettivismo e a favore dell�individualismo � stata una lotta �per il recupero della libert� degli uomini, la difesa della loro intraprendenza, il sostegno della loro autonomia�.
L�individualismo, quale difesa della persona umana contro le mai sopite e sempre risorgenti tentazioni liberticide delle varie forme di collettivismo, costituisce un punto di forza della tradizione di pensiero francescano che si intesse con le ragioni del volontarismo. Posizioni filosofiche che fanno dei maestri francescani degli autentici classici del pensiero filosofico. E, come si sa, un classico � un contemporaneo del futuro.
5. Le ragioni del volontarismo
La difesa che Scoto (1266-1308) fa della libert� lo conduce ad una critica radicale del necessitarismo naturalistico dei filosofi greco-arabi. Dio � libero e creando ha voluto gli enti particolari nella loro individualit� � e non le loro nature o essenze. Contingente l�origine, contingente � il mondo stesso e tutto ci� che � in esso, incluse le leggi morali. E, in una situazione del genere, quali sono i diritti necessari ed assoluti? Sono soltanto quelli contenuti nella prima tavola mosaica, e cio� l�unicit� di Dio e l�obbligo di adorare lui solo. Certo, l�intelletto percepisce la verit� dei precetti della seconda tavola. Ma l�obbligatoriet� di questi scaturisce solo dalla volont� legiferante di Dio nell�assenza della quale, si avrebbe un�etica razionale, la cui trasgressione sarebbe irrazionale, ma non peccaminosa. Il male � peccato, non errore � come riteneva Socrate. Dall�Ordinatio: �Come Dio poteva agire diversamente, cos� poteva stabilire altre leggi che, se fossero state promulgate, sarebbero rette, perch� nessuna legge � tale se non in quanto stabilita dalla volont� accettante di Dio� [�Ideo sicut potest aliter agere, ita potest aliam legem rectam statuere, quae si statuta a Deo, recta esset, quia nulla lex nisi quatenus a voluntate divina acceptante est statuta�]. In breve, � bene ci� che Dio comanda. Tanto che � scrive Scoto sempre nell�Ordinatio - �parecchie cose che sono proibite come illecite potrebbero diventare lecite se il legislatore le comandasse o almeno le permettesse, per esempio il furto, l�omicidio, l�adulterio e altre cose del genere, le quali non implicano una malizia inconciliabile con il fine ultimo, allo stesso modo che i loro apporti non includono una bont� che necessariamente conduca al fine ultimo�.
Il volontarismo di Scoto � diretta conseguenza della sua difesa della trascendenza di Dio infinito � una difesa senza compromessi che entra in collisione con quell��iper-razionalismo� dove prevalgono istanze pi� pagane che cristiane. In realt�, quel che si � detto della volont� di Dio, va pur detto, con le dovute proporzioni, della volont� dell�uomo. E Scoto sottolinea a pi� riprese il ruolo-guida della volont� che agisce sull�intelletto orientandolo verso una certa direzione e distinguendolo dall�altra. La luce dell�intelletto � necessaria, non per� determinante. Per guarire da un malanno � necessario conoscere farmaci adeguati, ma l�atto di assumere il farmaco non � necessario, ma libero, in quanto alla vita uno pu� preferire la morte.
Pretese giusnaturalistiche avanzate con la forza della pura ragione appaiono, ai nostri giorni, sempre meno convincenti, se non altro a motivo del fatto che da proposizioni descrittive non � possibile passare logicamente ad asserti prescrittivi, per cui da tutta la scienza disponibile non � possibile estrarre un grammo di morale. La scienza descrive, spiega e prevede, sempre tramite teorie falsificabili, ma non stabilisce valori. La scienza sa, l�etica valuta. Non intendo annoiarvi con richiami alla lunga, travagliata e certamente ricca storia della disputa tra razionalisti e volontaristi � ma una domanda mi sta a cuore porla: un cristiano ci� che � bene e ci� che � male lo sa dal Vangelo o dalla ragione? � da quale ragione? dalla ragione di chi? E se il bene ed il male assoluto lo stabilisse la ragione, non sarebbero nel giusto coloro che affermano che allora �mestier non era parturir Maria�?
L�antica disputa tra razionalisti e volontaristi si configura ai nostri giorni � all�interno dell�analisi linguistica ed epistemologica � come uno scontro tra cognitivisti e non-cognitivisti. Uno scontro che l�argomentazione logica fa pendere dalla parte del volontarismo. Certo, pu� essere deludente rendersi conto del fatto che non pu� esservi una base razionale valida per tutti delle nostre convinzioni etiche e politiche di fondo. Ma, d�altra parte, non � frutto di presunzione fatale pensare all�uomo come al padrone assoluto di un senso assoluto e costruttore-padrone del bene assoluto? Insomma: Dio vuole il bene perch� il bene � bene ovvero � bene ci� che Dio comanda? Chi ha una migliore conoscenza dell�uomo, della natura umana, Dio o l�uomo? L�odio � tanto naturale quanto l�amore. E nostro Signore rende imperativo l�amore. Quanto � naturale porgere l�altra guancia? Quanto � naturale baciare il lebbroso? Il messaggio di Francesco � un teorema tratto dalla speculazione di qualche filosofo o la testimonianza di chi ha abbracciato l�imperativo evangelico dell�amore?
�Eritis sicut dei cognoscentes bonum et malum� � l�antica tentazione ha accarezzato i nostri istinti pi� bassi: quelli di sopraffazione dell�uomo sull�uomo; l�orgoglio luciferino dell�uomo che si � creduto un dio, che ha preteso di sostituirsi a Dio, di cancellare Dio � e insieme popolando la Terra di idoli assetati di sangue. Anche da qui, l�estrema attualit� del pensiero francescano: Francesco non intese fare dei �professori�, volle dei testimoni: testimoni dell�amore comandatoci da Ges� Cristo.
6. Cosa possono insegnarci ancora Roberto Grossatesta e Ruggero Bacone
Qui tuttavia non va affatto sottovalutato il contributo del francescanesimo alla genesi della filosofia empirica della natura. Cos�, tanto per esemplificare, � all�interno della sua metafisica della luce che Roberto Grossatesta (1175-1235) incastona e sistema conoscenze di natura puramente scientifica ed empirica quali quelle relative alla propriet� degli specchi e alla natura delle lenti. Ma, a parte ci�, notevole � il fatto che Grossatesta abbia espresso con estrema lucidit� un principio che in seguito sar� a fondamento del pensiero di Galileo e della fisica moderna: �L�utilit� dello studio delle linee, degli angoli, delle figure � somma, perch� senza di esse non si pu� conoscere niente della filosofia naturale. Esse valgono in modo assoluto in tutto l�universo e nelle parti di esso�. E� stato Nicola Abbagnano ad affermare che, sebbene frammiste ad elementi teologici, mistici e metafisici, le nuove ricerche �denunziano un nuovo corso dell�indagine filosofica e un rinnovamento dei suoi orizzonti�. E, in ogni caso, ha scritto Ch. Singer, �fu il francescano Roberto Grossatesta a determinare l�indirizzo fondamentale che assunsero gli studi fisici nei secoli XIII e XIV�. Ma se il Grossatesta pu� venir considerato quale l�iniziatore del naturalismo di Oxford, il rappresentante principale ne � Ruggero Bacone (1214 c. 1292 c.), il quale, allievo di Grossatesta ad Oxford, nomina tra i suoi predecessori e maestri anche Pietro Peregrino, autore nel 1269, di una Epistola de magnete di cui nel 1600 parler� Gilbert, il grande studioso del magnetismo. Sebbene, come gi� per Averro�, Aristotile � per Bacone �l�ultima perfezione dell�uomo�, ci� non significa affatto che la ricerca della verit� termini con Aristotile, perch� la verit�, ad avviso di Bacone, � filia temporis e la sua crescita non � priva di ostacoli. Ed esattamente nella prima parte dell�Opus maius Ruggero Bacone sviluppa una interessantissima analisi degli ostacoli che si frappongono al raggiungimento della verit�. Si tratta di riflessioni che anticipano e richiamano quelle che un altro Bacone, vale a dire Francesco Bacone, condurr� sugli idola. Ebbene, per Ruggero Bacone, quattro sono gli ostacoli che ci costringono nella caverna della nostra ignoranza: a) l�esempio dell�autorit� fragile e ingenua; b) le incrostazioni di una continuata abitudine; c) le idee del volgo sciocco; d) l�occultamento dell�ignoranza attraverso l�ostentazione di una apparente sapienza. La verit� � figlia del tempo e la scienza � opera non del Singolo, ma dell�umanit� che, appunto con il passar del tempo, elimina via via gli errori commessi in precedenza. E� cos� che il sapere progredisce. Due sono i modi tramite i quali noi arriviamo alla conoscenza: �per argomentazione e per esperimento� - ed � per esperienza esterna, quella che facciamo attraverso i sensi, che si perviene alle verit� naturali; mentre con l�esperienza interna, che � l�illuminazione divina agostiniana, perveniamo alle verit� soprannaturali. Sostenitore, al pari di Grossatesta, della fondamentalit� della matematica, studioso di fisica e particolarmente di ottica, Bacone comprese la legge della riflessione e della rifrazione della luce, studi� le lenti ed � a lui che si attribuisce l�invenzione degli occhiali e dei telescopi, intu�, tra altre, cose come il volo, l�impiego degli esplosivi, la circumnavigazione del globo, la propulsione meccanica. Scrive ancora Ch. Singer: �La previsione di una sola di queste scoperte non sarebbe degna di memoria, ma appare significativo il fatto che si ritrovassero cos� numerose in un'unica mente�. E pure per Ruggero Bacone, come sar� per Francesco Bacone, sapere � potere: �le opere della sapienza [�] sono come difese da leggi sicure e conducono efficacemente alla meta voluta�. E, di nuovo, la via che porta a questa meta � quella dell�esperienza, poich� �senza esperienza nulla si pu� conoscere in modo sufficiente�.
Dunque: con Roberto Grossatesta e Ruggero Bacone, anche se non soltanto con loro � basti qui ricordare Alberto Magno �, nasce e lentamente si sviluppa un filone matematico e sperimentalistico all�interno della filosofia scolastica. Certo, che il patrimonio scientifico-tecnologico fosse rimasto fino ad allora fuori dalla �filosofia� non significa affatto che le urgenze della vita pratica non avessero aguzzato l�ingegnosit� di uomini alle prese con la soluzione di problemi. Sar� sufficiente qui richiamare i tipi di bardature, i mulini ad acqua, il maglio ad acqua, l�orologio meccanico, la filatura della seta, il correggiato articolato, il mulino a vento, la fabbricazione delle lenti e quella della carta, l�estrazione di minerali. Questa e tante altre soluzioni tecniche ingegnose esistevano, ma, appunto, esistevano estranee alla filosofia. Grossatesta e Ruggero Bacone si situano esattamente all�inizio di quel movimento di pensiero che, riunendo teoria e pratica, porter� alla rivoluzione scientifica.
Perch� queste riflessioni su Roberto Grossatesta e Ruggero Bacone? Perch� insistere sul tratto empirico-scientifico del loro pensiero? E� questa un�insistenza motivata, oggi pi� di ieri, dal fatto che se la ricerca scientifica risolve problemi, altri ne crea incessantemente. E in un mondo dove uno scientismo cieco ai valori etici spinge a credere che � lecito fare tutto quello che tecnicamente si pu� fare, gli uomini di fede non possono disinteressarsi dell�avanzamento della scienza, in particolar modo della ricerca bio-medica, e lasciare la persona umana in balia di una nuova barbarie tecnologica in grado di travolgere l�uomo, fatto ad immagine e somiglianza di Dio, nei gorghi di una prospettiva di uomini �costruiti� secondo le voglie di altri uomini. Non tutto ci� che � tecnicamente possibile � anche eticamente lecito. Ci troviamo in una situazione problematica che impone di sapere cosa � tecnicamente possibile, di essere scientificamente attrezzati per controbattere quella mitologia scientista pronta a calpestare la inviolabile sacralit� della persona e a negare lo spazio del sano. E, dunque, una seria attenzione agli sviluppi della scienza (soprattutto bio-medici) in ambito formativo o, addirittura, un progetto per un centro scientifico di ricerca, ad alto livello e di grande prestigio internazionale sono davvero impegni tranquillamente trascurabili dalla tradizione francescana? Si serve il Vangelo servendo l�uomo; e pi� si serve l�uomo dove pi� fosche sono le minacce alla sua dignit� ed integrit�. I problemi suscitati dalla bioetica sono in cima ai preoccupati pensieri del santo Padre Benedetto XVI. E la preoccupazione del Papa non pu� non costituire un compito , il pi� urgente, per il pi� vasto mondo cattolico? Cosa, pertanto, pensate che si possa e debba fare in questa direzione?
7. Pratica della povert� e teoria della ricchezza: il contributo della Scuola francescana del XIII secolo alla genesi del capitalismo
E� �pazzamente dottrinaria� la tesi secondo la quale ��lo spirito capitalistico� sia potuto sorgere solo come emanazione di determinate influenze della Riforma o che addirittura il capitalismo come sistema economico sia un prodotto della Riforma. Gi� il fatto che alcune importanti forme di aziende capitalistiche sono notoriamente assai pi� antiche della Riforma si oppone una volta per sempre ad una tale opinione�. Questo dichiara Max Weber in una pagina del suo notissimo scritto L�etica protestante e lo spirito del capitalismo. Una pagina trascurata da molti studiosi i quali, come ha scritto Kurt Samuelsson in Economia e religione, abbracciarono, difesero e diffusero l�idea di un indiscutibile ed esclusivo nesso tra l�etica calvinista e lo spirito del capitalismo �come una �merce� da accettarsi senza un�ulteriore indagine, come verit� evidente per se stessa che non richiede n� conferma n� approfondimento�. E proprio qui sta una di quelle ragioni che, quando non bloccarono le indagini in altre direzioni, spinsero nell�ombra della dimenticanza o, in ogni caso, nel regno dell�irrilevanza studi nei quali si era posta l�attenzione sui rapporti tra cattolicesimo e capitalismo.
Da qualche tempo, tuttavia, sono noti i contributi �economici� della tardoscolastica spagnola � un movimento di idee che annovera come protagonisti, tra altri, i domenicani Francisco de Vitoria (1495 -1560) e Tom�s de Mercado (1500-1575); il vescovo agostiniano Miguel Solon (1538-1620); e i gesuiti Luis de Molina (1535-1600). Juan de Mariana (1535-1624), Francisco Suarez (1548-1617) e Juan de Lugo (1583-1660). Le funzioni della propriet� privata, i principi della tassazione, il valore delle merci, il rapporto tra prezzi e conoscenza, l�interesse e l�attivit� bancaria, il commercio con particolare riguardo al commercio internazionale: questi alcuni dei temi economici presi in considerazione dai tardo-scolastici, le cui idee, fatte proprie da Grozio, Pufendorf e dai fisiocratici, influirono in maniera decisiva sulla Scuola Scozzese di Ferguson, Hutcheson e Smith. E tra i tardo-scolastici vanno ricordati i francescani Juan de Medina (1490-1548), Lui de Aleale ed Henrique de Villalobos. Ma se la tardo-scolastica spagnola rappresenta un vero thesaurus per la storia delle teorie economiche, per la comprensione dei fatti economici, altrettanto si deve dire, oggi della Scuola francescana del XIII secolo.
Pratica della povert� e teoria della ricchezza � cos� potremmo sintetizzare la �teologia� economica francescana, dove la scelta della povert� pi� rigorosa induce molti francescani, sin dal Duecento, a riflettere sull�uso appropriato dei beni terreni da parte dei cristiani, e quindi sulla circolazione del danaro, sulla formazione dei prezzi, sui contratti, sulla moralit� dell�investimento socialmente produttivo, sulla figura del mercante. E proprio in quella del mercante, la Scuola francescana � con Pietro di Giovanni Olivi, Alessandro di Alessandria, Scoto, il catalano Eiximensis, il piemontese Astesano, il provenzale Francesco de Meyronnes ed altri ancora � vede �la professione-chiave della felicit� pubblica�, una professione che rende possibile lo scambio tra produttori, consumatori e professionisti delle diverse competenze, e dunque il mercato quale �sistema logico, dotato di un criterio di comunicazione interna�.
J. Schumpeter, nella sua monumentale Storia dell�analisi economica, scrive che fu il domenicano arcivescovo fiorentino Sant�Antonino a sostenere la funzione del prestito di denaro sia per i consumi che per gli investimenti vantaggiosi. Ma, come ben mostra Bazzichi, le cose non stanno affatto cos�, giacch� Sant�Antonino si richiamava alle idee di San Bernardino da Siena (1380-1440), il quale da parte sua, le aveva tratte da due francescani: Pietro di Giovanni Olivi (1248-1298) e Alessandro di Alessandria (1270-1314). Di fronte alla proibizione canonica dell�usura, � lecito distinguere fra il prestito di una somma di danaro qualsiasi e il prestito di una somma di danaro inscritto o da iscriversi nel processo produttivo, cio� impiegata in un programmato o gi� realizzato investimento produttivo? Ed ecco la risposta dell�Olivi: �Ci� che con ferma decisione (firmo proposito) � destinato a qualche probabile lucro, non solo ha il significato di semplice danaro o di qualsiasi merce, ma possiede in s� un qualche seme di lucro, che comunemente chiamiamo capitale. Perci� esso non solo deve prendere il suo stesso valore, ma anche un valore aggiunto (sed et valor superadiunctus)�. Da ci� si vede come l�Olivi stabilisce la coesistenza fra l�interesse del capitale e la proibizione canonica sull�usura � testimonianza che smentisce quanto affermava Eugen von Boehm-Bawerk nella sua Storia e critica delle teorie dell�interesse del capitale, e cio� che fu Calvino il primo teologo a schierarsi contro il divieto dell�interesse. E se � vero che i tardo-scolastici ci hanno lasciato riflessioni sul valore dei beni economici, � anche vero che ben prima di loro i francescani del Duecento, in primo luogo l�Olivi, avevano compreso che il valore di una cosa � dato dalla raritas, dalla virtuositas e dalla complacibilitas: e questa � la preferenza che un soggetto d� ad un bene in vista dell�appagamento di un bisogno piuttosto che di un altro, stabilendo una gradualit� tra questi. Si tratta � annota il Bazzichi - �della migliore e della pi� moderna tra le teorie del valore del Medioevo�.
Cos�, alle origini. E, ai nostri giorni, in una situazione di accentuati scambi (di idee, di merci e di danaro) globalizzati, con i vantaggi e i pericoli che essi comportano per i Paesi pi� poveri, quale � la posizione dei seguaci del �Poverello� nei confronti della globalizzazione? Quali le loro iniziative perch� il messaggio di Francesco non resti estraneo in un mondo che vorticosamente muta e che pu� produrre � come ammon� Giovanni Paolo II � nuove e pi� subdole forme di colonialismo? E le esperienze � tante e da secoli � dei francescani relative ai rapporti con il mondo musulmano non sono una via aurea per l�avvenire? In un mondo all�epoca diviso in due blocchi, l�uno contro l�altro, quello cristiano e quello musulmano, fu Francesco a rompere gli steccati e a portarsi personalmente dal Sultano. Il tentativo di pace di Francesco si aren� e la guerra prosegu�. E, tuttavia, la sua lezione e il suo impegno restano vivi, attuali � oggi come ieri.
8. San Bonaventura: �La scienza filosofica � via ad altre scienze�
Sin qui, dunque, alcune delle ragioni che rendono attuale, e quindi carico di impegni per il presente, il pensiero francescano. Ma le cose vanno ben oltre. �Abbia pure l�uomo la conoscenza della natura e la metafisica, che si eleva fino alle sostanze pi� alte, e poniamo che l�uomo, arrivato qui, si fermi: � impossibile che non cada in errore, se non � aiutato dalla luce della fede e non crede che Dio � uno e trino, potentissimo e ottimo fino all�estremo della bont� [�]. Perci� questa scienza precipit� e oscur� i filosofi [pagani] poich� non avevano la luce della fede [�]. La scienza filosofica � via ad altre scienze, ma chi vuol fermarsi ad essa, cade nelle tenebre�. Questo brano � che leggiamo nelle Collationes de donis Spiritus Sancti � esprime mirabilmente la funzione del sapere filosofico. Per quanto alto e sublime, il sapere filosofico, se trattiene lo sguardo in s� e non lo rinvia ad un sapere pi� alto, teologico o mistico, � fonte di errori. Bonaventura non � dunque contro la filosofia in genere, bens� contro quella filosofia incapace di cogliere la tensione del finito all�infinito, dell�uomo a Dio, nella concretezza del nostro essere, tendenzialmente orientato alla salvezza, ma esposto costantemente al male.
Il problema di Bonaventura, pertanto, non � quello di avversare l�uso della ragione e ogni filosofia, bens� quello di distinguere �tra una ragione e una filosofia o teologia cristiana e una filosofia non cristiana, tra una ragione che � mezzo della fede alla visione beatifica [�] e una ragione che, chiudendosi in una propria autosufficienza, nega il soprannaturale in s� (T. Gregory). Egli � contro una filosofia non cristiana, contro una ragione autosufficiente che non � capace di cogliere nel mondo il signum, l�orma di Dio: � contrario ad una ragione che ritiene il mondo una realt� totalmente profana e con leggi autonome e autosufficienti. Bonaventura, insomma, compie una scelta consapevole di quella tradizione di pensiero che da Platone, attraverso Agostino e Anselmo, aveva sorretto la riflessione cristiana nel considerare il mondo come un sistema di ordinate rispondenze, come un tessuto di significati e di rapporti allusivi a Dio uno e trino, e l�uomo come l�inquieto pellegrino dell�Assoluto tripersonale.
A che serve una filosofia che non renda pi� evidente la presenza di Dio nel mondo e non porti a compimento l�aspirazione dell�uomo alla conoscenza e al possesso di Dio? L�esercizio della ragione � salutare se ci consente di scoprire nel mondo e in noi stessi quei germi divini che poi la teologia e la mistica portano a completa maturazione. Il programma di Bonaventura, che � a fondamento delle sue scelte filosofiche, � costituito dal �quaerere Deum� che �relucet� e �latet� nelle cose, che si manifesta e si nasconde, e intorno al quale deve compiersi lo sforzo della �meditatio�, secondo la tradizione monastica, come prologo alla �consummatio�, costituita dalla visione beatifica. La scienza filosofica, che Bonaventura cerca e, a suo modo, elabora, � dunque �via alle altre scienze�, costituite dalla teologia e dalla mistica, di cui la filosofia � appunto prologo e strumento.
Verso quale filosofia S. Bonaventura � diffidente? Verso la filosofia aristotelica che, nella versione averroista, aveva mostrato tutta la sua forza corrosiva nei riguardi del pensiero cristiano. Bonaventura aveva studiato Aristotele nella Facolt� delle Arti, cui si era scritto nel 1235, quando l�ingresso delle opere dello Stagirita poteva dirsi completo. Qui, infatti, nella Facolt� delle Arti, �Aristotele era ben presente con la Logica vetus e la Logica nova a fianco di Porfirio, di Boezio e del Liber sex principiorum. Aristotele era parimenti presente con i libri I, III dell�Etica Nicomachea, con la Metafisica e i Libri naturales, che malgrado il divieto di Gregorio IX, erano insegnati a Parigi� (J. G. Bougerol).
Bonaventura aveva quindi studiato Aristotele e dunque lo conosceva soprattutto nella versione averroista. Egli, per�, pur apprezzando i suoi molti contributi allo studio della natura, ne respinse lo spirito e gli orientamenti generali, perch� estranei alla vicenda e al destino del cristiano. Aristotele � un�autorit� nel campo della fisica, non per� in quello del sapere filosofico, nel quale l�autorit� spetta a Platone e, superiore a entrambi, ad Agostino: �inter philosphos datus sit Platoni sermo sapientiae, Aristoteli vero sermo scientiae; uterque autem sermo, scilicet sapientiae et scientiae [�] datus sit Augustino�, cos� leggiamo in Christus unus omnium magister. Bonaventura, dunque, sceglie la tradizione platonico-agostiniana contro quella aristotelica, perch� per la prima la filosofia � apertura alla Trascendenza, � la teorizzazione dell�anelito delle cose e del-l�uomo a Dio e, nel ripensamento agostiniano, chiarimento delle implicazioni esisten-ziali della fede; per la seconda, invece, la filosofia � riflessione autonoma e, per molti versi, chiusa in se stessa e, pertanto, deviante. La filosofia di ispirazione aristotelica non poteva sorreggere lo sforzo di Bonaventura di connettere strettamente le componenti filosofiche con quelle teologiche, l�elemento rivelato con quello razionale. Egli andava alla ricerca di una filosofia che alimentasse la sua religiosit�, il suo abbraccio costante con la teologia, il suo misticismo, quel calore affettivo, per cui ogni passo � insieme un atto di intelligenza e un atto di amore. Nel quadro della tradizione monastica e dello spirito religioso portato da Francesco d�Assisi, Bonaventura, di fronte alle tradizioni filosofiche pi� autorevoli, opta per quella platonica e respinge, dunque, quella aristotelica.
9. Ancora San Bonaventura: un cristiano non pu� pensare mettendo tra parentesi la propria fede
�Le tesi fondamentali di San Bonaventura derivano da Sant�Agostino, considerato come il pi� illuminato interprete di quella Scrittura in cui risiede la norma della verit�. Bonaventura infatti (come gi� Agostino e, a differenza di San Tommaso), non ammette una autonomia della natura dalla sua radice divina, e, quindi, neppure dalla ragione naturale, la quale giunge a conoscere solo grazie alla presenza illuminante di Dio� (V. Mathieu). Bonaventura, in breve, prende sul serio la Rivelazione. Ed � a partire dal Cristo che Bonaventura guarda e legge la storia dell�uomo e dell�universo intero. E �una volta che l�anima ha preso coscienza di questa impressionante verit� � commenta Gilson � essa non solamente non pu� pi� dimenticarla, ma essa non pu� pi� pensare a niente se non in rapporto a siffatta verit�; le sue conoscenze, i suoi sentimenti, le sue volont� si trovano illuminati da una luce tragica; il cristiano vede un destino che si decide l� dove l�aristotelico non vede che una curiosit� da soddisfare. San Bonaventura, prosegue Gilson, �, da parte sua, profondamente penetrato da questo sentimento tragico [�]. Egli pensa perch� � per lui un problema di vita o di morte eterna quello di sapere di pensare ad altre cose; � sopraffatto dall�angoscia nel vedere che l�opera creata da Dio, riparata dal sangue di un Dio, viene ogni giorno ignorata e disprezzata�. Il pensiero (per San Bonaventura), dice ancora Gilson, �deve dunque essere uno strumento di salvezza e niente altro; che esso metta il Cristo al centro della nostra storia come Egli � al centro della storia universale, non dimenticher� mai che un cristiano non pu� pensare niente come lo penserebbe se egli non fosse cristiano�. Ed � cos� che comprendiamo il concetto di filosofia cristiana in Bonaventura. �La filosofia non comincer� senza il Cristo, perch� � Lui che ne � la fine. Essa si trova dunque davanti alla scelta o di condannarsi sistematicamente all�errore o di tener conto di fatti di cui essa � ormai informata�.
La filosofia di Bonaventura �, dunque, una filosofia cristiana. Bonaventura � un Cristiano che filosofa, e non un filosofo che � anche Cristiano. Bonaventura � un mistico. Egli guarda il mondo con gli occhi della fede. La ragione � un instrumentum fidei; la ragione legge ci� che la fede illumina; la ragione � una grammatica scritta con l�alfabeto della fede. Per tutto questo ben si comprende come la filosofia di San Bonaventura e quella di San Tommaso � almeno in certa tradizione interpretativa � siano, in qualche modo, per usare un�espressione dell�epistemologia contemporanea, incommensurabili. Certo, ci sono dei punti in comune: sono due filosofi cristiani e ogni minaccia contro la fede li trova uniti. �Si tratta del panteismo? L�uno e l�altro insegnano la creazione ex nihilo e affermano una distanza infinita tra l�essere per s� e l�essere partecipato. Si tratta dell�ontologismo? L�uno e l�altro negano formalmente che Dio possa essere visto dal pensiero umano in questo mondo [�]. Si tratta di fideismo? L�uno e l�altro oppongono ad esso lo sforzo pi� completo dell�intelligenza per provare Dio e interpretare i dati della fede. Si tratta del razionalismo? L�uno e l�altro coordinano lo sforzo dell�intelligenza all�atto di fede e sostengono l�influenza benefica dell�atto di fede sulle operazioni dell�intelligenza. Accordo profondo, indistruttibile, proclamato dalla tradizione [�] e mai contestato� (�. Gilson). Ma quest�accordo, potremmo dire con i gestaltisti, � sulle linee, non sulla forma. I dati son gli stessi, ma si vedono in una luce differente. Nel 1879 Leone XIII parl� di Tommaso e Bonaventura come di duae olivae et duo candelabra in domo Dei lucentia. Ma quel che subito � da rilevare � che la luce dei due candelabri illumina diversamente le cose. In realt�, l�accordo non � identit� ed � chiaro che queste due dottrine sono organizzate secondo due preoccupazioni differenti; non vedono mai gli stessi problemi sotto il medesimo aspetto. Si tratta di due filosofie complementari: la fede in Dio � unica e i tentativi umani di situarci nella e per la fede sono molteplici. La fede, insomma � possiamo dire noi � � liberante: ci consente e ci impone di essere interpreti creativi, nella consapevolezza che i nostri tentativi sono e restano umani, non assoluti e relativi alla cultura dell�epoca, ai mezzi espressivi a disposizione dell�interprete.
10. La rilevanza della grande tradizione del pensiero francescano
La nostra storia, la storia dell�intellettualit� cristiana, � colma di sofferenze causate da tanta nostra presunzione. La tentazione integralista ha fatto le sue vittime. Tentazione consistente nella seguente affermazione: la mia interpretazione della fede � la fede; o in quest�altra affermazione: senza la mia filosofia la fede non trova un fondamento, � solo una favola illusoria.
Dunque: senza il fondamento di questa o quella filosofia la fede non sarebbe nient�altro che �una specie di puro impegno emotivo�, �una fabulazione pi� o meno vaga e mitica�; in altri termini, si � preteso di affidare �al discorso breve e rigoroso del metafisico la sorte di una cosa tanto grande, quanto pu� esserlo una fede religiosa, il senso stesso della vita, il significato medesimo dell�intera civilt� cristiana�.
Di fronte a posizioni del genere, c�� da chiedersi: ma a fondamento della fede c�� Cristo ovvero, per esempio, Aristotele? Nel maggio del 1996, l�allora cardinale Joseph Ratzinger tiene a Guadalajara, in Messico, una conferenza in occasione dell�incontro tra la Congregazione della Dottrina della Fede e i Presidenti delle Commissioni per la Dottrina della Fede della Conferenza Episcopale dell�America Latina. Di questa Conferenza � apparsa successivamente sia su l�Osservatore Romano (27 ottobre 1996) che su La Civilt� Cattolica (quaderno 3515, IV, 1996), con il titolo La fede e la teologia ai giorni nostri, ecco la conclusione sul tema dei rapporti tra ragione e fede: �Ritengo che il razionalismo neoscolastico sia fallito nel suo tentativo di voler ricostruire i Praeambula Fidei con una ragione del tutto indipendente dalla fede, con una certezza puramente razionale; tutti gli altri tentativi, che procedono su questa medesima strada, otterranno alla fine gli stessi risultati. Su questo punto aveva ragione Karl Barth, nel rifiutare la filosofia come fondamento della fede, indipendentemente da quest�ultima: la nostra fede si fonderebbe allora, in fondo, su mutevoli teorie filosofiche�. Nel volume Il sale della terra sempre l�allora cardinale Ratzinger scrive che �La sostanza di questa fede � che noi riconosciamo in Cristo il Figlio di Dio, vivente, incarnato e divenuto uomo; che per mezzo suo crediamo in Dio, il Dio della Trinit�, creatore del cielo e della terra [�]�. Sembrano proprio frasi tratte da San Bonaventura.
C�� un�altra pretesa � quella dell�integralista � dove si afferma: la mia interpretazione della fede � la fede, o, anche: solo la mia filosofia � una filosofia cristiana. Una storia di incomprensioni e di sofferenza. Ed ecco, allora, la Fides et ratio. L�enciclica �, innanzi tutto, una netta presa di distanza da quegli �assoluti terrestri� che hanno preteso di proibire lo spazio della fede, di quelle filosofie che hanno inteso �cancellare dal volto dell�uomo i tratti che ne rivelano la somiglianza con Dio, per condurlo progressivamente o ad una distruttiva volont� di potenza o alla disperazione della solitudine�. Simultaneamente, la Fides et ratio � una difesa della legittimit�, sensatezza, razionalit� e umanit� della domanda metafisica. La filosofia �si configura come uno dei compiti pi� nobili dell�umanit�, giacch� � proprio la filosofia a mantenere vive quelle domande di fondo che caratterizzano il percorso dell�esistenza umana: chi sono, da dove vengo e dove vado? Perch� la presenza del male? Che cosa ci sar� dopo questa vita? �Sono queste domande � diceva il Santo Padre � che hanno la loro comune scaturigine nella richiesta di senso che da sempre urge nel cuore dell�uomo: dalla risposta a tali domande, infatti, dipende l�orientamento da imprimere all�esistenza�. E qui, l�enciclica, pur insistendo sui poteri della ragione umana, ne sottolinea a pi� riprese i limiti. E a chiare lettere afferma che non � dalla ragione che viene la salvezza. La ragione umana pone una domanda � la domanda metafisica � alla quale solo Cristo offre la risposta soddisfacente. Si chiede e chiede il Santo Padre: �Dove l�uomo potrebbe cercare la risposta ad interrogativi drammatici come quelli del dolore, della sofferenza dell�innocente e della morte, se non nella luce che promana dal mistero della passione, morte e resurrezione di Cristo?�.
�La ragione non pu� svuotare il mistero d�amore che la Croce rappresenta, mentre la Croce pu� dare alla ragione la risposta ultima che essa cerca�.
�La fede non � come tale una filosofia [�]. Come virt� teologale, [la fede] libera la ragione dalla presunzione, tipica tentazione a cui i filosofi sono facilmente soggetti�.
�L�uomo si trova in un cammino di ricerca, umanamente interminabile: ricerca di verit� e ricerca di una persona a cui affidarsi. La fede cristiana gli viene incontro offrendogli la possibilit� concreta di vedere realizzato lo scopo di questa ricerca�.
�La conoscenza che essa [Chiesa] propone all�uomo non le proviene da una propria speculazione, fosse anche la pi� alta, ma dall�avere accolto nella fede la parola di Dio�.
Dunque: � la Croce che pu� dare alla ragione la risposta ultima che essa cerca. E, d�altro canto: �Nessuna forma storica della filosofia pu� legittimamente pretendere di abbracciare la totalit� della verit�, n� di porsi come spiegazione piena dell�essere umano, del mondo e del rapporto dell�uomo con Dio�.
�Il fatto che la missione evangelizzatrice abbia incontrato sulla sua strada per prima la filosofia greca, non costituisce indicazione in alcun modo preclusiva per altri approcci�.
�La Chiesa non propone una propria filosofia n� canonizza una propria filosofia a scapito di altre�.
�Le vie per raggiungere la verit� rimangono molteplici; tuttavia, poich� la verit� cristiana ha un valore salvifico, ciascuna di queste vie pu� essere percorsa, purch� conduca alla meta finale, ossi alla Rivelazione di Ges� Cristo�.
E in questo orizzonte ben si comprende la rilevanza, la capacit� di rispondere ad urgenti problemi attuali, di quella via � che � un tratto identitario dell�Europa � e che � costituita dalla grande tradizione del pensiero francescano.
Schweitzer e cassirer: memoria e speranza
di E. Donadon
Introduzione
�Perch� i classici sono la riserva del futuro�, torniamo ad Agonia della civilt� (1923) di Albert Schweitzer ed a Il mito dello stato (1945) di Ernst Cassirer. Li accomuna la radiografia dello �spirito dell�epoca� che ha preparato il terreno di due conflitti mondiali. Alla testimonianza della disumanit� delle guerre, i due pensatori affiancano un progetto per l�uomo e la societ�. Trovano il motivo della comprensione e della vicinanza tra gli uomini nel rispetto per il valore di ogni vita. Affidano all�educazione, secondo questo principio, la speranza per il futuro dell�umanit�.
I testi sono stati scritti negli anni in cui i due filosofi tedeschi erano esuli: Schweitzer, nell�Africa Equatoriale Francese, per mettersi al servizio dell�umanit� e poi nei campi di prigionia francesi; Cassirer, negli Stati Uniti, per sfuggire dall�oppressione nazista.
1. La genesi delle due opere
1.1 Lungo il fiume Ogooy�
Il filosofo, teologo, concertista e medico A. Schweitzer (1875-1965) mette mano ad Agonia della civilt� �il secondo giorno del [suo] internamento� nell�abitazione attigua all�ospedale di Lambar�n�, perch� �suddito germanico ospite di una colonia francese�. In quella stazione missionaria dell�Africa Equatoriale Francese (odierno Gabon), i coniugi Schweitzer erano giunti nel 1913 per curare i lebbrosi e gli afflitti dalla malattia del sonno. Il 5 agosto 1914, quando in Africa giunge la notizia dello scoppio della Grande Guerra, le autorit� del Gabon considerano gli Schweitzer prigionieri di guerra. Chiuso l�ospedale, il medico-missionario ha quindi il tempo di riflettere sulla situazione in Europa e di formulare la sua diagnosi circa la malattia del genere umano che � sfociata nella guerra. Egli ipotizza che il conflitto mondiale sia �la tragica conseguenza di un processo di decadimento spirituale della civilt� moderna legato alla mentalit� non etica (irrazionale) degli individui e delle nazioni. L�irresponsabilit� etica, legata ai pregiudizi ed alle passioni politiche, ha reso impossibile la soluzione razionale delle controversie internazionali. La Prima Guerra mondiale � scoppiata perch�: �I governanti grandi o piccoli agirono secondo lo spirito del tempo�. A ci� ha contribuito la filosofia, non pi� �guida� della ragione nell�epoca del rapido progresso della scienza e della tecnica, dell�ideologia economica e del mito del superuomo. Cos�: �La creatura sovroccupata, non pi� capace di vero raccoglimento, che � l�uomo moderno, � caduta in balia dell�asservimento spirituale, di ogni sorta di esteriorizzazione, di un�errata valutazione della storia e della realt�, del nazionalismo da questa derivante, di una spaventosa assenza di umanit�1. La terapia appropriata per l�uomo in crisi d�identit� � perci� quella di aiutarlo a ritrovare la fiducia in se stesso. Contro lo spirito dell�epoca che lo spinge allo scetticismo nei confronti del proprio pensiero: �Dobbiamo � dice Schweitzer - ritornare ad una visione del mondo che racchiuda in s� gli ideali della civilt� autentica (�) tutto ci� che � compreso nei concetti di amore, dedizione, compassione, gioia ed anelito comune�2. Nel principio evangelico dell�amore, egli trova �la scintilla� che riaccende il fuoco del pensiero mentre educa l�uomo alla responsabilit� naturale e fattiva verso se stesso ed ogni altra forma del creato. E� dunque �sulla via del pensiero�, o dell�etica, colui che riflette sulla propria vita di creatura e sulle altre del creato e trova in questa coesione del mondo il motivo per sentirsi utile al prossimo, alla societ� ed alla nazione. �Il vero cuore riflette e l�autentica ragione ha sentimenti�3, dice Schweitzer. Ascoltandoli, ogni persona pu� sperare nel futuro dell�umanit�, in un presente segnato dalla disumanit� della guerra.
Alla fine dell�estate 1915, Schweitzer trova all�improvviso l�espressione che riassume il concetto �elementare� ed �universale� dell�etica e dell�affermazione d�ogni vita che andava cercando. Succede, durante un viaggio in piroscafo che il medico-missionario compie lungo le acque del fiume Ogooy� per raggiungere un ammalato. Egli ricorda che mentre il pilota manovrava il piccolo piroscafo per aprirsi un passaggio fra un�orda di ippopotami che si muovevano nella stessa direzione dell�imbarcazione, gli � venuta in mente d�un tratto la frase: rispetto per la vita. Nasce da quest�esperienza vissuta l�espressione che ricapitola l�essenza di un�etica universale. Per Schweitzer, la norma morale del rispetto per la vita assegna ad ogni uomo la responsabilit� per la conservazione e l�affermazione delle infinite volont� di vita presenti nel creato. Essa infatti presuppone la fondamentale forza di sopravvivenza presente in ogni creatura: �Io sono un essere vivente che vuole vivere, circondato da altri esseri viventi che vogliono vivere�4. Solo l�uomo che riflette sulla vita, data da Dio, e la ritrova in tutti gli esseri del mondo agisce in modo �naturale� e �sincero� restando fedele a se stesso.
Lasciati a Lambar�n� i primi appunti, scritti in tedesco, sul rapporto tra etica e civilt� moderna, l�impegno di Schweitzer prosegue nel campo di prigionia di Bordeaux, dove il filosofo � trasferito nel settembre 1917; poi nel campo di concentramento di Garaison (Pirenei) ed infine in quello di St. Remy de Provence (1918) dove rimane fino alla fine del conflitto mondiale. �Quante notti, seduto a tavolino, pensai, meditando e scrivendo, a coloro che giacevano nelle trincee�5, ricorda. Il suo contributo alla pace � racchiuso nell�etica del �Rispetto per la volont� di vita in me e fuori di me�6: la parola di Ges� contro l�irrompere di tragedie immani.
In un mondo che � �l�orrendo nello splendore, l�assurdo nel comprensibile, la sofferenza nella gioia�7, e che resta sempre �enigmatico� per l�uomo, ognuno coglie in s� ed intorno a s� solo il mistero della vita racchiuso in quell�istinto indefinibile di conservazione che anche gli animali possiedono. La vera conoscenza della vita e del mondo consiste dunque nella docta ignorantia dei mistici del Medioevo. �La dotta ignoranza della mistica etica � ignoranza in quanto si rassegna a non capire niente del mistero del mondo. E� dotta perch� sa che l�unica cosa che ci sia possibile sapere e che ci sia necessario sapere � che tutto quel che esiste � vita e che votandoci agli altri esseri noi realizziamo l�unione spirituale con l�Infinito che contiene in s� tutte le esistenze�8. Dalla constatazione che solo attraverso l�etica, lo spirito umano pu� comunicare con lo Spirito universale, nasce il dovere per l�uomo di operare prima di tutto in se stesso. Attraverso l�auto-perfezionamento etico gli deriva �una segreta auto-affermazione spirituale (�) un�insospettata libert� di fronte alle vicende della vita (�) la felicit� dell�essere-libero-dal-mondo�9 e la libert� di dedicarsi con gioia alla vita degli altri.
Il 23 febbraio 1919, Schweitzer presenta per la prima volta al pubblico la massima morale del Rispetto per la vita, in una meditazione tenuta nella chiesa di St. Nicolai a Strasburgo. �E� bene mantenere e promuovere la vita; � male ostacolare e distruggere la vita� ne � l�esordio. Nel 1923, viene pubblicato Agonia della civilt� �prima parte di una completa filosofia della civilt�.
Nel 1924, il medico-missionario ritorna a Lambar�n�. Si pone di nuovo al servizio della vita: ricostruisce l�ospedale, cura le malattie, combatte il potere degli stregoni, insegna agli indigeni a strappare i terreni coltivabili dalla giungla e fornisce loro i primi rudimenti di economia. �L�agricoltura e l�artigianato sono il muro di fondazione della civilt�10. A questo proposito J. Gollomb, in A. Schweitzer il genio nella giungla, riferisce che il modo di lavorare del medico era stato d�esempio per Oyembo, l�indigeno che traduceva i suoi sermoni in lingua locale ed insegnava ai bambini del villaggio. Costui aveva avviato con successo una societ� commerciale, per la vendita di legname, di cui facevano parte gli abitanti del villaggio.
Con la coerenza della sua esistenza, Schweitzer indica quindi il Rispetto per la vita come il fondamento etico che trascende l�individuo, lo Stato e la nazione. Senza di questo �grande� e �semplice� comandamento non c�� civilt�.
1.2 Gli amici americani di Cassirer
Alle riflessioni di Schweitzer avrebbe fatto eco di l� a poco Cassirer (1874-1945), filosofo neokantiano della Scuola di Marburgo. Egli ritiene, infatti, che le condizioni spirituali esistenti in Germania, nel periodo tra le due Guerre Mondiali, non possano essere descritte �in maniera migliore e pi� efficace� che con le parole pronunciate da Schweitzer, quando l�infuriare della Prima Guerra mondiale sembrava �un segno del tramonto della civilt�.
La filosofia non � stata �guardiano� e �guida� della ragione neppure negli anni successivi alla Grande Guerra, annota Cassirer, perch� i filosofi sono rimasti �imprigionati� nelle sottigliezze della filosofia dimenticando il suo nesso con i problemi pi� urgenti dell�uomo. Essa non � stata in grado di assolvere il suo pi� importante compito educativo. �Non ha insegnato all�uomo come sviluppare le sue facolt� attive al fine di formare la sua vita individuale e sociale�11 nell�epoca in cui la frammentazione e la specializzazione delle ricerche sull�uomo scatenata dall�evoluzione della scienza e l�ideologia economica hanno reso l�uomo insicuro, succube della massa e del nazismo. La filosofia ha quindi il compito di aiutarlo a riacquistare fiducia in se stesso, tramite la conoscenza dell�energia del pensiero (il simbolo) che produce le opere della cultura. Cassirer trova nel concetto di uomo inteso come animale simbolico una definizione che compendia le molteplici forme di vita spirituale che lo caratterizzano. Il mito, la religione, l�arte, il linguaggio, la storia e la scienza sono le singole forme simboliche di una totalit� (cultura) che l�uomo ha progressivamente sviluppato per giungere alla civilt�. Sono variazioni di un tema comune: la capacit� umana di allontanarsi dalla forme espressive pi� immediate ed emotive (i miti) per conquistare la razionalit� scientifica. Ci� che lo affranca dalla sua natura animale � l�atteggiamento critico verso se stesso ed il mondo.
La filosofia ha cos� di nuovo il compito di aiutare l�uomo ad autoliberarsi dalle forme irrazionali del mito: le armi �spirituali� che essa ha fornito ai politici tedeschi per scalzare il pensiero razionale. Secondo Cassirer, nel periodo tra la Prima e la Seconda Guerra mondiale, le armi non sono mai state deposte. Hanno solo assunto una forma pi� sottile e sofisticata. I capi politici hanno utilizzato il mito, mascherato in forme nuove (linguaggio, riti, profezie) per completare e perfezionare le armi materiali ed obbligare gli individui all�azione decretata dall�alto. In mano loro i nuovi miti (convinzioni non razionali e aspirazioni della collettivit�) sono diventati strumenti razionali di distruzione della volont� e della libert� individuale. I politici hanno accentuato di proposito la componente emotiva del mito per screditare il pensiero critico degli individui, far prevalere il potere dello Stato sull�individuo e sopprimere il senso stesso della libert�. Per Cassirer, ci� � alla base della crisi politica e sociale che ha portato le nazioni alla Seconda Guerra mondiale.
La teoria che chiarisce l�origine, la natura e la funzione del mito nella vita politica del Novecento, cio�: �La preponderanza del pensiero mitico sul pensiero razionale in alcuni nostri sistemi politici moderni� � proprio il tema di Il mito dello stato. Negli anni di crisi della cultura e della storia mondiale, Cassirer assegna alla filosofia il compito etico di �guardiano� della ragione. �Perennemente in via di attualizzazione�, l�autentica natura della ragione �dobbiamo ricercarla nell�eterna opera dell�autorinnovamento dello spirito�12, afferma Cassirer, come gi� Schweitzer.
I due pensatori si conoscevano e, nel 1933, le loro strade si incontrano ad Oxford: di ritorno in Europa dall�Africa, Schweitzer; proveniente da Amburgo, Cassirer. Per Schweitzer la citt� inglese � una tappa del suo itinerario europeo di conferenze e concerti a sostegno dell�ospedale di Lambar�n� in cui � tornato ad operare come medico-missionario dopo la parentesi della Grande Guerra. Per Cassirer, d�origine ebrea, Oxford � una tappa della sua �odissea� accademica iniziata presso le Universit� di Marburgo, Berlino e Amburgo. La fuga dall�oppressione nazista lo porta da Amburgo all�All Souls College di Oxford, poi all�Universit� di G�teborg ed infine a Yale ed alla Columbia University dove rimane fino alla morte (1945). Il mito dello stato � l�ultimo libro che il filosofo scrive in difesa dell�autonomia e della libert� di pensiero. Tra il 1944 e il 1945, negli Stati Uniti, �per venire incontro a una istanza dei suoi pi� intimi amici americani�, egli interpreta la vita politica moderna mentre illustra il rapporto tra il mito e le altre forze culturali. �Finch� queste forze intellettuali, etiche e artistiche sono in pieno vigore � dice - il mito � domato e soggiogato. Ma non appena esse cominciano a perdere vigoria, il caos ritorna�13. Solo attraverso la cultura si pu� costruire un mondo nuovo, perch� nell�ambito delle sue forme simboliche pu� avvenire la progressiva autoliberazione dell�uomo dai vincoli dell�irrazionalit�. Il suo progetto per l�uomo nella societ� si avvicina all�impegno di Schweitzer in difesa della vita, della libert� di pensiero e della pace nel mondo tanto � vero che Cassirer lo definisce: �l�incarnazione per eccellenza dell�Ethiker nella societ� contemporanea�14.
Oggi �l�urgenza� dei tempi chiede ancora che la filosofia sia la forza dell�uomo: non pu� starsene in disparte, �muta e inerte�. Deve aiutare l�uomo ad interrogarsi circa il senso della vita, la natura del bene e del male, il suo rapporto con gli altri uomini e con tutto il creato. La riflessione rende l�uomo libero di vagliare criticamente le proposte della societ� per ricercare la verit� delle questioni e mettersi al suo servizio. Cos�, anche nel nostro tempo, l�etica del Rispetto per la vita pu� includere e richiamare un sempre nuovo risveglio alla vita secondo le parole di Schweitzer: �Quando in primavera al grigio arido dei pascoli si sostituisce il verde brillante, vuol dire che milioni di germogli spuntano freschi dalle vecchie radici. Nello stesso modo un rinnovamento del pensiero, essenziale per il nostro tempo, pu� realizzarsi soltanto attraverso la trasformazione delle opinioni e degli ideali della maggioranza mediante una riflessione individuale e generale sul significato della vita e del mondo�15.
2. A. Schweitzer
2.1 I barbari Stati civili
�Quando gli eventi inesorabilmente ci richiamano al fatto che stiamo vivendo in un pericoloso e tumultuoso momento, tra civilt� e barbarie, dobbiamo, lo si voglia o no, cercare di determinare la natura della vera civilt�16. Cos� Schweitzer in Agonia della civilt� dove affronta la questione della decadenza spirituale della civilt� moderna e del suo ripristino partendo dal presupposto che essa ha carattere essenzialmente etico. �Il principio fondamentale del bene consiste nel fatto che ci impone di mantenere la vita, di incrementarla e di innalzarla al suo valore pi� alto; e compiere il male significa: distruggere la vita, nuocere alla vita, impedirne lo sviluppo�17.
Secondo questa prospettiva, l�origine della civilt� si deve alla mentalit� �etica e positiva� degli individui che si sono messi al servizio della vita e del mondo con �entusiasmo e abnegazione� per il progresso spirituale e materiale dell�uomo. Questa dedizione senza riserve obbliga l�uomo ad operare prima di tutto su se stesso, perch� solo il dominio di s� lo rende libero e capace di agire per amore della vita, �con forza pi� alta e pi� pura�. Nella tensione etica l�individuo acquista valore come persona e le sue riflessioni circa il significato di ogni vita prendono consistenza in azioni concrete per l�affermazione della ragione sulle inclinazioni umane e sulle forze della natura. �Il progresso morale � quindi l�essenza stessa della civilt�. Mancando il fondamento etico, la civilt� crolla.
�Oggi viviamo sotto i segni del crollo della civilt�. Ci� non � conseguenza della guerra, anzi questa non � che un sintomo�18 di un�epoca che ha dimenticato i valori etici di cui � stata portatrice la filosofia, ha screditato il pensiero individuale ed ogni forma di razionalismo e liberalismo. La Prima Guerra mondiale � scoppiata perch� �i governanti grandi o piccoli agirono secondo lo spirito del tempo� caratterizzato dalle conquiste materiali della scienza e della tecnica e determinato dalla Realpolitik che ha calpestato i diritti dell�uomo enunciati nel XVIII sec. ed ha forgiato l�opinione pubblica �seguendo la morale dei dominatori, cio� la volont� di potenza�. Cos�, l�uomo moderno, condizionato dall�enorme sviluppo delle scienze del XX sec., assillato dal lavoro e dalla retorica del superuomo, � diventato scettico nei confronti del proprio pensiero. Abbandonato il senso critico, fa sua la mentalit� della massa. L�uomo moderno si � trasformato in un �non-uomo�. Ricettivo ai dettami della propaganda politica, egli accetta la verit� decretata dall�alto senza riflettere perch� il suo pensiero non � pi� guidato dalla filosofia. �Un tempo la filosofia era un attivo operaio che creava convinzioni universali riguardanti la civilt�19, scrive Schweitzer. Dalla met� del diciannovesimo secolo, le �idee elementari� circa l�uomo, la societ�, la razza, l�umanit�, la civilt� non si sono pi� trasformate in �vivente� filosofia del popolo come avveniva nell�et� degli illuministi. Da allora, la filosofia ha perso lo �spirito creativo� e �si fa studio che filtra i risultati delle scienze storiche e naturali�. Il legame logico con il mondo si � interrotto. Essa non esorta pi� gli uomini a porsi di fronte ai problemi sociali con spirito critico per ricercarne la verit�. Non li induce a lottare per sostenere quella visione etica del mondo e della vita sulla quale poggia la civilt�. �Nell�ora del pericolo il guardiano che avrebbe dovuto tenerci svegli dormiva, cosicch� noi non opponemmo resistenza alcuna (�) all�opinione pubblica tenuta in vita dalla stampa, dalla propaganda, dalle organizzazioni, dal denaro e da altri mezzi a sua disposizione�20.
Il declino della civilt� � dunque legato all�abdicazione del pensiero critico, alla mentalit� collettiva che �fiacca� il sentimento di umanit� degli individui ed al �tipo del nostro progresso�. Il vero progresso della civilt� presuppone uomini liberi di mettere la propria creativit� al servizio dell�affermazione della vita e del mondo. L�uomo moderno invece � uno �strumento� di lavoro incapace di riflessione e di creativit�. �Occupare il poco tempo libero in un�opera d�auto-educazione, in seria compagnia di amici e di libri, richiede un raccoglimento mentale e un auto-controllo che l�individuo non possiede. L�ozio completo, l�oblio di se stesso e della quotidiana attivit� rappresentano allora una necessit� fisica�. Egli cerca cos� il divertimento che non fa pensare, aggregandosi. E �la mentalit� della massa, spiritualmente depressa e incapace di raccoglimento interiore, agisce su tutte le istituzioni che dovrebbero servire la causa della cultura e con essa quella della civilt�21. A questa mentalit� che �spersonalizza� l�individuo danno alimento il teatro, i periodici, i giornali che espongono gli argomenti nella forma pi� facilmente assimilabile dai lettori invece di indurli alla riflessione. Lo spirito della �superficialit�� dilaga, dunque, nella societ� moderna per l�assenza di libert� e di concentrazione mentale dell�individuo che associa alle lacune della formazione intellettuale l�incapacit� d�ogni sollecitudine nei confronti del prossimo, dei valori etici e della civilt�. Egli subordina la propria personalit� e le idee allo spirito di gruppo perch� ritiene una �conquista� la sua dipendenza dalla mentalit� collettiva. L�individuo � portato a credere che la sua �devozione� agli interessi della collettivit� salvi la �grandezza� dell�uomo moderno, anche perch� le opinioni predominanti della societ� organizzata, determinate dalla nazionalit�, dal credo, dal partito politico, dalla posizione sociale e da altri fattori dell�ambiente sono �protetti da una sorta di tab� e non solo stanno al di sopra di qualsiasi critica, ma neanche possono costituire legittimo argomento di conversazione�22. L�individuo non oppone pi� resistenza, non ricerca la verit� delle questioni lasciandosi guidare da ogni affermazione della propaganda politica elevata a �dignit�� di opinione pubblica. �Cos� siamo entrati in un nuovo Medioevo�, afferma Schweitzer. Rinunciando all�atteggiamento critico, l�uomo � pronto a giustificare qualsiasi crudelt� ingiustizia o follia in nome della propria nazione. �Senza averne coscienza, la maggioranza dei cittadini dei nostri barbari Stati �civili� concede sempre minor tempo alla riflessione morale per evitare di cadere in intimo dissidio con la collettivit� e di dover cos� ogni momento reprimere dubbi di coscienza�23. Inoltre, l�opinione pubblica diffonde l�idea che: �Le idee della collettivit� devono essere giudicate non gi� secondo valori etici, ma secondo il metro della convenienza. Cos� l�individuo reca ingiuria alla propria anima�. E mentre la societ� schiaccia gli individui invece di sorreggerli, come avveniva nell�epoca del razionalismo e della �grande� filosofia, le idee etiche su cui poggia la civilt� �vanno attorno povere e nude�. Schweitzer scrive: �Il fallimento dello Stato incivilito, sempre pi� evidente man mano che gli anni passano, sta rovinando l�uomo d�oggi; la demoralizzazione dell�individuo per opera della societ� � in pieno corso�24. Per superarla, gli uomini devono di nuovo imparare a riflettere su se stessi e sul mondo. �La rinuncia a pensare � una dichiarazione di fallimento spirituale�.
2.2 Il nazionalismo
L�essenza della civilt� dipende dalla disposizione mentale etica degli individui e delle nazioni, si legge sempre in Agonia della civilt�. L�affermazione del filosofo va contro la �superficiale� convinzione diffusa dai pensatori del suo tempo, secondo i quali la civilt� � solo la manifestazione della naturale evoluzione umana legata alle conquiste scientifiche, tecniche ed artistiche degli uomini. Per questo motivo, scrive Schweitzer, negli anni precedenti la Prima Guerra mondiale: �Invece di discutere insieme gli elementi essenziali, che decidono il carattere dello sviluppo sociale - Popolazione, Stato, Chiesa, societ�, progresso - ci accontentammo dei dati empirici. (�) Cos� ideali che erano stati scientificamente ridotti dominarono la nostra vita spirituale e il mondo intero�25. In questa situazione, la concezione etica della civilt� � venuta meno e l�individuo, privo di ideali attuabili, non � stato pi� capace di distinguere i valori reali da quelli immaginari. Egli ha reagito ai fatti in modo irrazionale, senza vagliarli criticamente per tentare di ricercarne la verit�. E gli storici invece di richiamare l�individuo �a riflessivo apprezzamento dei fatti; invece di porsi quali educatori non sono rimasti che studiosi�26. Secondo il filosofo, la generazione degli storici del suo tempo non ha senso storico: non ha �obiettivit� critica di fronte agli eventi remoti e recenti�27. Essi attribuiscono al passato un peso maggiore del presente, pretendono di dedurre dal passato le opinioni e le passioni del presente e propongono �una storiografia manipolata ad uso popolare, in cui le attuali idee nazionali e confessionali sono accolte ed esaltate senza riserva; i nostri libri di storia sono fonte inesauribile di menzogne storiche. (�) E� naturale che una generazione educata da tali insegnanti non abbia una concezione elevata e pratica degli eventi�28. Schweitzer accusa ancora gli storici di dare fondamento storico agli eventi passati che non possono essere giustificati dalla ragione. In tal modo le idee e le convinzioni non razionali che essi propongono sono elevati a religione.
�Il nazionalismo, al quale si deve la tragica condizione esterna in cui si compie il declino della civilt�, � sorto appunto dal nostro senso della realt� e dal nostro senso storico. Cos�� il nazionalismo? E� ignobile patriottismo, esasperato sino a perdere ogni significato; in rapporto al patriottismo nobile e sano, sta come l�idea fissa di un imbecille rispetto ad una convinzione normale�29, scrive il filosofo. Il nazionalismo si � sviluppato a partire dal diciannovesimo secolo quando l�idea di nazionalit� � stata elevata a valido ideale di civilt�. L�idea di nazionalit� si � poi trasformata con la decadenza della civilt�. �Infine il nazionalismo non si accontent� di mettere da parte, nella sfera politica, ogni tensione verso una societ� veramente civile: distrusse la stessa idea di civilt� e parl� di civilt� nazionale�30. Senza la guida degli ideali morali, ma solo degli �istinti� radicati nella realt�, le idee e le aspirazioni nazionali salvaguardavano solo i sentimenti delle masse. Continua Schweitzer: �Il nazionalismo non poggia tanto sui fatti quanto sulla forma che questi assumono nell�immaginazione delle masse; ci� � evidente dalla sua stessa condotta. (�) La sua Realpolitik � sopravvalutazione di alcune questioni relative a interessi territoriali ed economici, sopravvalutazione elevata a dogma, idealizzata e sorretta dalla passione popolare. (�) La Realpolitik, quindi, � politica irreale perch� permette l�intervento della passione popolare che rende insolubili le questioni pi� semplici. Dispone in vetrina gli interessi economici e tiene in magazzino le idee di grandezza e di conquista proprie del nazionalismo�31. Queste idee sono emerse nel momento in cui tra le nazioni �civili� d�Europa, la lotta di predominio � diventata lotta per la civilt� nazionale. �Il volere una civilt� nazionale � sintomo morboso, significa che i popoli civili d�oggi hanno perduto la loro sana natura e non seguono pi� istinti, ma teorie�32. Il carattere di un popolo � tanto accentuato da farlo diventare �un artificio, una moda, un autoinganno, una mania. (�) Le nazioni moderne cercano mercati per la propria civilt� non meno che per i propri manufatti�33. In questo modo, le nazioni civili, nonostante le loro diverse strutture politiche e sociali, sono tutte sprofondate nella barbarie. Per uscirne non � sufficiente riformare le istituzioni della vita pubblica e sociale della nazione perch�, continua Schweitzer, i progetti di riforma sono sempre diversi tra loro. Ad esempio: �Un gruppo espone un piano anti-democratico, un altro ritiene che gli errori derivino dal fatto che i principi democratici non sono ancora stati applicati con rigore, un altro ancora vede salvezza solo in una organizzazione socialista o comunista della societ�34. Ogni gruppo politico crede che uno spirito nuovo possa sorgere da una nuova organizzazione della societ�; ma, per il filosofo, i valori spirituali non sono mai generati dai fatti imposti dall�esterno bens� dalla mentalit� etica degli individui che compongono la societ�. Essa si mostra nella comprensione e nella fiducia reciproca e nella decisione degli individui di voler risolvere i problemi con la riflessione critica. �Lo Stato potr� riprendere le sue funzioni cui � chiamato soltanto se la critica nei suoi confronti verr� esercitata da molti. (�) La vera forza per lo Stato, cos� come per l�individuo, sta nella spiritualit� e nell�etica. Uno Stato vive della fiducia di coloro che ne fanno parte e della fiducia degli altri Stati�35.
2.3 Il ripristino della civilt�
�L�unico modo di ricostruire il mondo � quello di trasformarci in uomini nuovi anche se sotto il peso delle vecchie circostanze, e poi, come societ�, di entrare in una disposizione di spirito che smussi i contrasti tra le nazioni e renda possibili le condizioni di una vera civilt�36, scrive ancora Schweitzer in Agonia della civilt�. Contro la concezione pessimistica di coloro che denunciano la decadenza della civilt� per vecchiaia, il filosofo propone la sua concezione etica che ha fede nelle capacit� dell�uomo di rinnovarla E contro gli storici che ritengono la rinascita della civilt� un�impresa impossibile egli afferma che dalla storia si pu� dedurre solo ci� che � stato non ci� che accadr�. Tuttavia il ripristino della civilt� richiede il coraggio di ammettere il suo declino per applicare poi alla situazione del tempo gli ideali che erano gi� un suo patrimonio.
Un tempo, ogni scienziato era anche un pensatore che indirizzava la vita spirituale della sua generazione. Ma ecco che �la nostra et� � riuscita a separare sapere e pensiero con la conseguenza che abbiamo una scienza libera, ma non pi� una scienza che rifletta�37. Essa ritiene che solo l�accertamento dei fatti particolari sia di sua competenza. Prosegue Schweitzer: �Quello che pu� salvarci dalla barbarie � un movimento etico e i valori etici prendono radici solo nella personalit� individuale�38, non nella mentalit� collettiva. La civilt� dunque si riprender� quando l�individuo si far� �persona indipendente nella superorganizzazione che lo tiene avvinto in mille modi. La collettivit� ricorrer� ad ogni espediente per mantenerlo in una condizione spersonalizzata; essa, infatti, teme la personalit� perch� in questa lo spirito e la verit� trovano il mezzo di esprimersi. Sfortunatamente il potere della societ� � grande quanto la sua paura�39. La �tragica� alleanza tra la societ� e le condizioni materiali tendono a fare dell�uomo un essere privo di libert�, d�indipendenza, di raccoglimento interiore. L�individuo, al contrario, ha solo il suo senso critico per mettersi al servizio della verit� e della vita. Solo in questo modo, egli pu� tentare di combattere la propaganda politica e le passioni nazionalistiche per mantenere la fiducia nello Stato civile e pu� sperare nella giustizia e nella moralit� politica in un�epoca in cui �non solo le istituzioni, le associazioni laiche e religiose, ma gli stessi uomini cui si guarda come a guide continuamente ci deludono, quando gli artisti e gli studiosi si rivelano difensori di barbarie e persone che passano per pensatori, ed esteriormente si comportano come tali, in tempi di crisi si rivelano scrittori d�accademia�40.
Ogni epoca riceve le idee dai suoi pensatori; e coloro che detengono il comando, in alto o in basso, �possono portare a esecuzione solamente quanto � nel pensiero dell�et�. Quindi, la civilt� progredisce se i pensatori diffondono, con �forte� ottimismo, le loro idee di progresso della civilt� che poggiano su una valida concezione circa la natura ed il fine del mondo. Ottimistica ed etica (razionale) � la concezione del mondo che afferma la vita come valore e educa l�individuo alla perfezione interiore suggerita dal principio dell�amore. Attingendo ad esso, le persone si sentono responsabili verso tutte le creature e agiscono di conseguenza. In caso contrario la civilt� crolla. Per questo, annota Schweitzer: �Anche se i nostri statisti fossero stati pi� lungimiranti, non avrebbero potuto evitare la catastrofe che ci ha colpito. Lo smarrimento interiore e il crollo esterno della civilt� erano gi� latenti nelle condizioni preparate dalla prevalente concezione del mondo; i governanti, grandi e piccoli, agirono secondo lo spirito dell�epoca. Il venir meno dell�influsso esercitato dall�Aufkl�rung, dal razionalismo e dalla grande filosofia del primo Ottocento, gi� preparava il terreno alla futura guerra mondiale, perch� con esso si indebolivano quelle idee e convinzioni che avrebbero reso possibile una giusta soluzione delle controverse internazionali�41.
Ogni vero progresso della civilt� � sorretto dalla visione del mondo che ha nella ragione la forza per forgiare il perfezionamento morale del singolo e della collettivit�. Da qui ha origine la societ� civile frutto di vera umanit� e l�operare dell�individuo volto a vagliare criticamente le sue esperienze alla ricerca del vero accordo tra cuore e ragione per il progresso sociale. Ci� che � vero per s� guider� poi l�uomo verso l�altro per rispettare la sua stessa volont� di vivere. �Dovunque vedi vita, questa sei tu�42. Con questa guida interiore razionale, l�uomo pu� quindi promuovere la comprensione reciproca e migliorare le condizioni di vita propria e degli altri esseri viventi, della societ�, delle nazioni e dell�umanit�; pu� costruire la pace e diffondere la giustizia economica.
�L�etica � lo sforzo volto ad assicurare l�interiore perfezione della personalit�43. Seguendola, l�uomo � capace di agire per il progresso generale ed il bene dell�umanit�. La rinascita della civilt� � perci� legata alle capacit� dell�individuo di progettare fini realizzabili solo rinnovando le sue idee mediante la riflessione sul significato della vita e di quella del mondo in cui vive. Tale riflessione personale � l�unica valida misura dei valori che formano una cultura etica universale il cui fine � rifiutare la guerra e promuovere la pace. �Gli ideali, nati da follia e da passione, di coloro che creano l�opinione pubblica e dirigono i pubblici eventi, non avrebbero pi� forza sugli uomini se questi cominciassero a riflettere sull�eterno e sul temporale, sull�esistenza e sulla morte e imparassero a distinguere tra vere e false misure, tra valori e disvalori�44.
3. E. Cassirer
3.1 L�arte della divinazione di O. Spengler
Nel 1923, Agonia della civilt�, �prima parte di una completa filosofia della civilt�, � pubblicato dallo stesso editore del libro di O. Spengler Il tramonto dell�Occidente (1922). �Cos� lo conobbi � scrive Schweitzer - anzich� combatterci a vicenda diventammo amici e come tali confrontammo le nostre posizioni sulla cultura�. Per Spengler �la cultura occidentale era sorta, aveva avuto la sua fioritura ed era giunta alla fine per motivi esclusivamente storici. Questo modo tragico di affrontare l�argomento era in sintonia con lo spirito del tempo, successivo alla prima guerra mondiale. Spengler non aveva preso in esame la natura della cultura in generale, ma aveva descritto il destino storico di una cultura�45, annota Schweitzer.
Secondo Splenger, per sapere quale sar� il �destino� della civilt� (Kultur) bisogna prima di tutto definire che cosa sia una civilt�. Essa � �un organismo� vivente d�ordine superiore che sorge, fiorisce �in una magnifica assenza di fini, come i fiori di campo�, declina e muore. �La logica del tempo� vuole che la civilt� occidentale sia gi� pervenuta alla fase della �civilizzazione� (Zivilisation), ossia alla piena fioritura, cui seguir� necessariamente la decadenza e la morte. Questo processo di declino, dice, si mostra nel �rovesciamento di tutti i valori� in atto nella civilt� occidentale. E� quindi legato alla crisi della morale e della religione, delle arti e della filosofia, al prevalere della democrazia ed al trionfo del denaro sullo spirito. La civilizzazione �compimento e sbocco di una data civilt�46 porter� alla barbarie da cui nascer� la prossima civilt�. Splenger propone quindi la dicotomia �Kultur� (civilt�) / �Zivilisation� (civilizzazione) per mostrare che questa porta in s� l�inevitabile �destino� di una civilt�. �Le civilizzazioni - dice - sono gli studi pi� esteriori e pi� artificiali di cui una specie umana superiore � capace. Esse rappresentano la fine, sono il divenuto che succede al divenire, la morte che segue alla vita, la fissit� che segue all�evoluzione. (�) Esse rappresentano un termine, irrevocabile ma sempre raggiunto secondo una necessit� interna da qualsiasi civilt�47.
Schweitzer invece � dell�avviso che la distinzione tra i termini tedeschi �Kultur� (sviluppo spirituale e materiale dell�umanit�) e �Zivilisation� (civilt�) intesa come �mero progresso materiale� e forma non etica di civilt� �serva a mascherare quest�ultima con un nome di dignit� storica�48. A suo avviso, la distinzione di Spengler non ha giustificazioni filologiche o storiche tanto � vero che i tedeschi usano �Kultur� ed i francesi �civilisation� per indicare la civilt�.
Contrariamente a Splenger, Schweitzer ritiene che l�etica sia essenziale alla civilt�. Egli � convinto che il suo processo di decadimento si arrester� non appena ci sar� il risveglio spirituale degli individui, perch� �non � la civilt� di una razza, ma quella dell�umanit�, presente e futura, che dobbiamo ritenere perduta se � vana la fede nella rinascita della civilt�49. Schweitzer combatte quindi la tesi di Splenger secondo la quale �l�umanit� non ha alcuno scopo, alcuna idea, alcun piano, cos� come non lo ha la specie delle farfalle o quella delle orchidee. L�umanit� � o un concetto zoologico o un vuoto nome�50.
�E� il sistema delle attivit� umane a definire ed a determinare la sfera dell�umanit�51, dice Cassirer, nel Saggio sull�uomo. Queste varie forme d�attivit� simbolica si concordano e si armonizzano �nel fuoco del pensiero�. Il mito, la religione, il linguaggio, l�arte, la storia e la scienza sono tutte produzioni del processo creativo individuale che mediano il rapporto dell�uomo con se stesso e con il mondo. Esse quindi hanno tracciato e segnano il cammino dell�umanit� verso la cultura e la civilt�, perch� l�uomo ha la capacit� di conservare le forme spirituali della cultura e di rinnovarle progressivamente con la sua attivit� simbolica.
Cassirer � ancora d�accordo con Schweitzer che vede i sintomi del pessimismo, diffuso tra gli uomini dalla teoria di Splenger, nella �riammissione� del vaticinio e della superstizione anche negli ambienti colti. Secondo Cassirer, �La filosofia del destino� contenuta nell�opera Il tramonto dell�Occidente (1918) di O. Spengler appoggia indirettamente la �nuova arte della divinazione� propagandata dall�ideologia del tempo. Per Spengler, il sorgere ed il cadere della civilt� non dipendono dalle leggi della natura, ma sono determinate dal potere del destino. �Il destino non la causalit�, � la forza motrice della storia umana. La nascita di un mondo culturale � sempre un atto mistico, un decreto del destino�52. Nelle parole di Spengler, Cassirer ravvisa tutti i caratteri del fatalismo, il pi� antico motivo mitico. Il suo libro, egli dice, � �un�astrologia della storia; l�opera di un indovino che narra le sue cupe previsioni apocalittiche�. Spengler � un profeta del male che diffonde solo fatalismo contro il quale l�uomo non pu� fare nient�altro che accettare il tramonto dell�Occidente in �quieto� raccoglimento. E i capi politici dell�epoca interpretano �nel senso loro� la teoria pronosticando un mondo nuovo dopo la morte della cultura. Convinti di realizzare la profezia, essi �ispiravano ai loro aderenti le pi� esagerate speranze parlando loro della conquista del mondo da parte della razza germanica�. Spengler � un conservatore non un seguace del movimento nazista, tuttavia la sua opera �divent� una delle opere anticipatrici del nazionalsocialismo�53.
Cassirer rileva ancora: �L�ideologia del nazionalsocialismo non � stata elaborata dai filosofi. Era cresciuta su un terreno completamente differente. Ma tra quel generale corso di idee che possiamo studiare nel caso di Splenger o Heidegger e la vita politica e sociale della Germania nel periodo successivo alla prima guerra mondiale esiste un nesso indiretto�54. La teoria di Splenger e di Heidegger hanno minato ed indebolito le forze critiche che invece avrebbero dovuto combattere il ritorno dei tab�, del vaticinio e del fatalismo nel mondo moderno. Nelle mani di �artefici abilissimi ed astuti� le previsioni circa il declino dell�Occidente e la distruzione della cultura di Splenger, la condizione dell�uomo �gettato� nella corrente del tempo e vincolato al tempo di Heidegger, la teoria dello Stato di Hegel, la teoria del culto degli eroi di Carlyle e quella del mito della razza di Gobineau si sono quindi trasformate in armi politiche. I politici hanno adattato queste idee accademiche alle circostanze dell�epoca perch� un pubblico diverso ne subisse il fascino. Il momento storico per l�abile impiego di questa nuova tecnica politica era propizio. L�inflazione e la disoccupazione minacciavano il sistema sociale ed economico della Germania e, nelle situazioni difficili l�uomo ricorre sempre a mezzi disperati. �I miti politici dei nostri giorni sono stati altrettanti mezzi disperati di questo genere�55, sottolinea Cassirer. Il linguaggio emotivo, la potenza del miracoloso e del misterioso subentrano, infatti, al linguaggio della ragione quando questo perde la sua forza a causa delle difficolt� del vivere.
3.2 I miti politici
Cassirer scrive Il mito dello stato (1945) durante gli anni dell�esilio americano (1943/45). La storia del passaggio delle teorie mitiche dello Stato fino all�universalit� e razionalit� del pensiero politico di Rousseau e Kant e �La preponderanza del pensiero mitico sul pensiero razionale in alcuni nostri sistemi politici moderni� compongono il testo. Cassirer usa la teoria del mito per ripercorrere lo sviluppo della nozione di Stato ed indagare la vita sociale e politica del primo Novecento dove il mito (frutto dell�esperienza sociale dell�uomo primitivo) � riproposto come una nuova strategia politica per preparare l�avvento del nazismo. Per il filosofo, questo lucido programma politico � incominciato in Germania molto prima del 1933, anno in cui il mondo politico internazionale ha incominciato ad interessarsi del riarmo tedesco. �Il vero riarmo cominci� con l�inizio e con lo sviluppo dei miti politici. (�) Il riarmo militare non fu che la conseguenza inevitabile del riarmo mentale determinato dai miti politici�56. Questi hanno distrutto l�autonomia del volere e l�indipendenza dell�attivit� umana perch� il mito della razza ha lavorato �come un potente corrosivo ed � riuscito a dissolvere ed a disintegrare tutti gli altri valori�. La strategia di Cassirer di fronte al mito politico, �impervio alle argomentazioni razionali�, � quella di comprendere la forza di questa nuova arma offensiva della dignit� umana per non soggiacere ad essa. �Guardare in faccia l�avversario� significa per lui studiare l�origine, la struttura, i metodi e la tecnica dei miti politici per non sottovalutarli una seconda volta.
Che cos�� il mito? Nella storia della civilt�, il mito rappresenta lo stadio pi� primitivo della conoscenza. E� l�espressione dell�emozione dei primi uomini davanti alla potenza della natura che �nulla concede senza cerimonie�. Per questo, le immagini, le parole magiche, le formule, ecc., correlate ai riti, sono accettati da tutti i componenti del gruppo sociale e ripetuti con grande attenzione altrimenti: �La pioggia non cadr�, il grano non maturer�. La violazione delle norme collettive fissate dallo stregone, �attore nel teatro della natura�, significa sventura per l�individuo e per l�intera comunit�. Nella vita sociale e culturale primitiva, i miti rappresentano quindi i primi messaggi e le prime norme tribali della vita sociale.
Che cosa caratterizza il mito politico? La razionalit� degli scopi. Nella prima met� del Novecento, il mito � �una combinazione artificiale fabbricata nel gran laboratorio della politica�57 dai capi politici che hanno operato deliberatamente con idee e ideologie per dominare la societ�. E� l�arma usata dalla propaganda politica per incitare l�uomo all�odio razziale ed alla guerra intesa come �il vero ideale e l�unico elemento permanente nella vita pubblica e sociale dell�uomo�58.
Nell�et� della tecnica, il mito politico � fabbricato secondo i piani della propaganda politica. �I miti sono manifatturati nello stesso senso e seguendo gli stessi metodi che si usano per qualunque altra arma moderna, come le mitragliatrici o gli aeroplani�59.
Nel ventesimo secolo, dunque, il mito non evoca pi� le imprese degli dei e degli eroi in un mondo di tab�, di forze e di potenze in conflitto, ma esso ha ancora il ruolo di suscitare emozioni attraverso i riti collettivi e le parole magiche dello stregone. Un tempo, costui conosceva i rimedi a tutti i mali degli uomini primitivi. Negli anni tra le due guerre, il capo politico diventa �l�appagatore di tutti i desideri collettivi. A lui si rivolgono tutte le speranze e tutte le paure� dell�uomo moderno. Il capo politico diventa �una specie di pubblico negromante�, che sa interpretare le delusioni e le attese delle masse e pu� quindi rappresentarle. L�arte divinatoria salda quest�affinit� di impulsi e di intenti tra il capo e la massa perch� la profezia � �un elemento essenziale della nuova tecnica di governo�. Nel mondo moderno, l�uomo politico � una mescolanza di homo magus dell�et� della magia e di homo faber dell�et� della tecnica. E� �il sacerdote di una nuova religione del tutto irrazionale e misteriosa�, che procede in modo metodico senza lasciare niente al caso. Egli riprende la mitica idea del millennio, ossia �del periodo in cui tutte le speranze saranno soddisfatte e tutti i mali cancellati�, ma promette alla razza germanica non un �millennio� di pace, bens� di guerra per la vittoria del nazionalsocialismo. Inoltre: �Nel pandemonio mitico troviamo sempre spiriti maligni opposti agli spiriti benevoli. C�� sempre una rivolta, segreta o aperta, di Satana contro Dio. Nel pandemonio tedesco questo ruolo � stato assegnato all�ebreo�60. Cos�, la tradizione militaristica ed imperialistica tedesca � rispettata e l�ebreo � il �mitico� simbolo del nemico: � la �potenza demoniaca� su cui riversare ogni sorta di rancore e di odio personale e di classe. Perch� l�ebreo? Per spezzare l�influenza esercitata dagli ebrei sulla vita economica, culturale e politica e perch�, dice Cassirer, �nella storia dell�umanit� erano stati i primi a negare ed a sfidare quelle stesse concezioni che formavano la base del nuovo Stato. Era stato, infatti, il giudaismo a compiere il primo passo decisivo che da una religione mitica aveva portato ad una religione etica�61 liberando l�uomo dal peso dei tab� e presentandosi come l�espressione di �un ideale nuovo e positivo� della libert� umana. Cassirer, rappresentante di quegli ideali etici, consegna, dunque, al tempo la propria riflessione politica incentrata sul mito come �impulso animatore� del nazismo e dell�antisemitismo.
3.3 Il peso della libert�
Il vero riarmo della Germania � cominciato con la trasformazione della mentalit� individuale operata dai miti politici. A conferma della sua tesi, il filosofo riporta in una nota a pi� di pagina 487 del testo Il mito dello stato un�intervista di un giornalista americano. �A un droghiere tedesco, che era abbastanza disposto a spiegare certe cose ad un ospite americano � riferisce Stephen Raushenbush � parlai della nostra sensazione che, nel rinunciare alla libert�, si fosse rinunciato a qualcosa di inapprezzabile. Egli rispose: �Ma voi non capite affatto come sta la cosa. Prima di questo, dovevamo preoccuparci delle elezioni, dei partiti e di votare. Avevamo delle responsabilit�. Ma ora non abbiamo pi� niente di tutto ci�. Ora siamo liberi� �. Nei momenti di grave crisi economica e politica, i valori morali e civili scadono e l�uomo non ha pi� fiducia nelle proprie capacit� di giudizio e di decisione. La libert� individuale e politica gli sembra un peso e si perde nella massa. �Qui entrano in gioco lo stato totalitario e i miti politici. I nuovi partiti politici promettono, quanto meno, un�evasione al dilemma. Essi sopprimono e distruggono il senso stesso della libert�; ma, al tempo stesso, alleggeriscono le spalle dell�uomo di ogni responsabilit� personale�62. Secondo Cassirer, questa � la condizione spirituale creatasi in Germania, negli anni Venti e Trenta. La �preminenza� del pensiero mitico su quello razionale ha causato la disintegrazione dei valori etici e lo scetticismo dell�uomo verso il proprio pensiero, rendendolo ricettivo alla verit� imposta dall�alto. Il mito diventa cos� una nuova arma di lotta politica ed uno strumento tecnico di mobilitazione delle masse perch�: �I politici moderni sanno benissimo che le grandi moltitudini sono mosse pi� facilmente dalla forza dell�immaginazione che non dalla pura forza fisica�63.
La prima tecnica prodotta dall�incontro mito-politica � legata all�introduzione di alcuni neologismi nella lingua tedesca che hanno lo scopo di suscitare emozioni. Per illustrare questa tecnica, Cassirer porta ad esempio le parole �Siegfriede� (singolare) e �Siegerfriede� (plurale), entrambe composte da Sieg (vittoria) e Fried (pace). �Una Siegefriede � una pace dovuta alla vittoria tedesca; mentre una Siegerfriede significa esattamente il contrario�. La sillaba in pi� denota una pace imposta dai vincitori alleati: un tutto non omogeneo, un miscuglio di razze diverse. �(...) Nell�udire queste parole sentiamo in esse tutta la gamma delle emozioni umane: dell�odio, dell�ira, del furore, dell�orgoglio, del disprezzo, dell�arroganza e dello sdegno�64. �I maestri� dell�arte della propaganda politica in Germania completano l�effetto emotivo compresso nelle parole �magiche� con i nuovi riti �regolari�, �rigorosi� e �inesorabili� che sono usati per promuovere l�azione di massa e �addormentare� tutte le forze attive. Ricorda il filosofo: �Nessuno poteva camminare per strada, nessuno poteva salutare il vicino o l�amico senza compiere un atto politico. E come nelle societ� primitive, la trascuratezza di uno dei riti prescritti significava sciagura o morte� cos�, in epoca moderna, ogni dimenticanza diventa �un delitto di alto tradimento contro l�onnipotente ed infallibile stato totalitario�. Compiendo gli stessi riti prescritti, gli uomini cominciano a pensare ed a parlare tutti negli stessi modi ed a vivere in maniera artificiale e fittizia: �Il soggetto morale non � l�individuo, bens� il gruppo�. La personalit� e la responsabilit� individuali sono soppresse. Gli uomini: �Agiscono come marionette su un palco e non sanno nemmeno che le corde di questa azione teatrale e di tutta quanta la vita individuale e sociale dell�uomo, da quel momento in avanti sono tirate dai capi politici�65.
In ogni tempo sono stati usati metodi di repressione politica, ma tali sistemi miravano a risultati materiali e lasciavano una sfera di libert� personale. Per esempio, Seneca ha scritto le opere morali al tempo di Nerone. I capi politici moderni invece si sono proposti di cambiare i sentimenti degli uomini regolando e controllando i loro atti. �I miti politici hanno agito nello stesso modo del serpente che cerca di paralizzare la propria vittima prima di attaccarla. Gli uomini sono caduti nelle loro mani senza nessuna seria resistenza. Sono stati vinti e soggiogati prima di aver compreso ci� che realmente era accaduto�66. Negli anni tra le due guerre, i miti politici sono stati perci� le armi �spirituali� che hanno sostituito i fucili ed i cannoni. �E� la parola imperativa dei capi politici che li ha fatti nascere�, ma la filosofia, in un certo senso, ne ha preparato il terreno non prendendosi cura degli eventi reali e non insegnando all�uomo come sviluppare il senso critico al fine di formare la sua vita individuale e sociale.
L�invenzione e l�uso �sapiente� dei miti politici, come strumento tecnico, ha cos� deciso la vittoria del movimento nazionalsocialista in Germania. �Gli avversari del nazionalsocialismo � dice Cassirer � avevano perduto ancor prima che la battaglia avesse inizio. E ci� perch� nella lotta politica � sempre di vitale importanza conoscere l�avversario, penetrare i suoi modi di pensiero e di azione; ed i capi politici della Repubblica di Weimer erano impari a questo compito. Essi non compresero minimamente il carattere e la forza della nuova arma impiegata contro di loro. Nel loro modo di pensare sobrio, empirico, �tutto fatti� non ebbero occhi per la pericolosa forza esplosiva contenuta nei miti politici. Era pressoch� impossibile persuaderli a prendere sul serio queste cose. In maggioranza erano marxisti convinti. Pensavano e parlavano in termini economici, persuasi com�erano che l�economia sia la molla della vita pubblica e la soluzione dei problemi sociali. Seguirono la loro teoria e non videro la questione reale; non compresero quale posta era in gioco. Non c�� dubbio che le condizioni economiche pesarono considerevolmente sull�evoluzione e sulla rapida crescita del movimento nazionalsocialista. Ma le cause pi� profonde e determinanti non vanno ricercate nella crisi economica che la Germania si trov� a subire. Esse appartengono ad un ambito diverso, che era in un certo senso inaccessibile ai capi socialisti. Quando costoro cominciarono a scorgere il pericolo, era troppo tardi: le forze dei miti politici erano diventate irresistibili�67. La nuova tecnica politica aveva gi� soffocato l�energia creativa, la dignit� e la libert� delle persone tanto che costoro consideravano la libert� un peso. �La libert� non � un�eredit� naturale dell�uomo. Per possederla dobbiamo cercarla�68, sentenzia Cassirer.
4. Sottolineature
4.1 Memoria e speranza
�Durante la guerra si giunse a controllare completamente il pensiero e la propaganda prese definitivamente il posto della verit�69, sottolinea Schweitzer. Sotto la pressione di tale arma politica, l�uomo ha perso la fiducia in se stesso e si � lasciato trascinare dalla massa. �E� simile ad una palla di gomma che ha perduto elasticit� e conserva ogni forma che le viene impressa�.
Nell�articolo Filosofia e politica (1944) Cassirer scrive: �Due cose, secondo Schweitzer, sono responsabili di questa crisi. La prima � il predominio del nazionalismo; la seconda la schiacciante influenza di quello che egli descrive come lo �spirito collettivo�. (�) [E la filosofia] era diventata straniera al mondo ed ai suoi problemi di vita che concretamente occupavano l�uomo; e l�intero pensiero contemporaneo non prendeva parte alcuna nelle attivit� della sua epoca. (�) Nell�ora del pericolo il guardiano che avrebbe dovuto tenerci svegli dormiva, cosicch� noi non opponemmo resistenza alcuna�70. L�accusa di Schweitzer alla filosofia non � infondata sostiene Cassirer. Negli anni tra le due guerre, infatti, la sua voce non solo non si � fatta sentire, ma la filosofia ha giocato un ruolo nuovo: ha fornito ai politici le armi �spirituali� che hanno completato le armi materiali. Filosofi, etnologi e sociologi pensavano che la cultura si fosse lasciata alle spalle l�et� mitica. Invece, il mito � diventato la nuova arma politica prodotta a piacimento �nel grande laboratorio della politica�. Contro il mito della razza ed i metodi adottati dalla propaganda antiebraica tedesca, Cassirer ricorda che �Le vittime di quest�ord�lia non possono essere dimenticate�. Tuttavia, il filosofo � convinto che tutti quei sacrifici non siano stati inutili. �Ci� che l�ebreo moderno doveva difendere in questa battaglia non era soltanto la sua esistenza fisica, o la conservazione della razza ebraica. La posta in gioco era molto pi� alta. Noi dovevamo rappresentare tutti quegli ideali etici che, generati dal giudaismo, erano divenuti patrimonio generale della cultura umana, della vita di tutte le nazioni. E qui la nostra certezza � salda. Questi ideali non sono stati distrutti, n� possono esserlo�71. Il giudaismo ha contribuito a spezzare il potere dei miti politici moderni.
In quei tempi di guerra, Cassirer segue l�imperativo socratico del �conosci te stesso� e aiuta l�uomo a ritrovarsi come animale simbolico, soggetto creatore e fruitore di cultura. L�uomo � se stesso solo quando libera la creativit� e, distaccandosi dalla sua finitezza, trasforma l�esperienza immediata nelle forme simboliche del mito, della religione, del linguaggio, dell�arte, della storia e della scienza. L�uomo dunque non � solo un animale razionale, � anche un �animale mitico�. Il mito fa parte della cultura umana ed � sempre presente anche se in forme diverse. Da questa tesi emerge che lo sviluppo della civilt� � legato al raffinamento dell�attivit� simbolica che dalle primitive espressioni del mito raggiunge i pi� alti gradi della razionalit� nell�attivit� scientifica. Negli anni Venti e Trenta, utilizzare le forme del mito ha significato far regredire la civilt� allo stadio primitivo.
Cassirer vede la cultura come �il compimento� della vita, come un�attivit� di progressiva autoliberazione dell�uomo dai vincoli dell�animalit� e dell�ignoranza; perci� �la liberazione dello spirito umano � il fine autentico e ultimo di ogni educazione� intesa come sviluppo della personalit� individuale alla luce dei cambiamenti sociali. Egli ha messo cos� in evidenza che il pensiero simbolico � lo strumento costruttore del mondo della cultura ed il possibile realizzatore dell�unit� degli uomini, attraverso la consapevolezza della loro umanit�. Mostrare l�interiore umanit�, insita nelle �opere� dello spirito, � l�imperativo per tutti coloro che mirano alla �liberazione di s� mediante il sapere� nella quale consiste la dignit� ed il valore dell�uomo. �Agisci!� comanda Kant. Per trasformare �l�animalit� nostra in umanit� e renderci degni della felicit�. L�umanit�, dunque, � l�essenza dell�uomo simbolico; � il fondamento per la formazione d�ogni personalit�.
�C�� etica soltanto dove c�� umanit�, cio� dove l�esistenza e la felicit� di ogni singolo essere umano sono rispettate. (�) Quindi la cultura non � l�immagine di un�evoluzione del mondo, ma un�esperienza della volont� di vita che � in noi stessi�72, dice Schweitzer. La cultura � una �totalit�� che unisce gli uomini se costoro vagliano criticamente l�esperienza alla ricerca della verit�, non se diventa un patrimonio di idee e conoscenze in s� concluso. In questo caso essa divide gli uomini e sconfigge il senso critico che li contraddistingue. Producendo cultura l�uomo si � costruito un �secondo� mondo, il mondo dello spirito, attraverso il quale � possibile costruire una nuova umanit� con la guida etica della filosofia.
Scrive Schweitzer: �Cartesio fa iniziare il pensiero dalla frase: �Cogito ergo sum�. (�) Pensare significa pensare qualcosa. Il fatto pi� immediato della coscienza dell�uomo �: �Sono vita che vuol vivere, in mezzo a vita che vuol vivere� (�) Nella mia volont� di vita ci sono la brama della sopravvivenza e quella misteriosa esaltazione della volont� di vita che si chiama piacere, e la paura dell�annientamento e di quella misteriosa menomazione della volont� di vita che si chiama dolore: la stessa brama e la stessa paura ci sono nella volont� di vita che mi circonda, sia che possa esprimersi sia che rimanga muta�73. Per la mistica etica, ogni conoscenza ha valore perch� tutte le ricerche e scoperte scientifiche non possono far altro che approfondire il mistero della volont� di vivere del creato. Se quindi ogni uomo ritiene etico che tutte le volont� di vita debbano essere rispettate sa che cosa lo unisce agli altri uomini. Rendendosi conto della verit� delle sue convinzioni, circa la vita e la natura del bene (pace) e del male (guerra), l�uomo si assume la responsabilit� di condividerle con gli altri. Ed agisce di conseguenza. Ha aperto questa s