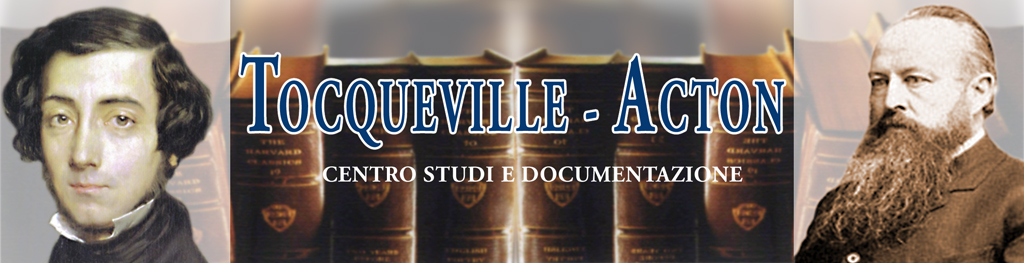
![]() D. Ciccarelli,
L'impresa vitale
D. Ciccarelli,
L'impresa vitale
![]() F. Felice, L'economia civile
F. Felice, L'economia civile
![]() F. Felice, Le ragioni etiche dell'economia di
mercato
F. Felice, Le ragioni etiche dell'economia di
mercato
![]() F. Felice,
L�Economia D�Impresa Come Economia Civile
F. Felice,
L�Economia D�Impresa Come Economia Civile
![]() C. Galluccio, Metodi di scelta
negli investimenti etici
C. Galluccio, Metodi di scelta
negli investimenti etici
![]() G. Costa,
Vangelo e ricchezza: le nuove prospettive esegetiche ed etiche di
don Angelo Tosato
G. Costa,
Vangelo e ricchezza: le nuove prospettive esegetiche ed etiche di
don Angelo Tosato
![]() S. Noto,
Detti e contraddetti messedagliani
S. Noto,
Detti e contraddetti messedagliani
![]() S. Noto, La
recezione di Hayek in Italia: gli anni �30 e �40
S. Noto, La
recezione di Hayek in Italia: gli anni �30 e �40
![]() N. Novak,
Armonia Sociale e Pace Tra I Popoli: La Liberta� al Servizio Dell
�Umanita�
N. Novak,
Armonia Sociale e Pace Tra I Popoli: La Liberta� al Servizio Dell
�Umanita�
vai indietro
L�Impresa vitale
di Dario Ciccarelli
Chi � l�Imprenditore? E quali requisiti qualificano un comportamento come �imprenditoriale�?
Prima di provare a dare una nostra risposta a queste domande, esploriamo in libert� le soluzioni suggerite dall�ordinamento statale italiano, facendo attenzione a cogliere, tra le parole, anche la forza dei messaggi culturali che i dettati normativi esprimono e diffondono.
Il codice civile (art. 2082) definisce imprenditore �chi esercita professionalmente un�attivit� economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi�. Da questa nozione, la dottrina[1] ha desunto che i requisiti costitutivi dello status di imprenditore sono i seguenti: 1. la professionalit�; 2. l�esercizio di un�attivit� economica organizzata; 3. il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
Proviamo ad approfondire.
� Sulla �professionalit��. Condividiamo: deve trattarsi di un�attivit� abituale, sistematica e non occasionale.
� Sull��esercizio di un�attivit� economica organizzata�. Tralasciando l�aspetto organizzativo, che in parte si fonde con quello della professionalit�, ci chiediamo: quali attivit� rientrano nella categoria �economica�? La risposta, non pacifica, richiede un richiamo alla definizione di Economia. Lionel Robbins [2] definisce l�economia come quella scienza �che studia il comportamento umano come una relazione fra scopi e mezzi scarsi applicabili ad usi alternativi�. Da questa definizione, che � tra le pi� diffuse, si desume la centralit� del riferimento all�uso di risorse scarse; sicch� per attivit� economiche possiamo correttamente intendere quelle attivit� che �impiegano risorse scarse�. Bisogna allora chiedersi: esistono forse risorse che non siano scarse, la cui disponibilit� sia illimitata, a prescindere dal modo in cui l�Uomo ne faccia uso? Ebbene, forse in passato potevano considerarsi illimitate la risorsa �acqua�, la risorsa �ossigeno�, la risorsa �spazio� e poche altre. Oggi, sembra di potersi ragionevolmente osservare come tutte le risorse siano �scarse�. Fondendo il buon senso con le lezioni della teoria, si pu� dunque, altrettanto ragionevolmente, rilevare come oggi tutte le attivit� siano economiche, dunque suscettibili di esercizio imprenditoriale.
� Sul �fine della produzione o dello scambio di beni o servizi�. Su questo aspetto sorgono molti e pesanti dubbi. Che il fine della produzione, anche se dissociato dalla propensione allo scambio (l�art. 2082 usa la congiunzione �o� e non la congiunzione �e�: vedremo come intorno a questa opzione ruotino due diverse visioni del mondo!), sia elemento necessario per qualificare un�attivit� come �economica� appare chiaramente falso. La proposizione dovrebbe infatti concentrarsi esclusivamente sul momento �scambio�. Il richiamo alla vicenda �produzione� � ridondante, non superfluo ma improprio. Non � infatti imprenditore - e il legislatore non riesce a renderlo tale - colui che realizza una produzione che non sia rivolta allo scambio. Che imprenditore sarebbe colui che producesse qualcosa, senza poi orientare quella produzione all�altrui domanda?
Il codice civile (art. 2082) pone dunque come requisito teleologico costitutivo - condizione sufficiente - dell�imprenditorialit� il fine della produzione, anche, dunque, nel caso in cui a questo non si associ quello dello scambio. Ebbene: abbiamo la sensazione che questo sia un Errore, enorme e dagli effetti disastrosi.
E� da qui che � partito il messaggio che ha disorientato una generazione. E� da questo errore nella struttura portante che tanti altri hanno preso e prendono origine. Le vie della storia individuale e collettiva si sono separate di fronte a questa interpretazione. Su una via scorre il fluido della sapienza e delle certezze, con la presunzione, che vi si accompagna, di non avere bisogno del consenso degli altri per conoscere il valore della propria �produzione�. Sull�altra via, scorrono umilt� e cambiamento, caratterizzati dalla disponibilit� ad apprendere dall�esperienza, e a modificare la propria produzione ove questa non risulti apprezzata.
Non esiste Impresa, o imprenditore, che non aspiri allo scambio. L�indefettibile orizzonte teleologico, il fatto che un�attivit� sia orientata allo Scambio, � dunque essa s� la condizione non solo necessaria ma anche sufficiente perch� l�attivit� sia imprenditoriale. Ci� perch� l�orientamento tenace allo scambio rende poi a sua volta necessari comportamenti che siano disciplinati, sistematici, organizzati (attivit� �professionale� ed �organizzata�). Il momento dello scambio contiene dunque, implicandoli logicamente e presupponendoli cronologicamente, quelli della professionalit� e dell�organizzazione: indicare questi due elementi come autonomamente rilevanti (la �o� dell�art. 2082 c.c.) ha invece contribuito a confondere le idee, inducendo molti a relegare l�Impresa in un ambito separato ed esclusivo: quella che � una parabola vitale � stata trattata come un oggetto per specialisti. L�impresa � contenendo costitutivamente la condizione dello scambio e quindi della creazione di un valore, che esiste e si misura attraverso il consenso che altri manifestano � detiene una naturale vocazione alla relazione; essa svolge una intrinseca funzione sociale. L�imprenditore pu� non produrre, ma non pu� non scambiare. Una produzione diventa �impresa� solo se scambiata, solo se tesa agli altri, solo se mira all��apprezzamento� degli altri (da qui la necessit� di un �prezzo�). Il caso � frequentissimo: una produzione materiale pu� anche del tutto mancare all�impresa; a caratterizzare la natura imprenditoriale di un�attivit� e di un�organizzazione � infatti l�irrinunciabile vocazione allo Scambio (trade). Talmente profonda � l�identificazione ontologica della struttura con la funzione (scambio), che il termine �impresa� � nell�uso comune � viene indifferentemente a richiamare l�organizzazione (l��azienda�) come la sua attivit�, proprio perch�, nella vita dell�Impresa, il �divenire� � invariabilmente connaturato all��essere�.
E� dunque l�imprenditore a consentire il �cangiamento imperituro che rinnova il mondo� (Eraclito), perch� �l�imprenditore non � una classe, n� una professione, ma un modo di agire, rompere la routine, produrre innovazione� (Schumpeter). Se l�impresa decide di cessare nella sua dimensione sociale (clienti, pubblicit�, trasporti, sponsor, acquisti, vendite, etc.), decide anche di cessare di esistere: la relazione di simbiosi con l�ambiente esterno costituisce la sua stessa identit� genetica, la sua missione vitale, la sua ragion d�essere. L�impresa non pu� non scambiare e nel contempo rimanere impresa; poich� �tutto scorre�, l�impresa deve saper � e sapersi � continuamente cambiare. Non potrebbe aspirare ad essere imprenditore colui che �si innamorasse� della propria produzione, trascurando il beneficio che altri devono poterne trarre. L�imprenditore che per qualsiasi ragione non riuscisse a scambiare la propria produzione, andrebbe incontro al �fallimento�.
L�Imprenditore scambia sistematicamente e colui che scambia sistematicamente � Imprenditore.Da questo Scambio (traditio), l�imprenditore trae il suo Reddito (redditio). In questo percorso, semplice e trasparente, ci sono giustizia, equit�, fiducia, tenacia, umilt�.
Estraiamo da un documento [3] sulla Giornata mondiale della Giovent�, celebrata nell�ambito del Giubileo di Roma 2000.
�La dinamica interiore della Giornata mondiale della Giovent� - � stata riassunta in due parole latine perch� hanno la radice nelle origini cristiane, nella stessa vita di Ges�: traditio e redditio, ossia consegna e restituzione, dono e risposta (cf Prog. Past, nn. 2-4).. Vuol dire l�attuazione di un dinamismo che coinvolge e rende personale ci� che esternamente si dice e si fa.
� Tutto parte dal mistero trinitario di Dio. Nel Vangelo si legge: �Dio ha tanto amato il mondo da dare ad esso (tradere) il suo Figlio per salvare il mondo� (Gv 3, 16).. Cristo � dunque la �consegna� (traditio) al mondo della cosa pi� grande che il Padre ha, il Figlio, per salvare il mondo.� Nella vita di Ges� si legge che egli sovente prega dicendo �Ti ringrazio o Signore per quello che fai attraverso di me� (cf Mt 11, 25s).. E all�ultima Cena dice: �Ho realizzato la missione che mi hai consegnato� (cf Gv 17,4).. E quando muore sintetizza la sua vita con: �Padre nelle tue mani consegno la mia vita� (Gv 19,30).. Ges� allora non � solo la consegna di Dio al mondo, ma � insieme la resa, la risposta pi� fedele che l�uomo, in Ges�, fa a Dio. Egli � la traditio-redditio fatta persona.� Questa esperienza impregna di s� la missione della Chiesa e di ciascuno di noi. Il cristiano � colui che riceve da Dio nella chiesa la fede (ecco la traditio), e vi risponde con una vita di fede (redditio).. Questa � la logica della fede: un dono e una risposta. Nel tempo antico quando i cristiani diventavano tali con un lungo tirocinio detto catecumenato vi era l�usanza di dare dei segni da parte del vescovo ai catecumeni, che si impegnavano di ridare con la professione della fede nella celebrazione della Pasqua e attuare nella vita.. Venivano consegnati il Credo, detto Simbolo della fede, il Padre Nostro, il Vangelo. E vi erano gli scrutini in quaresima per vedere il tipo di resa, quindi il livello di maturazione per il battesimo. Questa risposta ha una scansione nella celebrazione della Messa domenicale (Parola-Credo), trova spazio nella preghiera e nella vita cristiana, ha conclusione nella morte, che � la redditio massima ad un dono ricevuto nel battesimo, e insieme diventa l�accoglienza di una nuova traditio, la vita eterna, cui corrisponde una redditio di lode per sempre da parte del salvato. Ovviamente questa che � la logica di Dio, di Ges�, della Chiesa, dovrebbe essere rispettata, ma accade che non lo sia. Oggi purtroppo non lo � sempre. Soprattutto � dimenticata, deve essere riproposta. Ebbene, il bimillenario dell�Incarnazione � visto come un gigantesco memoriale del dono che Dio fa del Figlio al terzo millennio�.
Ridurre l�attivit� d�impresa a mera materialit� ha condotto molti fuori strada, lontani dalla via della Vita. Negandosi appartenenze, affetti, passioni, sogni, progetti, molti hanno finito col convincersi che la variabile rilevante, se non esclusiva, nella vita dell�impresa � il denaro. Il denaro come obiettivo, il denaro come unica risorsa necessaria. Impropriamente attribuendo agli imprenditori una parziale visione del mondo[4] e della storia umana, l�impresa in Italia � stata spesso trattata come una macchina senz�anima, che consuma risorse finanziarie per produrne in un ammontare pi� alto. Poco � stata esplorata, e pochissimo � stata battuta, la possibilit� di guardare all�imprenditore come a un essere Vivente, mancandosi conseguentemente di evidenziare il profondo legame tra comunit� sociale e imprese, nonostante questo, proprio in Italia, sia forte ed evidente, connotando in maniera qualificante il nostro sistema produttivo (aziende familiari, piccole imprese, distretti industriali, made in Italy).
�� Da questi processi non � esente il modo in cui le societ� locali si strutturano intorno alle loro economie, offrendo a queste ultime le coordinate sociali all�interno delle quali si regola il mercato locale. E� in questo senso che, per esempio, la struttura familiare rappresenta una risorsa nello sviluppo dell�imprenditorialit� locale, nel duplice senso in cui favorisce la formazione dell�imprenditorialit� e offre, al contempo, lavoro che s�impiega nelle piccole imprese locali. Nel primo caso la nascita e lo sviluppo dell�impresa � intimamente connessa a percorsi familiari, le cui vicende s�intrecciano con la storia dell�azienda, sino al punto da rendere talvolta ardua l�individuazione di un confine tra la vita aziendale e quella familiare. Nel ripercorrere la loro vita lavorativa, gli imprenditori molto spesso non distinguono il tempo di lavoro da quello personale: nella ricostruzione degli eventi che segnano il loro vissuto, tutto � rimandato alla prospettiva dell�impresa, che vedono come un risultato al contempo dei propri impegni e dei propri sacrifici�[5].
E� l�orizzonte della Traditio-Redditio il traguardo. Le parole sono due, ma le due dimensioni configurano un binomio indissolubile, un�unica dinamica. Si riceve perch� si d�, e si d� perch� si riceve. Ma non ci sono aridi calcoli alla base di questo scambio, e, come in un matrimonio felice, c�� ben poco di egoistico o di avido. C�� la Vita, ma bisogna avere gli occhi puliti per vederla. Chi possiede ma non scambia, non esprime il proprio slancio animico. �A che giova all�uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima?�[6]
Un�impresa � soprattutto il progetto di un Uomo. L�etimologia soccorre: concorrere (correre insieme), competere (cercare insieme) sono le missioni eterne dell�impresa vitale, il mercato cos� risultando il campo energetico nel quale spiegare - e dal quale trarre - le proprie energie, verso un orizzonte indeterminato, impenetrabile e mutevole, nella fiduciosa ricerca del quale tutti gli ostacoli, di slancio, devono essere superati, i pericoli evitati, le opportunit� colte e valorizzate. �La conoscenza incontra nell�uomo un oggetto che non pu� essere colto nel suo principio per via di dissezione, cio� analiticamente, ma solo nella sinteticit� del suo essere�[7].
Cos� si � espresso il Pontefice, Giovanni Paolo II[8]: �In effetti la principale risorsa dell�uomo insieme con la terra � l�uomo stesso. E� la sua intelligenza che fa scoprire le potenzialit� produttive della terra e le multiformi modalit� con cui i bisogni umani possono essere soddisfatti. E� il suo disciplinato lavoro, in solidale collaborazione, che consente la creazione di comunit� di lavoro sempre pi� ampie e affidabili per operare la trasformazione dell�ambiente naturale e dello stesso ambiente umano. In questo processo sono coinvolte importanti virt�, come la diligenza, la laboriosit�, la prudenza nell�assumere i ragionevoli rischi, l�affidabilit� e la fedelt� nei rapporti interpersonali, la fortezza nell�esecuzione di decisioni difficili e dolorose, ma necessarie per il lavoro comune dell�azienda e per far fronte agli eventuali rovesci di fortuna�.
In senso convergente, Michael Novak[9]: �proprio al cuore del capitalismo, come hanno mostrato Friedrich von Hayek, Joseph Schumpeter e l�americano Israel Kirzner, vi � la virt� creativa dell�iniziativa. L�iniziativa �, prima di tutto, l�inclinazione a notare, l�abitudine al discernimento, la tendenza a scoprire ci� che gli altri non vedono ancora. E� anche la capacit� di concretizzare le intuizioni, cio� di realizzare cose mai viste prima. E� la capacit� di prevedere sia i bisogni degli altri sia le combinazioni di fattori produttivi pi� adatte a soddisfare tali bisogni. Questa abitudine intellettuale costituisce un�importante fonte di ricchezza nella societ� moderna �. Sembra che molti critici non abbiano mai immaginato il puro divertimento e il piacere creativo insito nel dare vita a un nuovo business. Una tale creativit� reca su di s� il timbro di una personalit� tutta particolare. Nel piacere che d� al suo creatore, rivaleggia, a suo modo, con la creativit� artistica�.
Internet e la liberalizzazione mondiale dei mercati disegnano uno scenario in cui le opportunit� di relazioni di scambio tra le persone sono tali da consentire forme di espressione inimmaginabili fino a pochi anni fa.
Le Istituzioni del terzo millennio dovranno sapersi porre in sintonia con questo meraviglioso potenziale di energia umana, formando pentagrammi su cui un infinito numero di melodie potranno essere composte.
Le strade praticate in passato, volte ad imporre schemi omogenei e ad imporre regole non condivise, genererebbero malessere, frustrazione, sfiducia in una entit� non pi� sostenibile. Le possibilit� di esprimere il proprio potenziale energetico sono tali che nessuna forma di compressione risulta pi� tollerata.
Se dunque i sapienti della Comunit� tentano di conservare le regole della convivenza fondate su quella visione che guarda all�impresa non come ad una parabola vitale, ma come a un freddo meccanismo economico, su quell�attitudine a frazionare in artificiosi segmenti l�unit� dell�esperienza imprenditoriale, ecco che si forma un�atmosfera sociale impregnata di elusioni, di sfiducia, di aggiramenti, di particolarismi inconciliabili l�uno con l�altro.
Interiorizzata questa visione nelle proprie strutture e funzioni, lo Stato italiano sembra continuare a credere di poter favorire lo sviluppo, attraverso elargizioni materiali miranti ad incrementare la produzione. In realt�, come un genitore che non ha fiducia nel proprio figlio, quelle elargizioni tendono a provocare solo danni, strutturando sudditanza e dipendenza, ingenerando sfiducia e paura. Il �pubblico�, non avendo compreso la necessit� di aggiornare la propria missione, cerca di sopravvivere con le branchie fuori dall�acqua, distraendo il privato dalle sue attenzioni, dai suoi talenti e dai suoi percorsi naturali (�vocazioni�). Non avendone compreso la natura, lo Stato si rivolge alle imprese ma finisce col fare loro del male, corrompendone gli impeti, frenandone gli slanci, scoraggiandone gli sforzi. Come un genitore che non ha compreso la personalit� del proprio figlio, e dunque non riesce a stabilire con lui un rapporto empatico fondato sulla credibilit� e l�autorevolezza, la Pubblica Amministrazione italiana tenta di risolvere tutto con il denaro: non d� quello di cui le imprese hanno bisogno, e d� invece loro ci� che ad esse nuoce.
Anzich� guardare al popolo del mercato per riceverne le indicazioni, lo Stato � diventato portatore di una propria cultura, di proprie convinzioni, di un proprio linguaggio. Non Democrazia, ma Burocrazia.
Cosa accade quando lo Stato riesce ad attrarre gli uomini verso le risorse amministrative (concorsi pubblici, incentivi finanziari all�investimento, etc.)?
� Il potenziale investitore/imprenditore distrae attenzione e risorse dall�osservazione dei mercati per orientarle invece all�osservazione delle dinamiche amministrative (norme; bando; moduli; procedure; etc.), cos� lasciandosi trascinare nel mondo delle monadi burocratiche;
� la variabile tempo, tradizionalmente ignorata nel settore pubblico ma fondamentale sui mercati, viene ad essere depurata della sua vitalit�. Lo Stato, nel disegnare il percorso per l�accesso alle risorse amministrative, chiede di non reagire agli impulsi della Realt�. Colui che cede alle tentazioni statali (e che non possiamo definire imprenditore) �, di fatto, indotto a pensare, e poi a realizzare, il suo investimento secondo i tempi dettati dagli uffici del ministero e non secondo le esigenze della realt� espresse dal mercato. La fisiologica, altissima complessit� del rapporto con l�ambiente, utilmente gestibile solo attraverso la libera intelligenza, subisce quindi la distorsione di una improbabile, artificiale semplicizzazione, quale quella imposta dalle condizioni del �bando�, il quale trasferisce cos�, perniciosamente, le proprie rigidit� astraenti ai comportamenti �privati�;
� spiazzamento del mercato bancario. Ci si continua sorprendentemente a sorprendere del fatto che le banche italiane stentano a sviluppare una condotta autenticamente imprenditoriale, in quanto mancherebbero di condividere i rischi dell�investitore finanziato, conservando l�attitudine a decidere sull�erogazione del prestito in base all�essere (propriet�) e non al divenire (qualit� del progetto d�investimento). Si manca per� talora di ricordare che lo Stato continua a �togliere affari� alle banche, svolgendo il compito che ad esse spetterebbe, quello di fornire capitale[10] agli imprenditori;
� compressione delle vocazioni. Seducendo con la prospettiva del finanziamento o dell�impiego pubblico, le Amministrazioni, anzich� incoraggiare alla ricerca di un asse di redditivit� (redditio) tra le proprie propensioni e gli orizzonti del mercato, attuano una canalizzazione burocratica dei percorsi aziendali e personali. Il fascino, purtroppo persistente, esercitato da risorse abbondanti e di facile acquisizione, sottrae tempo, energie, professionalit�, sensibilit� e fiducia rispetto alla �ricerca� attiva e tenace della propria vocazione, diseducando alla valorizzazione del vantaggio competitivo e deviando le rotte vitali dalle istanze del mercato verso le artificiali opportunit� partorite nei circuiti dell�Amministrazione. Nell�attuale perverso intreccio imprese-Stato, si compie il paradosso per cui, nello stesso istante in cui formalmente si accede allo status di imprenditori, almeno secondo la nominalistica delle leggi di sostegno finanziario all�investimento, nella sostanza ci si sta negando, forse irreversibilmente, la possibilit� di diventarlo sul serio. Alla possibile obiezione, secondo la quale le procedure di accesso ai fondi sarebbero pensate in sintonia con il mercato, si deve rispondere, serenamente, che questo � semplicemente impossibile. L�errore dei funzionari � lo stesso dei genitori protettivi: gli scienziati sociali, come pure gli uomini d�affari, sanno bene come l�evoluzione di un qualsiasi organismo vitale � e il Mercato lo � per eccellenza � sia imprevedibile e non codificabile a priori. Cos� si esprimeva al riguardo von Hayek: �Noi non siamo in grado di prevedere il futuro, gli uomini non sono in grado di prevedere il futuro. C�� l�imprevedibile e la libert� � lo strumento migliore per andare incontro all�imprevedibile�.
Gli Ulisse del mercato e della Vita, protagonisti delle imprese autentiche, intimamente agitati dall�attrattiva della proiezione verso le novit� dettate dalle infinite opportunit� dell�Odissea�concorrenza, non possono fermarsi a riposare nella Pubblica Amministrazione-Ogigia; essi resistono perci� al fascino della sirena burocratica e proseguono, con le proprie forze, la felice, faticosa ed incessante ricerca di nuove aree di profitto, muovendo con fiducia verso un orizzonte mobile (investimento - Penelope) cui pu� solo tendersi, ma che mai pu� definitivamente conquistarsi. L�emancipazione dell�Uomo dalla schiavit� del comando consente la Libert�, ma gli associa il requisito indefettibile della Responsabilit�: ne consegue una tensione vitale che non pu� spegnersi.
E� la visione della Vita esposta nel Vangelo. Cos� disse Ges�: �Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a portare pace, ma una spada. Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera: e i nemici dell�uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama il padre o la madre pi� di me non � degno di me; chi ama il figlio o la figlia pi� di me non � degno di me; chi non prende la sua croce e non mi segue, non � degno di me. Chi avr� trovato la sua vita, la perder�: e chi avr� perduto la sua vita per causa mia, la trover�� (Matteo 10, 34-39)..
�L'agente Kirzneriano d� luogo a un processo creativo che non potrebbe avere luogo se non vi fosse incertezza. Come in Schumpeter e Leibenstein, l'imprenditore di Kirzner � colui che vede ci� che gli altri non sono riusciti a vedere, e che trasforma tale alertness in nuova fonte di reddito per la comunit�, in profitto per s� stesso. Da von Mises sono invece mutuati i termini essenziali del legame fra imprenditorialit� e incertezza da un lato, fra imprenditorialit� ed economia di mercato dall'altro; mentre in von Hayek si trova forse formulato con maggiore chiarezza il contesto Kirzneriano di concorrenza, da intendersi questo come fenomeno dinamico, attraverso il quale l'operatore trasforma l'ignoranza in conoscenza, e tende verso una configurazione di equilibrio che per� non riuscir� mai a realizzare compiutamente. Sarebbe per� eccessivo negare a Kirzner gli elementi di originalit� che invece sono propri della sua scoperta imprenditoriale � Per Kirzner, l'imprenditore puro � dunque privo di mezzi di produzione, poich� l'atto imprenditoriale non consiste nell'organizzare e attivare le risorse, bens� nell'individuare le opportunit�. La scoperta imprenditoriale nasce dal nulla; se ci� non fosse, la remunerazione di tale scoperta - il profitto - sarebbe, di fatto, remunerazione delle risorse utilizzate. Come per von Mises, il profitto kirzneriano remunera dunque la scoperta imprenditoriale creatrice di nuovo reddito per la collettivit�; in tale veste, costituisce lo stimolo che motiva l'attivit� imprenditoriale e acquisisce un fondamento etico indiscutibile�[11].
Un�attivit� (materiale o immateriale) �crea� dunque valore soltanto se ci� che ne deriva pu� essere �scambiato�.
Facendo un piccolo passo in avanti, sentiamo di poter estendere questa lettura al campo degli studi umanistici, delle produzioni artistiche o delle proposte politiche: l�orientamento allo scambio obbliga il grande autore, il genio, il politico, a ricercare il consenso e a farsi �compreso�, o comunque �apprezzato�. E� l�altrui apprezzamento a fare ordine e premio; nessun altro riscontro avr� altrettanta forza e valore. Quella verso la relazionalit� � veramente una scelta di campo: essa �, nei due sensi, capace di effetti moltiplicatori. Imboccata una delle due strade, l�allenamento porter� ad accelerare, ad aumentare le dosi: attivando energie ulteriori in un caso (fiducia negli altri e in s� stessi; coraggio ed intraprendenza; desiderio e soddisfazione � in mutuo sostegno - dell�apprendimento continuo; piacere di interagire con le persone; propensione al cambiamento; capacit� di socializzazione; sensibilit� alle aspettative altrui; sim-patia), o viceversa smorzando sempre pi� ogni apertura (autoreferenzialit�; alterigia; prepotenza; antipatia; isolamento), nell�altro. In questo secondo caso, nella vicenda umana scatta qualcosa di demoniaco (demones sono �coloro che sanno�), perch� l�orientamento relazionale tende, progressivamente ed inesorabilmente, a venir meno, senza che chi ne sia vittima possa rendersene conto, ove si manchi di nutrirlo costantemente delle sollecitazioni provenienti da altri mondi, ove si affievolisca la disponibilit�, umile e tenace, di apprendere da quanto accade intorno.
Questo � per noi il Mercato: da sempre luogo vivo di scambio tra persone, tra culture e tra civilt�: occasione di arricchimento di tutti e di ciascuno.
Accade invece che tanti dei predicatori del confronto e del dialogo finiscano col disegnare traiettorie incoerenti con l�obiettivo dichiarato. Nelle societ� fondate sull�erudizione, la chiusura all�altro diventa �atmosfera ambientale�, provocando bizzarre gerarchie sociali, tali per cui parlare cosi� �bene� da non essere capiti, in questo strano mondo, diventa un titolo di merito.
Se differenziamo tra pena e incentivo con un metodo diverso da quello dei tecnici della legge, e quindi, come farebbe un bravo sociologo, in termini di sanzione e premio sociale, le dicotomie dittatura/democrazia e monopolio/concorrenza potrebbero diluirsi nel continuum che differenzia un ambiente propenso alla variet� e all�intraprendenza, da un altro socialmente orientato all�omologazione, alla grigia manutenzione dell�uguale.
I pericoli insiti nel precipitoso compattamento nella categoria della �devianza� - ineludibilmente accompagnata da diverse forme di condanna socio-istituzionale - di ogni digressione, di ogni novit� erano molto chiari a Franco Basaglia, il quale, negando la �pazzia� come categoria clinica, osservava come qualsiasi forma di oggettivizzazione delle soggettivit� segnali di un�arretratezza sociale. Se si approfondiscono le ragioni ispiratrici della nota legge 180 (chiusura degli ospedali psichiatrici), si possono rilevare le tracce di una svolta filosofica: la devianza riconosciuta non pi� come oggettiva patologia da curare tecnicamente, ma come variante personale da coltivare socialmente. Stiamo evidentemente camminando lungo il sentiero battuto da Joseph Schumpeter, che propugnava la �distruzione creatrice� come connotazione tipica dell�innovazione imprenditoriale, e da Erasmo da Rotterdam, con il suo �Elogio della Follia�.
Certo, �coloro che sanno� sono disposti a tutto pur di non negare il proprio sistema di convinzioni, pur di non arrivare a rivedere le premesse costitutive del sistema. Nel caso in cui si avvertisse un tale pericolo, i solitari del Tempio diventano capaci di sprigionare difensivamente inattesa audacia. Ma le difficolt� non devono scoraggiare, e non scoraggiano. "Qualsiasi persona, uomo o donna, pu� ottenere i miei stessi risultati se solo compir� lo stesso sforzo e coltiver� la stessa speranza e la stessa fede" (Gandhi). Quello che soprattutto stentiamo a riconoscere � che, mentre critichiamo astrattamente i severi pregiudizi degli �altri�, allo stesso tempo fra quegli �altri� andiamo a collocarci spesso anche noi. Se i grandi della storia hanno sempre vissuto, al principio della loro parabola, il disagio dell�essere circondati da scettici, allora, da buoni imprenditori, bisogna non lasciarci spaventare dai piccoli scetticismi che ci circondano, accettando semmai di essere grandi anche noi e dunque tenaci.
Questo essere ripiegati su s� stessi, pronti sempre a giudicare, mai a scrutare ed esplorare, a produrre ma non a scambiare, negando che dalla Realt� possa venire una sollecitazione utile o una novit� interessante, la si suole chiamare autoreferenzialit�.
Ma � forse necessaria un�Immagine pi� chiara e forte, per provare a comunicare quanto in essa si ponga una scelta decisiva, di morte. La Vita comunica tramite Simboli; si � preoccupata di manifestare i suoi segreti, utilizzando i momenti del proprio ciclo naturale come abbecedario per le nostre traiettorie umane. Tra i sui messaggi, scegliamo quello della Masturbazione. Facciamo riferimento all�onanismo infecondo per significare della condanna di ogni forma di autoreferenzialit�, la quale si nutre della solitudine, della chiusura e dell�immagine astratta e falsificata della Realt�. Il suo contrario � il rapporto amoroso, che necessita costitutivamente dell��altro�.
Il coronamento dello Scambio d�amore � la Creazione e la Vita.
L�imprenditore guarda sempre agli altri, ed in funzione del loro apprezzamento accetta di cambiare continuamente s� stesso; egli insegue i clienti (non tutti, ma solo coloro che rientrano nel target, insomma l�anima gemella), li corteggia con audace fantasia, affinando cos� la ricerca della propria vocazione e capacit� distintiva (�vantaggio competitivo�), e infine li �fidelizza�. Tutto � in funzione dello Scambio. L�impresa replica la parabola della Vita.
Il vizio dell�egotismo saccente e dell�autocompiacimento farisaico sembra ispirare invece l�organizzazione amministrativa, come pure i saperi disciplinari compartimentati, come pure � va detto - tanta parte di intellettuali che non si preoccupano di chiarire e di chiarirsi, di spiegare e di spiegarsi, di squarciare cio� le immagini dotte per vivificarle nella quotidiana esperienza. Un vizio del genere, quello di non comunicare l�utilit� di un �bene� ai suoi potenziali fruitori, non potr� mai accedere allo statuto comportamentale dell�imprenditore, pena il suo �fallimento�. Se tutto � Vita e tutto � mercato, il valore di qualsiasi bene risiede nell��apprezzamento� che gli altri ne facciano: non � un giudizio, � un�identit�. Si pu� dire di pi�: il �bene� � tale se rientra in un processo di traditio-redditio; ove ci� non fosse, si tratterebbe non di un bene, ma di un male. In ogni momento di comunicazione mancata � qualunque ne sia l�oggetto - non �fallisce� mai il pubblico dei potenziali riceventi, ma sempre e soltanto l�emittente incapace, che sia un sacerdote, un professore o un�azienda. Chi non sa scambiare non � imprenditore, ma non � nemmeno filosofo, insegnante, artista, politico. Falliti saranno perci�, sempre, tutti coloro che non ricercano, non coltivano e non sviluppano una capacit� dialogica, l�attitudine all�ascolto e alla relazione, la propensione all�esplorazione della novit�, l�inclinazione all�osservazione, la disponibilit� alla sperimentazione. Fallisce chi non compete, chi non ricerca con gli altri la Vita. Muore chi non scambia; non si pu� vivere senza respirare (inspirare ed espirare).
L�interpretazione - si osservi - si presta ad ogni estensione: per uno studente �imprenditore�, l�orientamento del momento istruzione/formazione alle prospettive di sbocco sul mercato del lavoro, da congiunzione facoltativa ed accessoria, diventa elemento essenziale, intrinsecamente incardinato in un ciclo unitario.
Le parole consentono di dividere ci� che nella Realt� � inscindibile.
L�approccio solitario conduce al �fallimento�[12] (disoccupazione):: l�altrui apprezzamento garantisce insieme espressione di un potenziale, reddito individuale e benessere sociale.
Costituisce Reddito ogni forma dell�appagamento che si trae quando la propria laboriosit� intelligente sfocia nella sperimentata capacit� di essere utili agli altri. Sull�unicit� di ogni vocazione, sulla meravigliosa scoperta che ciascuno pu� fare della propria, pagine impareggiabili ha scritto Michael Novak[13]: �Abbiamo la sensazione di avere scoperto il nostro destino personale, di essere riusciti a contribuire utilmente al benessere comune, di avere fatto qualcosa che senza di noi non sarebbe esistito � e, soprattutto, qualcosa che sapevamo fare bene e che ci � piaciuto fare�.
L�ordinamento italiano sembra ignorare questi argomenti. La sfiducia aprioristica nell�istituzione �Mercato�, e nei suoi principi vitali, che ispirava una parte consistente delle forze politiche protagoniste della redazione della Costituzione italiana del 1948, port� a guardare alla funzione sociale dell�impresa come ad un ossimoro. In quella visione, l�impresa perseguirebbe soltanto il proprio bene, antagonistico a quello degli altri; la funzione sociale sarebbe qualcosa di ulteriore, di esogeno, di forzato, quasi inconciliabile con la vera natura imprenditoriale. Tale concezione trova ancor oggi accoglienza nella nostra Costituzione (art. 41 comma 2): �la legge determina i programmi e i controlli opportuni perch� l�attivit� economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali�. Nell�interpretazione proposta dallo Statuto repubblicano dev�essere la legge, il comandamento statale a �garantire il bene�. E� il trionfo della visione dualistica, cartesiana, in cui il male (impresa) � sopportabile fino a una certa soglia, dopodich� subentra il gigante buono (Stato) a rimettere le cose a posto, decidendo cos�� giusto fare.
D�altra parte, la Costituzione italiana del 1948, come si sa, era espressione di un compromesso ed interiorizzava anch�essa il principio del conflitto di classe e del dualismo tra capitale e lavoro, nell�ambito del quale per lavoratore deve intendersi soltanto il lavoratore subordinato legato all�azienda da un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Rispetto a tale dualismo, la Costituzione della Repubblica Democratica Germanica (7 ottobre 1949), pi� solida e compatta nei principi di fondo, aveva potuto svilupparsi in maniera pi� coerente. La Costituzione italiana (1 gennaio 1948) riconosce il diritto al lavoro (art. 1: L�Italia � una Repubblica democratica fondata sul lavoro�; art. 4: �La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro ��), ma si cimenta nel tentativo impossibile di considerare con esso conciliabile il principio della libera concorrenza. La Costituzione della Repubblica Democratica Germanica, con indubbia coerenza, poteva invece sancire all�art. 15: �Il lavoratore gode della protezione dello Stato.Il diritto al lavoro � garantito. Dirigendo l�economia, lo Stato assicura lavoro e sussistenza a tutti i suoi cittadini�.
Nella stagione delle Riforme, all�alba di un nuovo millennio, ci aspetteremmo la Buona Novella fondata sulla Fiducia nell�Uomo-imprenditore, con una disposizione costituzionale di questo tipo: �L�Italia � una Repubblica democratica fondata sulla Competizione�, che sancisca come sia solo il libero svolgersi degli scambi a poter garantire il conseguimento di quei fini che la legge ha astrattamente posto, ma concretamente precluso[14]. Saremmo all�anno zero di una totale trasformazione, la svolta epocale dall�Antico al Nuovo Testamento della Repubblica.
�Togliamo dunque ogni valore alla legge mediante la fede? Nient�affatto, anzi confermiamo la legge.�[15] �Che dunque? Dobbiamo commettere peccati perch� non siamo pi� sotto la legge, ma sotto la grazia? E� assurdo!�[16] �Fratelli miei, sono anch�io convinto, per quel che vi riguarda, che voi pure siete pieni di bont�, colmi di ogni conoscenza e capaci di correggervi l�un l�altro�[17] �Cos� la legge � per noi come un pedagogo che ci ha condotto a Cristo, perch� fossimo giustificati per la fede. Ma appena � giunta la fede, noi non siamo pi� sotto un pedagogo.�[18] �Cristo ci ha liberati perch� restassimo liberi; state dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavit�. Ecco, io Paolo vi dico: se vi fate circoncidere, Cristo non vi giover� nulla. E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli � obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Non avete pi� nulla a che fare con Cristo voi che cercate la giustificazione nella legge; siete decaduti dalla grazia. Noi, infatti per virt� dello Spirito, attendiamo dalla legge la giustificazione che speriamo. Poich� in Cristo Ges� non � la circoncisione che conta o la non circoncisione, ma la fede che opera per mezzo della verit�.�[19].
Sono la premessa e il fine a dare chiarezza di senso ai percorsi umani. I fatti accorrono a conforto: pensiamo a se, quotidianamente, confidiamo pi� in un rapporto fiduciario o in un contratto ben strutturato. La dimensione connettiva delle relazioni umane fonda in realt� non sulla dimensione legale � sempre relativa, eludibile ed eticamente deresponsabilizzante - bens� sulla dimensione, assoluta, della Fiducia e della reputazione. La fiducia, fattore fondante del Mercato e di ogni Comunit�, fluidifica, semplifica, facilita; chi sceglie di collocarsi fuori di essa opera una scelta decisiva, irreversibile. La colpa di aver violato la legge � espiata e si estingue; a m� di obbligazioni alternative verso la comunit�, le pene attribuite giudizialmente sono avvertite come il corrispettivo puntuale ed esaustivo dell�abuso. Al contrario, la sanzione sociale della condotta libera e disonorevole � irreversibile, irrecuperabile: la sua costosit� � infinita, non comparabile con il peso della condotta onesta. Il discredito sociale non ha un rapporto diretto con la natura o l�entit� della violazione: esso non si esercita puntualmente, ma si diffonde nell�atmosfera, in quanto attiene ad una diversa dimensione, quella della dignit� e della credibilit� della persona.
I due principi, si badi, sono antitetici, inconciliabili: dall�uno all�altro non � possibile trascorrere senza una discontinuit� o un Passaggio. �Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per noi �[20].
Un orientamento legalistico al dato formale erode l�attitudine alla sanzione sociale, sicch� il trasgressore pu� giovarsi degli interstizi giuridici (evasione, elusione, sanzione amministrativa, rinvii, formalismi, indimostrabilit�, etc.) per farla franca, cos� addirittura risultando, agli occhi degli altri, furbo, scaltro, capace. La societ� fondata sul profilo etico della responsabilit� pu� perdonare, ma non per questo dimentica; non distingue tra abusi fragorosi e piccoli espedienti; non riconosce attenuanti se all�adesione formale alle regole si accompagna nella sostanza l�inganno. Il sistema del passaparola, delle referenze, della reputazione funge da linfa istituzionale della relazionalit� fiduciaria. O s� o no, o vero o falso: stratagemmi non se ne ammettono. In una societ� fondata sulla Fiducia, lo Scambio � facile; chi perde la fiducia � che sia un�impresa o che sia un Ufficio pubblico � non potr� pi� scambiare, e fallir�.
Sarebbe forse bene � almeno questa � la nostra speranza - che si trasformassero in imprenditori tutti coloro i quali si ostinano ad attribuire valore autonomo alle proprie azioni e virt� (produzione), relegando a vile marginalit� l�altrui riconoscimento (scambio). Siffatto comportamento genera non il processo del �competere� (cercare insieme), ma quello del �contendere� (tendere insieme, ciascuno da una parte, l�unico bene): chi fonda sui dualismi, mira ad alimentarne sempre di nuovi. L�io presuppone la conflittualit�, e se ne nutre (Fichte). La competizione determina una crescita continua, inarrestabile, potenzialmente universale. La contesa esclude la creazione dinamica e presuppone invece un oggetto; la vittoria dell�uno implica specularmente la sconfitta dell�altro. Nella contesa, l�Io[21] - che tende ad affermarsi come �solitudine del s�, esaltando la propria individualit� � sussiste solo se si confronta con un �Tu�; ed al tempo stesso, per affermarsi, deve distruggerlo. Il �competere� � un gioco la cui fine sta nell�orizzonte: vi si pu� tendere, ma non lo si pu� raggiungere. La competizione presuppone il �noi�, e quindi la continuit� della libert� plurale propria del Mercato, in una cornice di valori condivisi. Nel gioco del mercato ogni giocatore necessita degli altri: se ci fosse un unico vincitore, questi sarebbe anche il perdente.
Ci precluderemmo la possibilit� di comprendere se associassimo all�imprenditore un animus di mero arricchimento materiale: in realt�, l�imprenditore profitta della ricerca, quest�ultima essendo la sua missione vitale, la sua ragione identificativa. E� solo cos� che si pu� spiegare come l�imprenditore non si accontenti mai, per definizione, sempre �ricercando� nuove opportunit�, nuove sfide, nuovi rischi.
Il profitto non � il fine, ma il mezzo. Il vero fine � l�investimento stesso, con la tensione vitale che vi si associa e che ci fa sentire Uomini vivi.
[1] Trabucchi A., Istituzioni di diritto civile, Cedam, 1983.
[2] Robbins L., Saggio sulla natura e importanza della scienza economica, Utet, Torino, 1947, cit. in: in: Zamagni S., Economia politica, la Nuova italia Scientifica, Roma, 1984.
[3] Cesare Bissoli, membro del comitato nazionale per la Giornata mondiale della giovent�.
[4] Marx K. Manoscritti economico-filosofici (1844) �Ci� che mediante il denaro � mia disposizione, ci� che io posso pagare, ci� che il denaro pu� comprare, quello sono io stesso, il possessore del denaro medesimo � Le caratteristiche del denaro sono le mie stesse caratteristiche e le mie forze essenziali, cio� sono le caratteristiche e le forze essenziali del suo possessore � e se il denaro � il vincolo che mi unisce alla vita umana, che mi unisce alla societ�, che mi collega con la natura e gli uomini, non � il denaro forse il vincolo di tutti i vincoli, il vero cemento, la forza galvano-chimico della societ�?� citato in: �Avarizia� di Umberto Galimberti, La Repubblica, 17 agosto 2001.
[5] De Vivo P., Attivit� di impresa e societ� locali nel Mezzogiorno. Il sistema moda della provincia di Napoli, in: Viesti G. (a cura di), Mezzogiorno dei distretti, 2000 Meridiana Libri, Corigliano Calabro (Cs).
[7] D�Agostino F., Bioetica, Giappichelli, 1998.
[8] Enciclica Centesimus Annus (1991), in: Novak M., L�impresa come vocazione, Rubbettino, 2000.
[9] Novak M., L�impresa come vocazione, Rubbettino, 2000.
[11] Colombatto E., Dall�impresa dei neoclassici all�imprenditore di Kirzner (articolo estratto da un sito internet).
[12] Nelle regioni meridionali italiane esiste un altissimo grado di disoccupazione intellettuale: giovani laureati che non riescono a trovare un impiego. Ma bisogna dire di pi�: � l�equilibrio generale, comprensivo di chi lavora, ad essere precario, insano. Moltissimi laureati in giurisprudenza trascorrono anni ed anni per preparare il concorso per poter diventare magistrati, mentre per i laureati in economia e commercio � considerato inevitabile diventare �commercialista�. Tra innovazione tecnologica e liberalizzazione mondiale dei mercati la situazione � da �conquista del West�, eppure molti giovani meridionali, intaccati nell�autostima, culturalmente drogati da un�omologazione pervasiva e deprivati di ogni slancio energetico, accettano indegni tirocinii, umilianti prebende, lasciandosi cadere nel precipizio della rassegnazione, senza nemmeno tendere una mano alla ricerca di un appiglio. Ci� peraltro gi� sapendo che su quelle strade nessun orizzonte domani si potr� schiudere: non ci si sforza, non si sperimenta, non si esplora. Uomini di poca fede. Tanto, si dice, la vita questa �. Ad impossibilia nemo tenetur ecco il movente di questo suicidio collettivo. Chi disegna traiettorie diverse va emarginato: o � raccomandato, o � un ladro, o � fortunato; meglio scartare altre ipotesi. L�autocritica, il cambiamento, l�impegno tenace, il rischio sono materiale ad alta carica esplosiva: meglio starne alla larga!
[14] �Le leggi che proibiscono di portar le armi sono di tal natura; esse non disarmano che i non inclinati n� determinati ai delitti, mentre coloro che hanno il coraggio di poter violare le leggi pi� sacre della umanit� e le pi� importanti del codice, come rispetteranno le minori e le puramente arbitrarie, e delle quali tanto facili ed impuni debbon essere le contravvenzioni, e l�esecuzione esatta delle quali toglie la libert� personale, carissima all�uomo, carissima all�illuminato legislatore, e sottopone gl�innocenti a tutte le vessazioni dovute ai rei? Queste peggiorano la condizione degli assaliti, migliorando quella degli assalitori, non iscemano gli omicidii, ma gli accrescono� � Cesare Beccaria, op. cit.
[15] La Sacra Bibbia, Lettera di S. Paolo ai Romani, 3, 31.
[16] La Sacra Bibbia, Lettera di S. Paolo ai Romani, 6, 15.
[17] La Sacra Bibbia, Lettera di S. Paolo ai Romani, 15, 14.
[18] La Sacra Bibbia, Lettera di S. Paolo ai Galati, 3, 24.
[19] La Sacra Bibbia, Lettera di S. Paolo ai Galati, 5, 1.
[20] La Sacra Bibbia, Lettera di S. Paolo ai Galati, 3, 13.
[21] Romano Vincenzo Maria, Il terzo millennio di Penelope, Simone, Napoli, 1998.
L� economia civile
di Flavio Felice*
�Ascolta
il ritmo uguale dei martelli, cos� noto
io lo proietto negli uomini, per saggiare la loro forza d�ogni colpo.
Ascolta, una scarica elettrica taglia il fiume di pietra, e in me cresce un
pensiero, di giorno in giorno:
che tutta la grandezza del lavoro � dentro l�uomo�
(Karol Wojtyla, La cava di pietra, 1956)
Il progetto della societ� civile
L�agire economico imprenditoriale rappresenta, in una certa misura, la risposta sia ad un�essenziale inclinazione dell'uomo di natura relazionale sia a forti motivazioni razionali. Ci� � riscontrabile anche osservando il modo in cui la creazione di forme di vita sociali ha permesso il raggiungimento di obiettivi che sarebbero risultati impossibili all�azione del singolo individuo. Da tale assunto ne consegue l'esigenza di pensare ad una figura d'uomo che si completa e si realizza nella misura in cui si apre al rapporto con l'altro; in tal modo il bene comune � politico, economico e culturale - ci appare come un valore perseguito in tutti i suoi aspetti sociali e morali e raggiunto dall'azione coordinata dei singoli e delle comunit�.
Simili considerazioni ci spingono a riflettere su una dimensione rilevante dell�odierno dibattito tra etica ed economia d�impresa, ovvero, per essere pi� precisi, evitando ci� che potrebbe apparire come un improprio dualismo, ci inducono ad approfondire i contenuti che emergono dalla riflessione sulla scienza economica, in quanto scienza umana, ed il modo in cui essa si relaziona con il naturale dinamismo della societ� civile, di cui l�agire economico imprenditoriale � parte rilevante e costitutiva. Tale dinamismo si esprime mediante una sfera di raggruppamenti sociali � l�impresa rappresenta uno di questi raggruppamenti -, all�interno della quale opera una ben distinta �cultura civica� che la pone in posizione di critica nei confronti dell�esercizio del potere politico[1]. Dunque, la nozione di societ� civile dalla quale intendiamo muovere non poggia sull�idea che la vita sociale � irrimediabilmente condannata alla prevaricazione di una parte pi� forte sull�altra pi� debole, sicch� dovremmo rassegnarci alla presenza invasiva di un potere coercitivo che tutto regolamenta e disciplina.
Accanto alla ferma convinzione dei rischi derivanti da una nozione di societ� civile asservita e succube della tendenza dello stato ad invadere aree di competenza che non gli competono, rileviamo i rischi derivanti dalla tendenza altrettanto distruttiva di una malintesa nozione di societ� civile come mera alleanza tra gruppi di potere (politico, economico e culturale) che sommano la forza dello stato con quella di particolari gruppi di interesse, ostacolando le legittime funzioni del governo.
Si sostiene, dunque, che la societ� civile non rappresenta lo strumento di legittimazione del potere coercitivo, n� tanto meno l�arena nella quale le lobbies si scontrano per il reciproco annientamento, bens� la linea di confine e l�elemento critico che dall�esterno esercita il controllo del potere e ne impedisce la tracimazione, fagocitando il pluralismo delle formazioni sociali, ossia, quella rete di corpi intermedi che svolgono l�ineludibile funzione di tenere a debita distanza, entro i propri argini, il potere politico e le istanze particolari. Ebbene, l�impresa economica, con tutta la rete civile che essa � in grado di muovere e promuovere, rappresenta un soggetto indispensabile per la realizzazione di un simile progetto democratico.
L�economia civile
Ci� premesso, passiamo a considerare direttamente il tema della funzione civile, ovvero di argine e di critica, svolta dalla libera economia d�impresa.
Nell�enciclica Centesimus annus, Giovanni Paolo II chiarisce i termini della questione. Il Pontefice opera un�importante distinzione fra un tipo di �capitalismo� (o �economia d�impresa�) fondato sul ruolo positivo svolto dalle aziende, dal mercato, dalla propriet� privata e dal libero, responsabile e creativo agire della persona, ancorata ad un saldo sistema giuridico e ad un chiaro orizzonte ideale che � dato dalla verit� di Dio sull�uomo, e un altro tipo sul quale il suo giudizio � estremamente negativo, in quanto non inquadrato in un solido sistema di regole e la libert� che lo caratterizza, distaccandosi dalla verit� sull�uomo, non � posta al servizio dell��integrale libert� umana, il cui centro � etico e religioso�[2].
� interessante notare come, forse per la prima volta nella storia della dottrina sociale della Chiesa si faccia riferimento in modo cos� diretto ed esplicito a categorie quali l'impresa e il mercato, al punto che � lo stesso autore dell'enciclica a definire quel tipo di economia come "economia d'impresa", "economia di mercato", "economia libera". Queste categorie, se ben intese, possono rappresentare gli elementi di un'economia civile capace di rispettare ed esaltare il valore trascendente della persona umana.
Il mercato, nella prospettiva dell�economia civile, lungi dallo scomparire o dall�essere demonizzato, � interpretato come processo dinamico di reciproca conoscenza, un processo catallatico[3] � ossia il processo mediante il quale da nemico si diventa amico e da estraneo si diventa parte di una comunit� � rappresentato dall�insieme delle relazioni tra soggetti liberi e responsabili, e non uno spazio da occupare, un luogo da conquistare. In definitiva, un gioco a somma zero, in virt� del quale al successo economico di a corrisponderebbe il fallimento di b, una sorta di spartizione della torta in fette, ove se qualcuno possiede � perch� qualcun altro ha rinunciato oppure gli � stato estorto. Sulla base di tale analisi, apparirebbe legittimo il giudizio di condanna morale nei confronti del mercato, inteso come una giungla nella quale vincono sempre i pi� forti, i pi� furbi e i pi� spregiudicati. La tendenza a pensare il mercato come uno spazio fisico, nel contesto di una dimensione temporale astratta, nasce dalla volont� dei teorici dell'ortodossia economica neoclassica di seguire i successi avuti nel campo della fisica newtoniana, trasferendoli nell�ambito delle scienze sociali e trasformando il discorso economico in una scienza che studia automi, piuttosto che reali esseri umani. Il mercato, secondo quanto detto in ordine alla societ� civile, � il processo relazionale mediante il quale ciascuna persona � consapevole di poter soddisfare i propri bisogni e desideri a partire dal riconoscimento dei bisogni e dei desideri degli altri.
Similmente, cos� come per la categoria mercato, � possibile intraprendere un percorso analogo con riferimento alla categoria del puro profitto imprenditoriale. Esso, sempre nella prospettiva dell�economia civile, non � una quota di benessere che l�imprenditore sottrae alle parti che compongono l�impresa. Il profitto, pur non essendo lo scopo dell�impresa, rimane un parametro cruciale: � il mezzo per continuare a fare impresa. Il giusto test per ogni impresa non � la massimizzazione del profitto[4], ma il raggiungimento di un profitto sufficiente a coprire il rischio insito nell�attivit� economica ed evitare cos� le perdite[5]. In definitiva, il profitto � un elemento necessario per pagare il raggiungimento degli obiettivi che l'impresa si prefigge, consente all'impresa di sopravvivere e rappresenta il prezzo del futuro, ossia il prezzo che deve pagare per restare sul mercato. In questi termini, la funzione civile del profitto, che possiamo schematizzare come premio per il rischio, fonte di capitale per finanziare l'occupazione di domani, fonte di capitale per l'innovazione e l'espansione dell'economia, si comprende meglio se associata alla dinamica tipica dell'uomo d'impresa, il quale, ci fa notare opportunamente Drucker, esercita la funzione imprenditoriale mediante la quotidiana e sistematica attivit� decisionale, con la maggior conoscenza possibile del futuro incerto, organizzando in modo sistematico gli sforzi necessari per realizzare quelle decisioni ed infine confrontando i risultati con le aspettative.
Talvolta il voler distinguere nettamente la sfera etica da quella del mercato rischia di perpetuare la dicotomia tra ci� che � economico, intendendo con esso il regno della razionalit�, dell�efficienza e della spregiudicatezza, da ci� che � sociale, come se l�eticit� dell�azione non comprendesse la sfera razionale. L�insistere su tale dicotomia ha rappresentato la fonte primaria del discredito che per anni ha colpito l�intrapresa economica e un alibi per coloro che intendono l�agire imprenditoriale come irrimediabilmente condannato all�assunzione di scelte spregiudicate, negligendo l�inutile disturbo di rendere conto dei valori e di rispettare quei diritti in grado di presentare una nozione di uomo come persona.
Affermare il valore civile dell�economia d�impresa significa in primo luogo riconoscere a coloro che operano in questa entit� un ruolo decisivo nell�edificazione del progetto della societ� civile. Un elemento fondamentale di questa riflessione � dato indubbiamente dal fatto che si considerano una nozione d�impresa ed una d�imprenditorialit� che ci permettono di inquadrare l�agire economico nel pi� generale dinamismo dell�agire umano, evitando di oscillare � parafrasando l�economista tedesco R�pke - tra un moralismo ottuso ed un razionalismo dogmatico, avendo assunto come archetipo antropologico l�homo agens, piuttosto che l�idealtipo dell�homo oeconomicus[6]. Di conseguenza, l�imprenditorialit�ci appare come la capacit� (virt�) - esercitata in un qualsiasi intervallo di tempo - che rivela la soggettivit� creativa della persona - che le consente di accrescere la propria umanit� e che le permette di porre in essere nel tempo presente un�organizzazione del lavoro produttivo, in considerazione delle condizioni incerte di un futuro ignoto; ovvero l�attitudine, sottoposta a vincoli, a gestire (oggi) i flussi produttivi presenti sul territorio, facendoli interagire con il principale fattore di produzione: il capitale umano[7], per la realizzazione di beni e servizi da destinare al mercato (domani). Accanto a questa definizione d�imprenditorialit�, per non sfuggire alla responsabilit� di rappresentare anche l�organizzazione aziendale che comunemente chiamiamo impresa, proponiamo la seguente nozione: in quanto �comunit� di uomini�, l�impresa � costituita da tutti coloro che ne hanno intenzionalmente sottoscritto i contratti costitutivi, un luogo imperfetto di cooperazione sociale il cui fine primario e fondamentale, ovvero immediato, � la soddisfazione del cliente[8], attraverso il miglioramento continuo dei prodotti e dei processi produttivi, avendo cura dei rapporti tra le parti che la compongono.
In questa prospettiva, l�impresa economica rappresenta una fonte inestimabile per la produzione di un valore civile fondamentale per l�edificazione di una societ� libera e virtuosa: il senso di responsabilit� ed il coraggio nell�assumersi il ragionevole rischio. Si comprende, allora, che in una societ� complessa nella quale l�esercizio della sovranit� � irriducibile al ruolo esclusivo di un determinato gruppo di potere, ma si esplica in una raffinata rete di rappresentazione e difesa di interessi contrapposti mediante il sistema dei pesi e contrappesi, si guardi al mondo dell�impresa economica come ad un indispensabile nodo che disegna la trama e l�ordito della societ� civile. L�articolazione civile che ne consegue � ben espressa dal principio di sussidiariet�: �una societ� di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una societ� di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessit� e aiutarla a coordinare la sua azione con quelle delle altre componenti sociali, in vista del bene comune�[9]. In questo passo della Centesimus annus, Giovanni Paolo II, oltre a sottolineare i pericoli e gli abusi provenienti da un grande ed impersonale Leviatano, afferma l�importanza delle istituzioni della societ� civile, quelle speciali comunit� di vicini che, nel corso degli ultimi decenni, hanno assunto varie denominazioni: comunit� intermedie, comunit� solidali, piccoli plotoni, mondi vitali. Ad ogni modo, ci� che caratterizza tali entit� sociali � il loro concreto agire nella vita umana, favorendo, in tal modo, il senso di responsabilit� dei membri che compongono la societ�, valorizzando le energie in essa presenti e nello stesso tempo scongiurando l�eccessivo aumento degli apparati burocratici che, lontani dai bisogni reali degli utenti, non ne colgono la domanda umana pi� profonda.
Consentitemi di concludere questa brevissima riflessione citando le parole di Alexis de Tocqueville, uno dei massimi scienziati sociali del XIX secolo, un autore che ha dedicato la propria vita intellettuale alla ricerca del miglior ordine politico, consapevole dell�irriducibile limitatezza e fallibilit� dell�agire umano. Proprio in forza di tale ferma consapevolezza etica ed epistemologica non consider� mai perfette e definitive le labili e caduche costruzioni umane e non confuse mai l�umana tensione a migliorare, imparando dagli errori propri ed altrui, con la �presunzione fatale� di costruire il Paradiso sulla terra. Una simile impostazione etico-antropologica gli consent� di affermare che il fondamento della democrazia � la virt� praticata dai membri della societ� per dar vita ad associazioni per il bene della comunit�. L�impresa economica, secondo questo modello di analisi, � il risultato di un processo storico, dinamico ed evolutivo, mai perfetto, ma perfettibile, che le donne e gli uomini della terra hanno posto in essere nel tentativo di rispondere ai problemi quotidiani della vita, imparando dai loro errori, agendo in modo creativo e responsabile, per il bene proprio e della famiglia umana.
Tocqueville, sottolineando gli elementi che caratterizzano le societ� aristocratiche e quelle democratiche, cos� si espresse:
�[�] presso i popoli democratici tutti i cittadini sono indipendenti e deboli, non possono quasi nulla da soli e nessuno di loro pu� obbligare gli altri a prestargli aiuto. Quindi, se non imparano ad aiutarsi liberamente, cadono tutti nell�impotenza�[10]
* Insegna Dottrine Economiche e Dottrina Sociale della Chiesa alla Pontificia Universit� Lateranense di Roma.
[1] Cfr. Pierpalo Donati, Alla ricerca di una societ� civile. Che cosa dobbiamo fare per aumentare la capacit� di civilizzazione del paese?, in Aa.Vv., La societ� civile in Italia, a cura di P. Donati, Mondadori, Milano 1997, p. 22.
[2] Cfr. Giovanni Paolo II, Centesimus annus, Citt� del Vaticano 1991, n. 42.
[3] �Per indicare la scienza che studia l�ordine di mercato, si � suggerito molto tempo fa, ed � stato pi� recentemente riesumato, il termine �catallassi�: mi sembrerebbe appropriato utilizzarlo qui. Il termine �catallassi� deriva dal verbo greco katallattein (o katallassein), col quale si intendeva -ed � significativo- non solo �scambiare� ma anche �ammettere nella comunit�� e �diventare da nemici amici��, Fredrich August von Hayek, Legge, legislazione e libert�. Una nuova enunciazione dei principi liberali della giustizia e dell�economia politica, Il Saggiatore, Milano 1986., p. 315.
[4] �Molto � rappresentato dalla scoperta attorno agli anni Venti della formula generale per la massimizzazione del profitto: ricavo marginale uguale a costo marginale�; L Robbins, L�evoluzione della teoria economica moderna, intervento alla London School of Economics, 30 settembre 1960, in L. Robbins, La misura del mondo, Ponte alle Grazie, Milano 2001, p.502.
[5] Cfr. P: Drucker, Manuale di management: compiti, responsabilit� metodi, Etas Libri, Milano 1991, p. 68.
[6] Pur non negando il valore euristico e logico di questa nozione che ci consente di costruire modelli astratti e formali cui confrontare gli squilibri e le incongruenze del mondo reale.
[7] �L�analisi sul capitale umano prende avvia dall�assunto che gli individui decidono della loro educazione, formazione, assistenza medica, soppesano i costi e i benefici. I benefici includono vantaggi di tipo culturale e altri di carattere non monetario insieme alla crescita del profitto e dell�occupazione, mentre i costi generalmente dipendono dal valore presunto del tempo necessario per porre in essere questi investimenti. Il concetto di capitale umano racchiude anche il lavoro accumulato e altre virt�, compresi i fattori dannosi, quali ad esempio fumo ed uso di droghe. Il� capitale umano, sia che si esprima sotto forma di sane virt� lavorative sia che si manifesti nell�alcolismo, � in grado di produrre, rispettivamente, i migliori o i peggiori effetti sulla produttivit��; G. Becker, �Nobel Lecture�, The Economy Way of Looking at Behavior, pubblicato in G. Becker, The Essence of Becker, a cura di R. Ferrero � P. S. Schwartz, Hoover Press, Stanford 1995, p. 640.
[8] Cfr. P. Salin, Liberalismo, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2002, p. 170.
[9] Centesimus annus, n. 48.
[10] Alexis de Tocqueville, La democrazia in America, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1999 (II ed.), p. 524.
Le Ragioni Etiche Dell�Economia Di Mercato. Riflessioni sul personalismo economico in Luigi Sturzo
di Flavio Felice
Che cos�� il liberalismo? [...] Esso � umanistico. Ci� significa: esso parte dalla premessa che la natura dell�uomo � capace di bene e che si compie soltanto nella comunit�, che la sua destinazione tende al di sopra della sua esistenza materiale e che siamo debitori di rispetto ad ogni singolo, in quanto uomo nella sua unicit�, che ci vieta di abbassarlo a semplice mezzo. Esso � perci� individualistico oppure, se si preferisce, personalistico.
(Wilhelm R�pke)
La base della giustizia naturale, o diritto di natura, pu� fissarsi nella coesistenza dei diritti e reciprocit� dei doveri; e questa trasporta il valore soggettivo dei diritti e doveri della personalit� umana nel suo ordine sociale oggettivo [...]. E� la personalit� dell�uomo, in quanto razionale, non solo soggetto del diritto ma sorgente del diritto: non � la societ� o lo Stato, come alcuni pensano, la sorgente del diritto.
(Luigi Sturzo)
Introduzione
I brani riportati come introduzione al presente contributo hanno lo scopo di chiarire in modo immediato il punto di vista, la prospettiva ed il tipo d�approccio che intendiamo far propri nella riflessione sulle ragioni etiche del libero mercato. Grazie alle sollecitazioni dei due autori abbiamo cominciato a pensare alla concreta possibilit� di conciliare alcuni aspetti tipici della Dottrina Sociale della Chiesa con altrettanti aspetti caratterizzanti la tradizione di quel particolare filone del liberalismo moderno, rappresentato dal liberalismo della Scuola austriaca di economia, cosiddetto classico o angloamericano. Procederemo in questa direzione dedicando particolare attenzione alla riflessione di un grande pensatore italiano, il sacerdote siciliano, fondatore del Partito Popolare Italiano, Luigi Sturzo (1871-1959). Sociologo, filosofo, statista, capace, sul finire del secolo scorso, di inaugurare una nuova stagione del cattolicesimo politico: il popolarismo[1]. Nel 1924, a causa del suo antifascismo, fu messo nelle condizioni di dover lasciare l�Italia ed iniziare cos� un lungo, doloroso, ma provvidenziale esilio che per vent�anni lo condusse prima in Francia, poi in Inghilterra ed infine negli Stati Uniti d�America.
� nostra intenzione discutere delle ragioni etiche che sottendono le istituzioni politiche ed economiche, quali ad esempio il mercato e la concorrenza, proponendo l�opera di un importante interprete del pensiero sociale cristiano, facendolo dialogare con alcuni dei pi� rilevanti esponenti del liberalismo del novecento.
Una preziosa testimonianza a favore della nostra sfida ci viene offerta da Friederich August von Hayek. L�economista austriaco, nel ripercorrere le tappe salienti della lunga marcia del pensiero liberale nella storia dell�umanit�, sulla scia di Lord Acton, definisce l�Aquinate �il primo Whig� - il fondatore del partito della libert� � e, in ordine alla predisposizione di un�indagine sulle prime scuole politiche che formularono il principio del �rule of law� (governo della legge) e di autogoverno della comunit� � ovvero il progetto della societ� civile o il civic republicanism, caro ai Padri fondatori degli Stati Uniti d�America e fonte sostanziale del principio di sussidiariet�- (civitas sibi princeps), rimanda allo studio dei pensatori medievali Niccol� da Cusa e Bartolo da Sassoferrato: �Ma, sotto un certo aspetto la definizione di Lord Acton secondo cui il primo Whig sarebbe stato Tommaso d�Aquino non � poi cos� paradossale [...]. Uno studio pi� attento dovrebbe occuparsi soprattutto di Niccol� da Cusa e Bartolo da Sassoferrato che continuarono la tradizione nel XIII e nel XIV secolo�[2].
Quattro ragioni fondamentali
Una linea di demarcazione tra �liberalismo� e �liberalismo�
Prima di addentrarci nell�analisi di quelli che a nostro avvisto potrebbero rappresentare alcune ragioni fondamentali a sostegno della tesi in ordine alla moralit� della libera economia di mercato, soffermiamoci brevemente a riflettere sulla possibilit� di avviare un fecondo dibattito con quella componente del liberalismo che, rinunciando agli eccessi di razionalismo, utilitarismo e materialismo, ha evidenziato la contiguit� delle proprie posizioni con quelle tipiche del pensiero occidentale ed in particolar modo con la tradizione ebraico-cristiana. A tal proposito, � indispensabile sottolineare la profonda linea di demarcazione fra i due principali filoni del liberalismo moderno. Da un lato abbiamo la tradizione britannica che chiameremo del liberalismo classico: empirica, asistematica ed antiutopistica, ricollegabile alla corrente politica inglese old whig, alla filosofia morale inglese e scozzese del xviii secolo e a quella americana, nella particolare versione del Federalist, che attribuisce all�ordine spontaneo della societ� civile la difesa e la promozione della libert�: �L�esperienza deve essere la nostra sola guida. La ragione potrebbe sviarci. Non fu la ragione a scoprire il singolare e ammirevole meccanismo della Costituzione inglese. Non fu la ragione a scoprire [...] l�insolita (e agli occhi di quanti sono governati dalla ragione, assurda) usanza del processo in presenza di una giuria. Probabilmente il caso ha favorito queste scoperte, che l�esperienza ha sancito. Questa dunque sia la nostra guida�[3]. Dall�altro abbiamo la tradizione continentale, in particolar modo francese: razionalista, utilitarista e materialista che riconosce una rilevante funzione progettuale al potere pubblico[4]. Volendo operare una distinzione abbastanza netta, e necessariamente non comprensiva di tante eccezioni, dovremmo considerare i due filoni relativamente puri, cos� come apparivano nel xviii secolo. Quello cosiddetto �britannico�, rappresentato in special modo dai filosofi moralisti scozzesi quali David Hume, Adam Smith e Adam Ferguson, ma anche dai francesi Montesquieu e Tocqueville, nonch� dai loro contemporanei inglesi Josiah Tucker, Edmund Burke e William Paley, i quali attingevano alla consolidata tradizione della common law. Sul versante opposto abbiamo la tradizione dell�illuminismo francese, impregnato di razionalismo cartesiano ed idealmente guidato dagli enciclopedisti, dai fisiocratici, da Rousseau, da Condorcet. Le differenze sono state ben individuate dal Talmon, il quale, affrontando lo studio delle origini della �democrazia totalitaria�, cos� riassumeva le due versioni del liberalismo moderno: �Uno trova l�essenza della libert� nella spontaneit� e nell�assenza della coercizione, l�altro crede che la libert� possa esser realizzata solo perseguendo e raggiungendo una finalit� di collettivismo assoluto [...] uno sostiene lo sviluppo organico, lento e semicosciente, l�altro la deliberazione dottrinaria; uno vuole adottare una procedura di esperimenti e di errori, l�altro esclusivamente un modello valido�[5].
Verso un nuovo incontro
Il punto di partenza dal quale avviare tale discussione ci sembra ben sintetizzato da un passaggio chiave del discorso inaugurale tenuto dal Premio Nobel per l�economia Hayek, in occasione del primo meeting della Mont Pel�rin Society, svoltosi nel 1947. Hayek, contestando la tendenza a voler perpetuare il contrasto tra chi difende la libert� su basi secolari e chi invece difende la stessa in ragione di argomenti religiosi, affermava con forza che �Questo liberalismo intollerante ed aggressivo � il principale responsabile dell�abisso che, particolarmente in Europa, ha portato molto spesso le persone religiose ad allontanarsi dal movimento liberale [...]. Sono convinto che, a meno che non si riesca ad abbattere questo muro che divide il liberalismo dalla religione, sia impossibile sperare in una rinascita delle forze liberali. Molti segnali, molti indizi lasciano pensare che in Europa una simile riconciliazione sia oggi pi� vicina rispetto al passato, e che molti vedano in essa l�unica speranza di sopravvivenza degli ideali della civilt� occidentale. � per questo motivo che mi sembrava cos� importante riservare ai rapporti tra liberalismo e cristianesimo una sessione specifica dei lavori del nostro incontro�[6].
Il personalismo metodologico
Persona: individuo e comunit�
La prima ragione che ci consente di argomentare l�eticit� di un sistema economico basato sul libero mercato � dato dall�individualismo metodologico, ovvero dal personalismo metodologico[7]. In base a tale interpretazione dei fenomeni politici, economici e culturali, le istituzioni sociali sono giudicate come il risultato inintenzionale di azioni intenzionali, poste in essere da soggetti che si prefiggono lo scopo di migliorare la propria esistenza, utilizzando gli strumenti a disposizione, nell�umana condizione di limitatezza e fallibilit�[8]. Scrive a tal proposito Carl Menger, uno dei padri della Scuola austriaca: �tutti questi istituti sociali [il diritto, la religione, lo Stato, il mercato, le citt�, il linguaggio] sono, nelle loro varie forme fenomeniche e nelle loro incessanti mutazioni, in non piccola parte il prodotto spontaneo dell�evoluzione sociale; i prezzi dei beni, il saggio dell�interesse, la rendita fondiaria, i salari e mille fenomeni della vita sociale e dell�economia in particolare mostrano esattamente la stessa peculiarit�[9]. Con ci� intendiamo affermare che il mercato, sebbene sia un ordine spontaneo, non � un dato naturale, bens� un prodotto dell�agire umano; anche se un prodotto molto complesso. Il libero mercato, dunque, a partire dall'interpretazione data dell'individualismo metodologico, si presenta come il frutto non intenzionale di azioni poste in essere da persone capaci di riflessione e di scelta, la cui autonomia e libert� consentono loro di agire avendo come obiettivo il perseguimento dei propri fini (non necessariamente egoistici); in definitiva, il legato pi� prezioso che la civilt� occidentale (greca, romana e cristiana) ci ha lasciato in eredit�[10].
In che modo l�antropologia cristiana pu� stabilire un punto di contatto con l�individualismo metodologico, almeno nella sua versione austriaca?[11] A tal proposito crediamo che la riflessione di Luigi Sturzo ci possa aiutare a cogliere la sostanza delle questioni che andremo via via elaborando, offrendoci un�inestimabile fonte di riflessioni e di idee.
Quanto al tema della libert� individuale, che si intreccia inevitabilmente con il personalismo metodologico, crediamo che essa possa essere meglio compresa se assumiamo come chiave di lettura il riferimento antropologico: il carattere centrale, unitario e trascendente della persona umana. Caratteristica peculiare del personalismo sturziano � il mettere instancabilmente in evidenzia i rischi ai quali andrebbero incontro le democrazie moderne qualora perdessero di vista il carattere unitario della vita personale ed il suo orizzonte etico, descritto dal nostro autore come �la tendenza di ciascuno a fare se stesso centro della propria attivit� interiore ed esterna, ad espandersi, a realizzare s� e le proprie facolt�, a cercare in s� e fuori quel che risponde ai suoi bisogni, alle sue aspirazioni, alla vita�[12].
Al centro del personalismo metodologico c�� la profonda convinzione circa il primato della persona sulla societ�[13], la quale � sempre mezzo e mai fine, poich� il fine � l�uomo. Nella prospettiva sturziana, inoltre, la societ� appare come una �proiezione multipla, simultanea e continua di individui considerati nella loro attivit��[14]. L�uso del termine �proiezione� ci appare particolarmente interessante poich� indica un elemento di continuit� e di relazione - e non di separazione - tra i due soggetti, al punto che riteniamo di poter affermare che la societ�, in quanto �proiezione� della libera, responsabile e creativa azione umana, presenti le stesse caratteristiche dei soggetti che con le loro azioni contribuiscono alla sua costituzione.
La dialettica di "reciprocit�"
Da un punto di vista squisitamente teologico, l�antropologia cristiana alla quale fa riferimento la dottrina sociale della Chiesa si fonda sul principio della trascendente dignit� della persona umana e sulla sua piena realizzazione attraverso l�incontro con l�altro, il vivere con l�altro e non contro l�altro. Il metodo di conoscenza che qui viene proposto - il personalismo metodologico - � l�attenta considerazione dell�intersoggettivit� - o reciprocit� - che ci consente di considerare l�individuo non nella sua separatezza rispetto agli altri. Al contrario, l�altro � la chiave attraverso la quale possiamo dischiudere lo scrigno prezioso e segreto che � in noi e scoprire l�immenso tesoro di cui Dio ci ha fatto dono: �L�uomo scopre compiutamente se stesso soltanto nella relazione con l�altro uomo. La scoperta di s�, l�autocoscienza, non � d�altro canto un accessorio, bens� un elemento integrante dell�autorealizzazione umana. La forma della realizzazione con l�altro contribuisce profondamente a determinare il successo e il fallimento dell�uomo nel compito di realizzare la propria essenza umana, che � per sua natura dinamica�[15]. In definitiva, tale metodo ci aiuta a comprendere da un lato l'essenza della persona - data dalla libert�, dalla responsabilit� e dalla creativit� - e, dall'altro, la relazione fra gli individui ed il loro essere l�uno per l�altro, il loro costituirsi ed acquistare piena coscienza di s� nella relazione con l�altro. Fra le relazioni umane, il rapporto Padre-Figlio � per eccellenza quello in cui l�affermazione della propria dignit� � legata alla affermazione e non alla negazione della dignit� dell�altro: il padre � padre nel figlio e attraverso il figlio. � il figlio che gli rivela quella particolare e decisiva profondit� del suo essere personale che consiste nell�essere padre. Al tempo stesso il figlio � figlio per il padre e attraverso il padre; questi non solo gli rivela la profondit� ed il significato dell�essere personale in generale, ma (addirittura) lo fa essere, lo costituisce nell�essere[16]. La dialettica Padre-Figlio (o di "reciprocit�") si colloca agli antipodi di quella antropologia sociale che ha come principio ermeneutico fondamentale la dialettica hegeliana servo-padrone. La lotta fra i due soggetti, oltre a costituire l�idea base della nozione di giustizia sociale, rappresenta un�interpretazione complessiva della situazione dell�uomo nel cosmo che si contrappone a quella che S.Tommaso, riprendendo da Aristotele, chiamava un�originale amicitia politica che sta a fondamento del vivere insieme nella citt�, e implica un reciproco aiuto nella realizzazione del bene comune. La dialettica Padre-Figlio, al contrario, ci consente di guardare l�uomo non solo in generale, ma anche e soprattutto nel momento della relazione con gli altri uomini: essa sviluppa la proposizione agire con gli altri, e ci aiuta a comprendere il momento stesso in cui nasce e si costituisce una societ�.
Le implicazioni economiche della succinta riflessione antropologico-teologica sono sotto gli occhi di tutti. Sul versante della scienza economica, quanto meno sul versante del paradigma dominante, quello neoclassico, il mercato � un "luogo", uno "spazio" da suddividere, e i concorrenti dei price-takers ai quali non � attribuita alcuna reale capacit� di agire: essi reagiscono in modo prevedibile, come automi programmati per massimizzare la propria funzione di utilit�. Lo scarto tra il rigore formalistico della scienza economica e l�esigenza di pensare a modelli adeguati alla reale capacit� umana di agire e di contraddire le ferree �leggi� dell�homo oeconomicus[17], ci impone un�attenta riflessione sull�autentico dinamismo dei processi di mercato e il rigetto di una visione statica, �spaziale�, del modo in cui gli operatori economici agirebbero in un mondo perfetto, caratterizzato da quella che Mises definiva "un'economia perfettamente rotante". Se supponiamo che il mercato sia un luogo, un�entit� spaziale da suddividere, dovremmo ammettere che i pi� spregiudicati ricorreranno al darwinismo sociale e penseranno che � naturale che i pi� forti si accaparrino porzioni maggiori di spazio competitivo, mentre i fautori della business ethics sosterranno che per il bene della comunit� � necessario che i pi� forti non esagerino e che lascino quote maggiori ai pi� deboli; altri ancora ricorreranno all'economia di Robin Hood. Ebbene, chi scrive ritiene che questa sia una trappola concettuale dalla quale fuggire. Il mercato, secondo il contributo offerto dagli autori della Scuola austriaca di economia, piuttosto che essere un �luogo� le cui quote andrebbero equamente suddivise con senso di giustizia e solidariet�, rappresenta un processo relazionale, � l'insieme delle relazioni mediante le quali ciascuno cerca di soddisfare i propri bisogni ricorrendo ai bisogni dell'altro: che il mercato si esprima mediante il baratto, la pecora, le conchiglie o la moneta, la logica che governa i processi di mercato non muta di una virgola[18]. In tal senso, l�individualismo metodologico, n